L'editoriale di ateatro 105
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro105.htm#105and1
I Marcido in mostra: 1986-2006
A Torino dal 2 febbraio
di Marco Isidori
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro105.htm#105and4
Spettacolo! Il Palcoscenico Elementare di Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa
In mostra a Torino dal 2 febbraio 2007
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro105.htm#105and5
Sulla natura teatrale del Test di Turing
In appendice a Valeria Patera, La mela di Alan. Hacking the Turing Test, Di Renzo, Roma, 2007
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro105.htm#105and9
Elogio del preservativo in forma di ballata ai tempi dell’aids
L’amore buono, il nuovo spettacolo africano di Marco Baliani, a cura di AMREF
di Andrea Balzola
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro105.htm#105and15
Tra teatro e pedagogia
Il progetto "Teatro in visita"
di Clara Gebbia
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro105.htm#105and20
Della Rivoluzione di uno stabile
A proposito di Prato
di Emanuele Nespeca
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro105.htm#105and33
L'inventore di Arlecchino
Siro Ferrone racconta Tristano Martinelli
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro105.htm#105and40
Naira González: autoriratto dell'attrice da giovane
Il saggio di Editoria&Spettacolo
di Fernando Marchiori
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro105.htm#105and41
Il taccuino di un'attrice in cerca della sua voce
Pietre d'acqua di Julia Varley, Ubulibri, Milano, 2006
di Fernando Marchiori
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro105.htm#105and43
La Hollywood della Brianza, naturalmente
Digital reality a Busto Arsizio
di Perfida de Perfidis
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro105.htm#105and47
Amleto giù per u-tube
to tube or not to tube?
di Anna Maria Monteverdi
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro105.htm#105and51
Il teatro del futuro, il teatro della nostalgia
Grazia Toderi - Rosso Babele al PAC di Milano
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro105.htm#105and52
Totopoltrone news ETI, Teatro di Roma, Metastasio, Mercadante...
Con qualche soffiata di Perfida de Perfidis
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro105.htm#105and70
Ultimissima Totopoltrone Prato
Manifesto per il migliore dei Teatri possibili
di Attori, registi, drammaturghi coinvolti nell’attività culturale della città di Prato e della Regione Toscana
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro105.htm#105and71
"Hystrio" 1/07 Speciale Canada
Il sommario
di Hystrio
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro105.htm#105and73
Bando per la rassegna NUOVE ESPRESSIONI TEATRALI
Uno spazio per giovani compagnie
di Associazione Terre d'Acqua
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro105.htm#105and74
Dalla Compagnia di San Paolo oltre 3 milioni di euro per lo spettacolo in Piemonte e Valle d'Aosta
Verranno distribuiti tra 100 rassegne e stagioni
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro105.htm#105and75
La scomparsa di Gianni Toti
Poeta e videoartista
di Un gruppo di amici
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro105.htm#105and78
ateatro105 così perverso così polimorfo
L'editoriale di ateatro 105
di Redazione ateatro
Siamo molto fieri di questo ateatro105, perché potremmo trovarci ispirazione per diversi logo-banner della nostra webizne.
Per esempio la vera e propria visione del teatro, bella e straniante, insieme ironica e profetica, che offre Grazia Toderi in Scala Nera: un teatro che diventa esso stesso oggetto da guardare, gli ordini di palchi che si trasformano nei bracci di una galassia che ruota nel vuoto, il destino che diventa insieme attesa dell’evento ed eterno ritorno del loop, un occhio nero che ti guarda...
Potremmo invece utilizzare uno dei geniali sipari - vere e proprie Maschere di Dioniso - disegnati da Daniela Dal Cin nei suoi vent’anni di invenzioni per Marcido Marcidorjs, in mostra a Torino dal 2 febbraio (e questo numero della webizne presenta in anteprima il saggio che apre il catalogo)...
Oppure potremmo recuperare l’HamLego - sì, avete capito bene: un Amleto fatto con i mattoncini colorati in passo uno - che ha scovato Anna Maria Monteverdi girovagando su YouTube, dove il Pallido Prence riappare in versioni assolutamente imprevedibili (e Ofelia somiglia in maniera sospetta a Christina Aguilera)...
Se invece vogliamo restare nella tradizione, ci sarebbe l’Amleto-Martinelli che Siro Ferrone ha messo sulla copertina della sua biografia dell’attore mantovano: in mano tiene un promettente cazzo-scettro-mondo. (A proposito di Arlecchino, la nostra Perfida de Perfidis aveva raccontato il suo naufragio un anno fa, in ateatro 94: di recente la storia l’ha ripresa "Diario"). Ma se preferite le attrici, Fernando Marchiori racconta anche di Julia Varley e Naira Gonzales, in questo ateatro105...
Ma stavamo parlando di perversioni! Non potevamo non occuparci della più sublime di tutte, la bontà: Andrea Balzola è andato a vedere il suo nuovo spettacolo che Marco Baliani ha realizzato con i bambini di strada del Kenia, L’amore buono. E anche questo, forse, potrebbe diventare un logo ateatroso...
Ancora, potremmo scegliere come santo protettore Alan Turing, inventore del computer e del celebre test che porta il suo nome: lo scienziato inglese è diventato protagonista del testo di Valeria Patera, obbligando Oliviero Ponte di Pino a una riflessione sul rapporto tra teatro e scienza, identità e computer, che è finito in appendice al testo (a proposito, Oliviero, è inutile che ti arrabbi se nei forum la gente sceglie l’anonimato: lo sai benissimo il perché, ha spiegato anche lì...)
Ma non c’è solo questo nel nostro grasso 105, se volete scoprire altre sorprese basta cliccare e curiosare...
I Marcido in mostra: 1986-2006
A Torino dal 2 febbraio
di Marco Isidori
La stagione teatrale 2006-2007 segna il ventesimo anno dalla fondazione della
Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa.
Per celebrare questa ricorrenza la compagnia allestirà una grande esposizione alla Promotrice delle Belle Arti di Torino: “I MARCIDO IN MOSTRA: 1986-2006”, in collaborazione con la Città di Torino, la Regione Piemonte, il Teatro Stabile di Torino e il Sistema Teatro Torino: un’occasione per ripercorrere i venti anni di attività attraverso le macchine sceniche, gli oggetti e i costumi, bozzetti e maquettes, documenti e materiale grafico.
Nello spazio insolito della prestigiosa galleria che ospiterà, montate e visitabili, tutte le strutture scenografiche realizzate dalla compagnia, sono programmati quattro eventi spettacolari, tra cui la ripresa di BERSAGLIO SU MOLLY BLOOM dall'Ulisse di Joyce (Premio Ubu 2003 per la scenografia) e il riallestimento di HAPPY DAYS IN MARCIDO’S FIELD da Samuel Beckett.
Oltre agli eventi spettacolari, è prevista un’intensa serie di attività didattiche con visite guidate e rappresentazioni rivolte alle scuole, realizzate nell’ambito della stagione Marcido/Ragazzi 2006/2007, con il sostegno della Compagnia di San Paolo e il contributo della Fondazione CRT di Torino.
La mostra sarà inaugurata venerdì 2 febbraio 2007 alle ore 19,30 con lo spettacolo MARCIDO: CANZONETTE. CANZONETTE MARCIDO!
Sede: Promotrice delle Belle Arti
via Balsamo Crivelli, 11 (Parco del Valentino) - Torino
dal 3 al 18 febbraio (h. 10-13 / 15-19)
Ingresso alla mostra: intero Euro 5,00 – ridotto Euro 3,00
Calendario delle rappresentazioni
MARCIDO: CANZONETTE. CANZONETTE MARCIDO! - venerdì 2, ore 20,30
BERSAGLIO SU MOLLY BLOOM – mercoledì 7, ore 10,30 e 20,30
RITRATTI DA WILLIAM SHAKESPEARE – mercoledì 14, ore 9,30 e 11
HAPPY DAYS IN MARCIDO’S FIELD – sabato 17 e dom. 18, ore 20,30
Per informazioni:
Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa 011.819 35 22 – 011.436 87 30
www.marcidomarcidorjs.org
MARCIDO IN MOSTRA: 1986 / 2006
Vent'anni di lavoro hanno definito con sufficiente chiarezza quel che i Marcido intendessero, quando, neonati, fantasticavano attorno all'idea di una costruzione dello spazio scenico che non fosse mai, né soltanto "scenografia", né, tantomeno, si trattasse di quel vago assortimento multimedialoide, che determina sovente l'inconsistenza propositiva dell'avanguardia peggio aggettivabile.
Noi pretendevamo per i nostri spettacoli il Mondo Ricostituito.
La mostra di cui si sta parlando è l'esposizione di questo tal universo riprogettato per contenere e far pulsare il cuore drammaturgico dell'avventura di quei teatranti che si chiamarono, che si vollero beffardamente battezzar Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa.
Non sarebbe stato possibile rappresentarci in Fedra, Pinocchio, Sirenetta, Genet, Eschilo, Beckett e con quant'altra commedia commerciammo cercando d'esplicare la nostra tendenza ad una mediazione anche forzata tra demoni e dei, se non proprio inscenandola a tavoletta, questa commedia che desiderammo precisamente puntualmente e totalmente "altra", dentro a quelle gabbie di tensione architettonico/magnetica (sì, magnetica, certo!) che poi in effetti (speciali nell'etimo sempre, gli effetti Marcido!) contennero davvero gli spettacoli, e che ora qui, mentre si mostrano in tutta la loro pura determinazione iconica, ci vanno anche mostrando, nello stesso tempo, quanto singolare e temerario sia stato e tutt'ora continui ad esserlo, il percorso teatrale seguito dalla compagnia.
L'arte, quando c'è, obbliga le soluzioni col pretendere l'assoluta coerenza del momento drammatico con lo spazio fisico in cui questo diverrà teatro.
Concezione sacra, fuorimoda, ma si tratta di una concezione che rivendichiamo interamente quale indiscutibile segno politico capace di ridare ai termini oggi slabbrati della comunicazione scenica, quella necessità storica e quella parzialità etica, che ci paiono andar via via, sempre più smarrendosi, nella terrifica attuale coazione dei tempi di una spettacolarità mediana senz'anima alcuna.
Marco Isidori
Spettacolo! Il Palcoscenico Elementare di Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa
In mostra a Torino dal 2 febbraio 2007
di Oliviero Ponte di Pino
Questo testo verrà pubblicato nel catalogo di I Marcido in mostra: 1986-2006
Una sera di luglio al Festival di Santarcangelo. Sotto i portici di piazza Ganganelli mi viene incontro un ragazzo massiccio, un po’ tozzo, un lampo scuro negli occhi. Non l’ho mai visto, non si presenta, mi aggredisce: “Sono sicuro che ti è piaciuto moltissimo!”. Naturalmente gli rispondo di no. Se è tanto sicuro, che bisogno ha di chiedermelo? E poi quello è di sicuro un fanatico.
Lui resta lì impalato, continua a guardarmi, non so se è sorpreso o arrabbiato. Non dice più nulla e io riprendo a camminare. Passo accanto a una ragazza pallida e minuta, con gli occhi grigi e i capelli chiari. Lo seguiva un passo indietro, come un soldatino, un po’ rigida, e ora sembra preoccupata. Forse avrei dovuto chiedere scusa, sono stato proprio maleducato.
Sono passati vent’anni. Quello che – sicuro – mi aveva incuriosito era un esordio, si intitolava Studio per le Serve. Da allora non ho smesso di seguire il lavoro di Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa.
È un gruppo che – sicuro – mi piace moltissimo, perché inventa spettacoli sempre un po’ strani. Anzi, molto strani, se giudicati con gli standard della routine teatrale. Perché sono opera – sicuro – di due fanatici. Perché sono lavori belli e intelligenti, pieni di energia. E perché, anno dopo anno, mi continuano a lavorare nella memoria.

Marco Isidori è Macbeth e Lady Macbeth.
Lui è Marco Isidori, il coté barocco, decadente ed enfatico che corrisponde a Marcido Marcidorjs, lei è Daniela Dal Cin, l’anima in apparenza fragile ma determinata, nonché dolcemente surreale, di Famosa Mimosa.

Maria Luisa Abate protagonista di Happy Days in Marcido’s Field.
Alla coppia bisogna aggiungere almeno la suprema primattrice della compagnia, Maria Luisa “The Voice” Abate, presenza costante e imprescindibile come la fedele Sabina, e poi l’immancabile Coro dei Marcido...
Al palcoscenico arrivano tardi (Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa nasce nel 1984, quando Marco e Daniela hanno superato la trentina), per vie oblique e oscure, quando i gruppi della “seconda onda” del Nuovo teatro italiano sono già esplosi. Così dal punto di vista critico i Marcido rimarranno, come le Albe a Ravenna, un po’ schiacciati tra chi è emerso allo snodo tra i Settanta e gli Ottanta e la “terza onda” dei Teatri 90 (anche di qui la ritornante polemica dell’Isidori contro i critici).
Il gruppo ha sede a Torino, dove spesso officia in teatrini-appartamento, in teatri-bomboniera in cima ad antichi palazzi, in teatracci di periferia... Spesso i due leader si ritirano a meditare e lavorare tra i monti della Val Varaita o a San Benedetto del Tronto, in riva all’Adriatico.
Lui è prima di tutto poeta, e ribadirà più volte la sua fede ambigua nella Parola:
I cardini della nostra ricerca sono sempre stati la Parola, il Verbo, il Significato, la Significazione: tutto secondo me è racchiuso nella Parola.
(Marco Isidori, intervista di Christopher Cepernich, “Corriere dell’Arte”, 22 giugno 1996)
Lei nasce invece pittrice. Ogni tanto li incontro, a Torino, a Milano o chissà dove, e facciamo quattro chiacchiere. Anno dopo anno, gli ho ripetuto di tenere duro anche se i loro spettacoli giravano poco e la critica latitava, che erano bravi anche se non capivo tutto, e dunque di non preoccuparsi troppo se il loro lavoro non lo capiva quasi nessuno.
Ho scoperto che Daniela Dal Cin – più spesso delegata alle missioni diplomatiche – ha una voce levigata come i ciottoli che si trovano sui greti dei fiumi. Spesso parla con un volume qualche decibel più alto del giusto e per questo, quando ci incontriamo nei bar vicino alle stazioni, gli altri avventori ci guardano un po’ strano. Lui invece ha sempre quel modo brusco, i gesti e la voce che ogni tanto hanno come uno strappo. È sempre molto sicuro di quello che dice, come se fosse una questione di vita o di morte, e capisci che è meglio non contraddirlo troppo, altrimenti si potrebbe infuriare. Infatti quando discutiamo cerco di non contraddirlo troppo: lui e Daniela si fidano un po’di me (ulteriore aggravante, per quei due...), e per fortuna Marco non si arrabbia nemmeno se lo prendo un po’ in giro. Anzi, ogni tanto esplode in una gran risata, anche se a volte non capisco bene il motivo: e allora quella bocca che gli taglia la faccia si spalanca, ed è insieme dolce e crudele. Naturalmente quando ride così nei bar gli altri avventori ci guardano un po’ strano, ma non me ne importa niente.
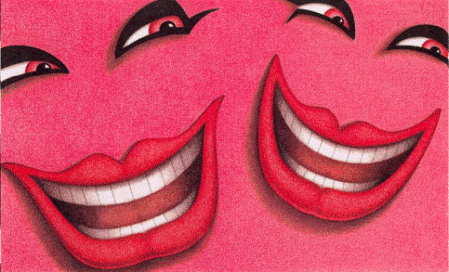
Il sipario della Locandiera.
Non esiste in Italia chi abbia un’idea di teatro forte, coerente e ostinata come Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa. E che l’abbia praticata con tanta forza, coerenza, ostinazione e disciplina per decenni, nell’arco di una ventina di spettacoli, contro tutto e tutti. Una coerenza, va aggiunto, che non è mai monotona, perché vi fiorisce rigogliosa la “pianta del barocco” e dunque è sempre colorata, inventiva, sorprendente. E insieme ossessiva e feroce: loro dicono che è “protetta solo dallo scudo fatato del suo gentile anacronismo”, e dunque la difendono con una verve polemica lucida e acuminata.
Perché – e anche questo è notevole – questa idea di teatro non si è mai evoluta, almeno nelle sue linee portanti: è sempre rimasta la stessa, matura e definitiva fin dagli esordi, come risulta evidente dalle quattro “comunicazioni” inaugurali, redatte nel 1984 da Marco Isidori mentre lavorava alle Serve. In fondo i Marcido hanno sempre fatto la stessa cosa: “Siamo andati a caccia del Palcoscenico Elementare!”, come proclama l’Isi nelle note di regia del suo Pinocchio.
È chiaro, ci sono state variazioni sul tema, diverse combinazioni degli ingredienti, e dunque un costante gusto della sperimentazione e della sorpresa, un affinamento di certe tecniche, e a volte – ma molto di rado – qualche soldo in più da investire nella produzione. Ma quello che colpisce è la costanza, l’ostinato ardore del duo e l’entusiasmo che riescono a trasmettere ai loro allievi, sempre nuovi (si intuisce che non è facile restare a lungo in compagnia: pochi soldi e una disciplina troppo dura, una dedizione al teatro che può sfociare in un moralismo fondamentalista...).
Ancora più sorprendente è un altro dato: in fondo la poetica del gruppo è basata su un principio molto semplice, che dovrebbe essere alla base di ogni opera spettacolare. Ma i Marcido lo spingono alle conseguenze più radicali, estreme (o meglio logiche), e così sembra che gli altri si limitino a enunciarlo, quel principio così chiaro e importante, senza tradurlo davvero in pratica.
Qui è la radice profonda del Teatro, l’origine della sua stessa specificità estetica: il carattere unitario di tutto quanto in esso concorre alla costruzione drammatica, la pertinenza di acconciature e costumi, della recitazione, della scenografia e della musica, pertinenza propria dell’atto liturgico che non consente alcunché di interscambiabile.
(Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa, Una giostra: l’Agamennone, Edizioni del Noce, Camposampietro, 1991, p. 3)
Il principio fondamentale, il primo postulato del Teatro Elementare dei Marcido, è dunque banale: i diversi elementi costitutivi dell’evento spettacolare – gli attori e i loro corpi, le scene, gli addobbi e i costumi, le luci e le ombre, la voce e la musica, le parole, i gesti, il respiro e il canto, e naturalmente anche gli spettatori – fanno parte di un tutto unico, una macchina-corpo dai molteplici organi. I punti di riferimento sono quelli della grande tradizione delle avanguardie del Novecento, primo tra tutti “A. A. (...) l’animo furioso di Antonino”. E poi
una valanga di molti bei nomi d’epoca: dal grande Craig, al gesuino Grotowski, dal tonante Mejerchol’d, al malinconico Appia, e profondendosi via via fino all’ultimo bagliore che soffiò Carmelo sullo sguardo del mondo qualche lustro addietro.
(dal programma di sala di Happy Days in Marcido’s Field)
Siamo insomma nel gran fiume del teatro come opera d’arte totale: ma in questo caso praticata con una coerenza d’acciaio, ispirata da una fiammeggiante fede nel teatro e nelle sue capacità di fascinazione e trasformazione. Con la consapevolezza che solo la pratica teatrale – più precisamente “le modalità con le quali tratteremo ‘l’attore’” – può davvero liberare la scienza di quei “Nomoni (...) inscatolata nei libri!” (dal programma di sala di Happy Days in Marcido’s Field). Evitando naturalmente di cercar “scampo o facile approdo nella gran carosellata dei ludi sommatori” (dal programma di sala del Cielo in una stanza). Insomma, si cerca un’unità organica, essenziale.
Questa visione del teatro spazza subito via ogni idea di rappresentazione: la Marcido, lontanissima da ogni realismo, per non abortire nel “verosimile immondo” cancella introspezione e psicologia privilegiando azione e gesto. Trascura la mimesi e cerca la catarsi. Questo postulato antinaturalistico è subito sancito da una delle due citazioni poste in esergo alla inaugurale “Prima comunicazione per Le serve” (1984), rubata a un maestro di esacerbata teatralità:
Senza sapere di preciso che cosa sia il teatro, so quel che gli nego d’essere: la descrizione di gesti quotidiani vista dall’esterno.
(Jean Genet)
In secondo luogo la fusione di elementi e corpi diversi, animati e inanimati, porta con sé una potente tensione erotica, o meglio erotizza corpi, oggetti e organi (e qui il punto di riferimento teorico potrebbe essere il “corpo senza organi” di Artaud riletto da Deleuze e Guattari). La riemersione del dionisiaco passa anche da qui, attraverso la creazione di un inquietante codice pornografico, di un perturbante alfabeto sadomaso, di una regola orgiastica.
Nei confronti dei testi, il “metodo Marcido” prevede una personale forma di appropriazione, spesso gioiosamente esplicitata nei sottotitoli: ci sono una Sirenetta di Andersen intrappolata “nel gioco della Marcido” e una Locandiera che negli stessi Marcido “inciampa”, un Isi (alias Marco Isidori) che “fa Pinocchio” (anche se desidererebbe “sfar lo Mondo”), Beckett che si perde “in Marcido’s Field” e che poi ispirerà “Marcido’s Love”, una “solenne funzione del Prometeo incatenato di Eschilo”, un Macbeth “che l’Isi ha potuto leggere soltanto per come il suo strabismo glielo permise”, e ancora i Giganti pirandelliani senz’altro da “far nostri”.
Oggetto di queste appropriazioni – un programmatico e sistematico stupro – sono miti classici e moderni, dalle Serve omicide di Genet ai sanguinari Atridi dell’Orestea, dal dio ribelle Prometeo a Suzie Wong in quanto “monumento all’alterità la più direttamente conclamata”, da un fremente Macbeth ibridato con la sua Lady alla logorroica Winnie di Beckett, da Fedra a un’altra chiacchierona come Molly Bloom. Al fuoco teatrale si glorificano, cantano e bruciano gli eroi e soprattutto le eroine di un Olimpo della diversità, spesso ibridi e comunque con più d’una traccia del Mostro. Protagoniste sono dunque
combinazioni dell’energia fatale, (...) Loro (...), i Regali, le celebrità affermatesi per esser vispe scatenatrici della Grande Occasione Epifanica del Signor Dioniso.
(dal programma di sala di L’Isi fa Pinocchio)
L’Occasione Epifanica è naturalmente ciò che i Marcido cercano disperatamente ogni volta di resuscitare sul loro Palcoscenico Elementare.
Tra gli antecedenti di queste riscritture ci sono le sintesi futuriste, a partire dalla funzione dinamizzatrice evidenziata da titoli che evocano danze di guerra, giostre e vortici, party, tiri a segno (Bersaglio su Molly Bloom), perché
il mondo del Circo, dei divertimenti viaggianti e degli antichi stadi (...) sono, per noi, luoghi autentici dell’epifania dionisiaca.
(Una giostra, cit., p. 4)
Ma il modello sono soprattutto le folgoranti reinvenzioni di Carmelo Bene, con la loro capacità di decostruire i testi, di smontarne il senso e svuotare la stessa logica della rappresentazione; anche se – va aggiunto – i Marcido cercano di superare la dimensione dell’assolo a favore della coralità, e impostano un rapporto più complesso e articolato con il pubblico.
In effetti l’appiglio più semplice per penetrare la poetica dei Marcido è proprio la posizione dello spettatore nei loro corpi-macchina. Nello spettacolo d’esordio, lo Studio per le Serve, la scena è una sorta di cassaforte-armadio, una placenta-vagina foderata di stoffa rossa, metafora semplice ed esplicita sia in rapporto al testo di Genet sia nell’esemplificazione di una certa idea del teatro. Al pubblico è imposta la tradizionale posizione di osservatore della scatola scenica – con le ante dell’armadio a fungere sipario e quarta parete – ma questa funzione è per così dire iperdeterminata dalla metafora, ironicamente sottolineata, e insomma subito svuotata di senso.
L’incognita dello sguardo dello spettatore verrà poi risolta in diverse maniere, con ulteriori spostamenti. Nella tappa successiva la scatola-palcoscenico ingloba il pubblico, che diventa così anche elemento scenografico e drammaturgico di cui esplorare le diverse potenzialità (e in questi teatri-tempio s’avverte l’eco di certe invenzioni di Grotowski e Barba, ma filtrate e razionalizzate in macchinerie barocche di sapore ronconiano). Nelle Serve, una danza di guerra i venti-venticinque spettatori-voyeur vengono infatti sistemati sulla panca che corre tutto intorno a una struttura ovale di ferro e legno, chiusa o meglio sigillata da siparietti di stoffa rossa. I curiosi possono sbirciare all’interno solo attraverso una fenditura orizzontale alta una dozzina di centimetri che corre all’altezza dello sguardo. Lì dentro, in quell’arena claustrofobica, le serve assassine Claire e Solange danzano per questi occhi una guerra di crudele raffinatezza. Il pubblico si fa attivo protagonista, fin dagli esordi:
Sono gli sguardi del pubblico moltiplicati dalla geometria, a cingere l’azione, la loro presenza a ridosso della scena e di sé stessi, creerà nell’attore, una nervosità leggera, un sentirsi scrutato da occhi che scrutano, molto favorevole a portare nella recitazione quella lieve componente isterica, sufficiente, a “sospenderne” i gesti (Genet).
(Le serve, Prima comunicazione)
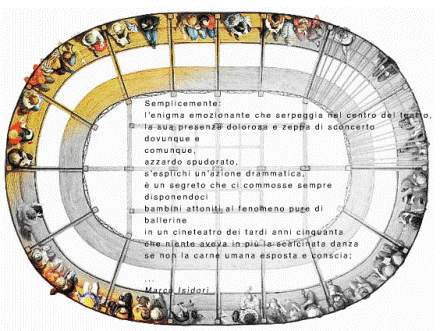
La scena di Una giostra: l’Agamennone.
Una giostra: l’Agamennone porta questo rapporto alla logica evoluzione: i settanta spettatori penetrano ora in una versione riveduta e ampliata di questo teatro-scenografia – l’ovale si è ingrandito fino a misurare una decina di metri sul lato maggiore – e siedono addossati alla parete della Reggia degli Atridi. In un’acrobatica coreografia tridimensionale, gli attori esplorano lo spazio, ne percorrono le linee di forza, circondano e aggrediscono il pubblico da ogni lato (sembra un sogno di Mejerchol’d fatto realtà).
Il meccanismo del coinvolgimento può farsi ancora più radicale. Il cielo in una stanza ha un unico spettatore: dove “unico” vuol dire certo privilegiato, ma forse anche ultimo della specie; o meglio un esemplare di laboratorio su cui verificare, con sana e ingenua radicalità, l’efficacia della comunicazione teatrale. Lo spettatore-cavia si ritrova chiuso in un appartamento, in balia di dieci attori. A un certo punto diventa addirittura Gengis Kahn e gli tocca sedere in groppa a una tigre di nome Ma (in realtà due attori-portatori nascosti sotto il coloratissimo mantello dell’animale) che lo scorazza di qua e di là nella stanza: come in un folle rodeo, deve addirittura domare la belva dell’immaginario.

La Torre del Teatro Rosso.
Al vertice della megalomania scenografica di Daniela Dal Cin si pone (per ora) la Torre del Teatro Rosso, pensata nel 1993 per un Gengis Kahn mai realizzato (vedi Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa. disegni, costumi, scenari, con introduzione di Franco Quadri, catalogo della mostra, Torino, Piemonte artistico e culturale, 4-21 aprile 1996). La Torre, edificata un decennio dopo per il Vortice del Macbeth, è un impressionante cubo di nove metri di lato, dove la funzione di sipario è affidata alla superficie esterna (tre anni di lavoro per 27 grandi tele), interamente percorsa da una rossa decorazione di carattere esplosivamente erotico, un corteo danzante di corpi nudi impegnati in amplessi d’ogni sorta, un trionfo di satiri e menadi infoiati, di centauri e ninfe che esibiscono i genitali, e coinvolgono persino gatti, cammelli, serpenti e coccodrilli in un folle e interminabile girotondo orgiastico punteggiato da demoni maliziosi e compiaciuti. Il pubblico – questa volta un’ottantina di testimoni-complici – penetra nella Torre salendo una passerella-ponte levatoio e si pigia su tre pareti, in due file serrate di panchette. La fortezza è un buco, il fallo si rivela vagina (per i Marcido il teatro non è mica una bocca, come teorizzava Richard Schechner...). Gli attori – a cominciare da un Marco Isidori in sottoveste e scarponi, che è insieme Macbeth e la sua Lady – si muovono soprattutto al centro, in fondo al pozzo nero del teatro: gli spettatori li guardano dall’alto, ma spesso si ritrovano anche circondati e sovrastati dalle azioni dei coreuti-acrobati.
Inutile sottolineare la follia economica di queste imprese di carpenteria: ma i teatrini-Marcido – vere e proprie architetture, frutto anche dell’abilità artigianale di fabbri e falegnami – sono necessari altari sacrificali che arricchiscono il significato della parola “teatro” restituendogli il senso del rito.
Il pubblico può dunque essere inglobato nello spettacolo, ne fa sempre organicamente parte, a volte in maniera imbarazzante, superando il confine dell’intimità. Tuttavia non si creano mai confusioni di ruoli o superficiale coinvolgimento. Allo spettatore, masochisticamente inchiodato alla sua posizione, non si chiede di agire e interagire con gli attori, ma solo di essere uno sguardo – il più possibile acuto, e al limite voyeuristico.
Nel Palcoscenico Elementare dei Marcido attore e spettatore incarnano due poli, ovvero due ruoli distinti e individuabili. Nel riflettere su questa separazione, i sipari assumono un ruolo insieme funzionale e simbolico, grazie a una variantistica provocatoria e pedagogica, oltre che baroccamente sorprendente. I sipari condensano e tematizzano infatti la dialettica tra théatron e skené:
La prima rimanda all’atto del guardare, la seconda a quello del nascondere. Mettendole in relazione si dovrebbe concludere che teatro significa: sottrarre qualcosa allo sguardo.
(Fernando Mastropasqua, Teatro provincia dell’uomo, Edizioni Arti Grafiche “Federico Frediani”, Livorno, 2004)
In Una canzone d’amore c’è “un potente sipario di carta, vasto, teso, tirato a far da pancia sonora sulle costole di una struttura poligonale ad arco (Il Mondo! sì, il Mondo!)”, e nei disegni preparatori si precisa “raggio metri 2,5 altezza metri 4”: il “Gran Sipario di carta cinese” verrà naturalmente sfondato dalla “Pallaceppo” alla quale è incatenato Prometeo.
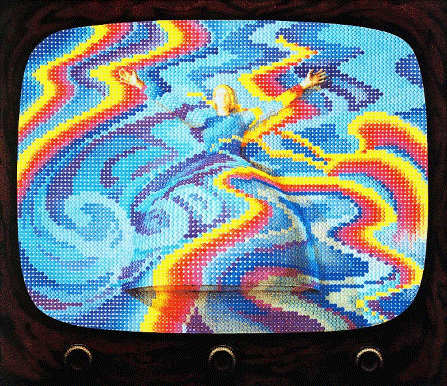
La scena di Palcoscenico ed Inno.
Per Palcoscenico ed Inno circa ventimila bottoni di seta colorata simulano in un maniacale arazzo i pixel di un monitor video, dentro una cornice-scatola-boccascena di falso legno con gli appositi pulsanti. Come in un quadro di Seurat, da quel fluttuare di punti, curve e sinuosità emerge una figura femminile, quasi crocifissa allo schermo: è la Sirenetta, pura immagine alla ricerca di un’anima, sospesa tra il fantastico mondo sottomarino e la realtà. Così il teatro gioca a scimmiottare, con l’ingenuo e maniacale illusionismo del bricoleur, l’attrazione dello schermo elettronico, ma risponde esaltando la terza dimensione, fino a chiamare in scena un grottesco, surreale e rotolante “uomo-palla”.
Attraverso il sipario, il gioco del gran teatro della meraviglia e della sorpresa si può rivelare ora seduttivo ora minaccioso. Happy Days in Marcido’s Field si presenta con una clamorosa cortina di corpi nudi, vivi e pulsanti a pochi centimetri dal pubblico: penzolano nel vuoto uno accanto all’altro, appesi per le braccia, a chiudere il boccascena prima di dar vita al coro che incarna Willie (che nell’originale beckettiano è il muto compagno di scena della loquacissima protagonista, e ora viene frantumato, moltiplicato e distribuito nell’ennesimo Coro Marcido). Ma la provocazione erotica può ribaltarsi in segnale di pericolo.

La locandina di A tutto tondo.
A tutto tondo si apre con un’immagine ancora più scioccante: la scena è una gabbia chiusa da una palizzata “che sfoggia conficcata al sommo una chiostra di ‘testine’ umane mummificate”: sono le repellenti teste mozze di chi si è avvicinato al mistero e non ha superato la prova. All’inizio dello spettacolo la grata cala verso il pubblico, a segnalare una zona di pericolo; poco dopo la sagoma del mansueto gorilla che s’intravedeva subito dietro viene smembrata per consentire l’apparizione della protagonista della serata, la sensuale e terribile Suzie Wong: quella lugubre palizzata-sipario dà accesso a
una vera e propria “Camera di Demenza”; un’alcova, sommata ad una gabbia, sommata ad una pista di circo; tutto, il tutto, attrezzato con sottopalchi, altalene, trabocchetti e un’infinità di gogne.
In Spettacolo c’è addirittura un sipario (detto “del Mostro”, come informa l’opportuna didascalia) che ribalta il senso della comunicazione teatrale e restituisce allo spettatore il suo sguardo: al centro di un ciclone azzurro di cieli, nubi e velocità, appare un occhio gigantesco che guarda minaccioso ma non vede (un altro occhio ugualmente inquietante e surreale, in forma di enorme scultura, campeggerà anche nel Prometeo, nella scena di Io e perciò sormontata da due enormi corni bovini. Si trovano altri occhi, in scena e nelle locandine, a testimoniare un rincorrersi coerente di riflessioni, temi e metafore – insomma il sedimentarsi d’un immaginario o di una mitologia).

Il programma di sala di Musica per una Fedra moderna.
Questi sipari, così come quei prototipi di teatro ovali o turriti, sono autentici capolavori. Così come lo sono molti dei costumi, delle acconciature e degli attrezzi disegnati e prodotti con artigiana pazienza da Daniela Dal Cin. Anche se, a ben guardare, è molto difficile scindere l’attore dalle scene e dagli oggetti di scena: spesso formano un tutto organico, attraverso protesi e cinghie, “appoggiature, altalene, cappi e trapezi (...) che noi s’eleggerà a praticabili” (e qui la memoria va al Sogno di una notte di mezza estate circense di Brook).
Quello dell’attore e della scena è un rapporto simbiotico, fin dal primo Studio per le Serve. Il costume di Madame diventa una raggiera di fili perlati a formare una rete che incatena l’attrice alla scena, “una meravigliosa trappola finale, un gioiello, ardito per concezione e splendore nero” (Le serve, Comunicazione numero due): l’attrice-ragno è prigioniera nella cassaforte-vagina, e al tempo stesso potenziale cacciatrice che seduce gli spettatori e la loro attenzione.
L’ambiguo meccanismo verrà spesso ripreso in seguito, lungo il sentiero ripetitivo della coazione nevrotica e quello sacrale del rito. Troverà altre apoteosi, a cominciare dalla Cassandra-ragno dell’Agamennone. In Spettacolo la ritualità della tragedia si ribalta in un esibizionismo vagamente sadomaso: la belva-protagonista Fedra, estranea e diversa fin dal suo primo apparire, viene ingabbiata in costumi scultorei, issata su alte pedane, esposta seminuda a mezz’aria con l’unico sostegno di un palo orizzontale, intrappolata da abiti e macchinari che la trasformano in un’icona in bilico tra ieraticità e feticismo; la sua declamazione è sempre enfatica, ricca di sottolineature ed eccessi, a volte strozzata, singhiozzante e gutturale, a volte melodrammaticamente intensa, ripiena e arrotondata. “È finita l’epoca dei mostri”, si lascia sfuggire la Nutrice: perché questa Fedra si rivela l’ultimo mostro che può infrangere le leggi dell’umanità, l’unica creatura ancora in grado di farsi travolgere dalla sua animalità e già pronta come un ibrido cyberpunk alla contaminazione con la macchina. Dunque è creatura intrinsecamente teatrale, attraente e repellente, irrimediabilmente diversa, ultimo residuo di un passato cancellato dall’avvento dell’Io e delle sue miserie, e insieme anticipazione di una spettacolarità inquietante e scandalosa.

Happy Days in Marcido's Field.
In Happy Days in Marcido’s Field la protagonista resta incastonata per tutto lo spettacolo come un’ape regina al vertice d’una piramide di legno, che reinventa il monticello di sabbia immaginato da Beckett. Questa gabbia-trono occupa l’intero palcoscenico: quando si scioglie il sipario di corpi nudi che la nasconde alla platea, al sommo vi appare Winnie, bloccata e quasi infilzata sulla cima di queste travi, la pelle arrossata e annerita dal fuoco, come scorticata e sanguinolenta, in un sacrificio erotico alla Bataille. Sotto un’enorme ma ingrigita parrucca anni Sessanta, inguainata in un bustino decorato di rose, Winnie sferza con il suo stravolto monologo il monte di nudità che nel frattempo si sono avvinghiate allo scheletro ligneo, come in un affresco dell’Inferno; e sferza gli spettatori, nei loro abiti “civili”: come se per avere il “teatro” e catturare lo spettatore (e non solo il suo sguardo) fosse necessario prima questo denudamento, e poi andare ancora oltre, fino alla carne viva.
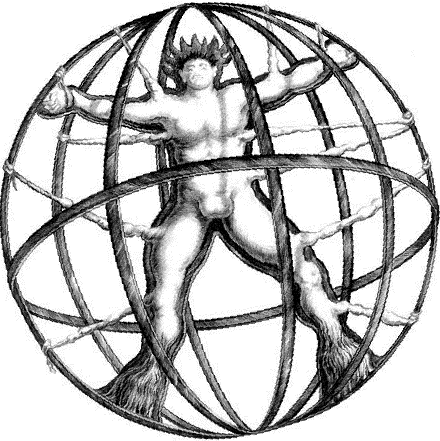
La “Palla che recita” di Una canzone d’amore.
In Una canzone d’amore Prometeo, il dio che ha liberato per gli uomini le forze della natura – il fuoco – si ritrova imbragato al centro di una gigantesca sfera di ferro, quasi a parodia del celeberrimo uomo vitruviano disegnato da Leonardo, inchiodato alla propria abnorme individualità. Intorno a questa gabbia-prigione si erge in forma di cornice un arco, sempre di ferro, largo nove metri e alto sei, che indica un ulteriore orizzonte, quello del boccascena-Mondo. Per tutto lo spettacolo Prometeo-Isidori, “Corpo Magico, insieme metallico ed umano”, verrà sballottato e centrifugato, autentica “Palla che recita” sospinta per la scena in un folle inesausto giravoltare, con l’attore costretto a declamare faticosamente e innaturalmente il testo in ogni posizione, sospeso nel vuoto con varie inclinazioni e spesso a gambe all’aria.
La scena diventa un ambiguo teatrino sadomasochistico a cui l’attore si fa legare per il piacere voyeuristico di chi lo guarda (peraltro analogamente inchiodato al suo posto e ruolo, come s’è visto), e che naturalmente diventa l’oggetto da sedurre. In un lavoro per certi aspetti minore, La locandiera, si fa esplicito il rimando a Kleist e Craig: per tutto lo spettacolo gli attori agiscono come marionette mosse da fili ben evidenti, in un abnorme teatrino per bambini.

La Grande Conchiglia di Bersaglio su Molly Bloom.
La strepitosa scenografia di Bersaglio su Molly Bloom moltiplica il meccanismo sadomasochistico della legatura su un’enorme struttura-sipario in ferro, illuminata da cento lucine, che occupa l’intero boccascena. Gli undici “cantanti Marcido” – alcuni raddoppiati da sagomati in cartone per riempire tutte le nicchie di questo gran retablo – sono imbozzolati all’interno di altrettanti costumi-conchiglia bianchi, a loro volta collegati da tiranti alla Grande Conchiglia che fanno risuonare di voci soliste e contrappunti corali.
Come abbiamo visto, attore e scena sono collegati spesso inestricabilmente in un tutt’uno da legacci e corregge, funi e carrucole, protesi e ceppi, che sospingono il corpo vivo, con la sua carne pulsante e il suo respiro, verso la macchina e la cosa. Costumi e acconciature possono evocare anche la materia o l’animale. Esemplari e memorabili restano i costumi dell’Agamennone, che intrecciano l’umano con il minerale, il vegetale, l’animale, e che al tempo stesso fungono da sorgenti ritmiche e rumoristiche, come mantelli sciamanici: le scaglie di rame dello strascico di Clitennestra-serpente, le lance di legno che si dipartono da Agamennone-istrice e – già citato – l’abito pesantissimo e interamente ricamato di anelli d’ottone con corona-lampadario a raggiera d’alluminio al cui centro campeggia una Cassandra-ragno. In un’“opera d’arte totale” ossessiva e claustrofobica, l’elemento umano resta così angosciosamente sospeso tra la dannazione e la redenzione, tra la regressione nella materia e la sublimazione nello spirituale.
L’ibridazione tra umano e non umano resta peraltro una costante a cui attingere, non appena se ne presenta l’occasione. A volte – e con i Marcido accade spesso – si condensa in esperimenti che generano efficaci metafore sceniche.
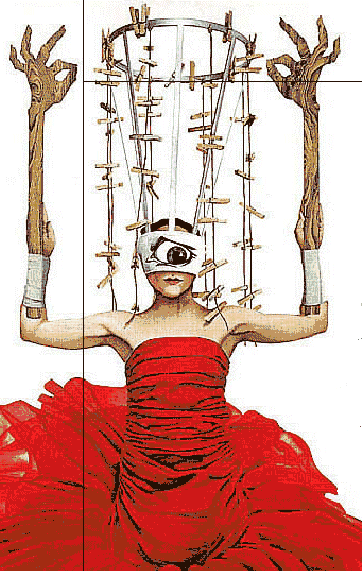
La Grande Ballerina protagonista di Canzonetta.
In Canzonetta – presentato come “studio dai Persiani” – protagonista è la Grande Ballerina (in Eschilo era la regina Atossa, vedova di Dario e madre di Serse), essere “finto naturale”, chimera che nasce dalla fusione di due corpi, sormontata da un ennesimo grande occhio cieco e da una beffarda corona-aureola decorata di mollette da bucato; anche le mani sono riproporzionate grazie a due protesi di legno che alludono ai remi della battaglia navale di Salamina, intorno a cui ruota il testo. A creare il mostro è il tutù rosso che inguaina due corpi impilati e incastrati uno sull’altro, quelli “dell’attore che verso il basso preme seguendo gravità e del danzante che alla gravità si oppone e verso l’alto spinge”, come annota Ferdinando D’Agata: alle sue gambe muscolose tocca, in un exploit atletico, il ruolo del “danzante”, mentre la voce dell’attore “che verso il basso preme” è quella di Maria Luisa Abate. Proprio nel contrasto tra queste due energie contrapposte, tra voce e corpo, sta il senso di una sperimentazione quasi agonistica: secondo le note di regia, “lo stridere delle giunture mentre è in atto lo sforzo per dare esistenza al progetto chimerico, fonderà lo spettacolo”.
In questa colorata sarabanda di ibridi e chimere s’intrufolano animali totemici, che campeggiano su grandi pannelli o in enormi sculture: il Gatto e la Volpe per Pinocchio; i cavalli alati del Carro di Oceano per Una canzone d’amore; il grande gorilla smembrato per far apparire Suzie Wong; e naturalmente la Grande Conchiglia di Bersaglio su Molly Bloom...
Ma l’inesauribile fantasia scenografico-costumistica di Daniela Dal Cin partorisce altre creature affascinanti e inquiete, dove è impossibile definire il confine tra l’umano, la cosa e l’animale. La Sirenetta, già di per sé un ibrido tra donna e pesce, si ritrova qui sospesa tra il video-acquario e la realtà tridimensionale. Nel Cielo in una stanza, due atletici attori hanno il duro compito di diventare la tigre Ma, “chimeride abbastanza grasso”, “creatura plurale di carne, di ferro e di variopinta seta, capace di scavalcare gli elementi che la compongono per recitare a puntino”.

Suzie Wong protagonista di A tutto tondo.
La “folle icona” in cui si trasforma Suzie Wong in A tutto tondo è la memoria di una soubrette vagamente anni Cinquanta, che funge da puro pretesto per l’invenzione di un feticcio di seduzione: è una farfalla gigante con zoccoli da equino, ibrido grottesco e narcisista, corpo seducente e terribile compresso in una gabbia-bomboniera-vagina rosa e vezzosa, a riversare il suo interminabile flusso verbale sul pubblico.
Quando fa Pinocchio, l’Isi convoca un Mastro Geppetto frutto della fusione di due corpi uniti come gemelli siamesi, mentre per il Grillo Parlante ne servono tre impilati come acrobati; l’Omino di Burro è un grottesco blob, Lucignolo è circondato da uno sciame di fiocchi rossi che sembrano leggere farfalle e Mangiafuoco, un abito a strisce bianche e rosse come i bastoncini di zucchero che vendono alle fiere, ha per copricapo una giostra dove corre un cavallino rosso.
Questa insofferenza del corpo, questo intreccio tra umano e non umano, ma anche tra corpo e voce, trova la sua più evidente incarnazione nel Coro, ingrediente costante del work in progress dei Marcido. Perché il modello del loro Palcoscenico Elementare resta la tragedia greca, o meglio le sue origini – il momento in cui l’attore protagonista si è appena distaccato dal Coro, imponendo la propria abnorme individualità (di qui, anche, la predilezione per Eschilo, il primo tragediografo, il più primitivo e barbaro).
Per capire il senso di questi vent’anni di lavoro, il Coro è forse l’elemento chiave. La locandina di Happy Days in Marcido’s Field gli regala uno dei più appassionati elogi che sia dato leggere: gli attori
fondano, instaurano e costituiscono la materialità fisica dello spazio scenico, saranno quindi essi palco, quinta, praticabili; saranno il sipario e i siparietti, il fondale e l’arlecchino, tiri luci e cieli neri.
Per definire in locandina i suoi Cori, Isidori libera una sardonica furia nomenclatoria, abbandonandosi a un parodico gusto pop: ecco così un Coro della Bellezza, un Coro di fantastici camerieri della parola, la Banda dei cinesini Sic et Simpliciter affiancata da Sette elementi da sbarco sette (il Coro dei cinesini, chiamati in demente cantilena Kiclo, Riclo, Niclo, Ziclo, Ticlo, Liclo, Biclo), e persino un Chiericoro... Anche senza curiosi battesimi, i boys e le girls danzanti e canterini – e magari sgambettanti su una scalinata da Gran Varietà in cappello a cilindro e scarpe con i tacchi, in frac chiari con vistosi fiocchi ai polsi e alle caviglie (come in Spettacolo) – costituiscono una presenza costante e fondante di quasi tutti i lavori dei Marcido, un elemento irrinunciabile, il fulcro dell’intero lavoro: “Un altro dannatissimo Coro Marcido? Hoinoi!”, autoironizza del resto Isidori.

Il Coro dei Marcido in Canzonette.
Il Coro è un corpo-macchina, un corpo-oggetto, un corpo-animale. È una scultura in movimento, ma quel groviglio di membra evoca anche gli incastri dell’orgia. Il Coro è “accumulo tignoso (...) straripamento d’una massa segnaletica organicamente drammatica”, è il magma dove si annullano le identità. Il Coro è il servo di scena indispensabile a mettere in moto e agitare e vivificare la Gran Macchina Inquieta del Teatro, è l’energia che lega, slega, monta, smonta, sostiene, distrugge, trasforma... È il master gestuale e vocale dei giovani allievi, che devono muoversi e cantare all’unisono. Il Coro è “Corpo Unico, il solo recitante autorizzato a sostenere il respiro vocale dell’Inno per spedirlo sonoro nei teatri”. È, soprattutto, portavoce della phoné nella sua forma più alta, rivelatrice e dirompente.
Perché nel Coro si invera e verifica lo strettissimo e fondante rapporto con la musica. Fin dall’esordio, Isidori offriva una prospettiva di ricerca attraverso l’altra citazione posta in esergo alla “Prima comunicazione” per Le serve, rubata questa volta a Nietzsche:
Abbiamo tentato di chiarire come la tragedia perisca per il dileguarsi dello spirito della musica con la stessa certezza con cui soltanto da questo spirito può derivare la sua nascita.
Se il dionisiaco è l’obiettivo, può essere raggiunto solo ritrovando lo “spirito della musica”. Il percorso dei Marcido si punteggia così di inni, musiche moderne, canzoni e canzoni d’amore... E soprattutto di canzonette, nei titoli (Canzonetta si avvale della collaborazione di un cantastorie di assoluta classe, il giovanissimo Luca Morino), nei sottotitoli e nelle colonne sonore, dove troviamo – ma l’elenco è parziale – Claudio Villa che spara a tutta voce Granada per Una giostra: l’Agamennone; Maramao perché sei morto? e Vedrai vedrai di Tenco per L’Isi fa Pinocchio; Aznavour che in Una canzone d’amore intona Io sono un istrione (e in omaggio all’isolamento del regista-demiurgo del gruppo ripete: “Perdonatemi se, con nessuno di voi, non ho niente in comune”); Gino Paoli che conclude A tutto tondo con Il cielo in una stanza. Nel Vortice del Macbeth, il cui sottotitolo promette “musica per le nostre orecchie”, Isidori-Macbeth gorgheggia: “E se domani / mettiamo il caso / diventassi re...”, facendo il verso a Mina, e fa terminare lo spettacolo con Sergio Endrigo e la sua Colomba, su versi di Rafael Alberti. Come a chiudere un cerchio, Bersaglio su Molly Bloom, che si era aperto con L’amore è una cosa meravigliosa, si congeda – dopo esser passati per Donizetti – con una beffarda versione “made in Marcido” della prediletta Granada, con accompagnamento di chitarrine giocattolo. Nel programma di sala dello spettacolo, Isidori spiega la sua predilezione per questo brano, dacché un bambino-Callas che lo cantava gli fece percepire, forse per la prima volta, “il sibilo del serpente di Dioniso”. Così non sorprende che nel programma di sala di Palcoscenico ed Inno il concetto di “sensazione assoluta” evochi subito nel regista-concertatore il “riferimento emozionale alla cantante Rita Pavone”. La compagnia può anche rubare il titolo a un hit come Il cielo in una stanza e finalmente trasformarsi in “orchestra-spettacolo”, in omaggio a Raul Casadei.
Questa passione per la canzone, questo abbandonarsi spensierati a ritmi e melodie facili facili, questa cura ora seria ora giocosa dell’aspetto musicale, sono il rovescio di un’attenzione ossessiva, fin dagli esordi. Il lavoro dei Marcido è un lungo e difficile percorso di avvicinamento al teatro musicale, già dall’intuizione esplicitata per l’Agamennone, quando si invocava
uno stile recitativo che riferisce al canto (...) ma, proponendosi di ricostruirne il carattere dionisiaco, con intonazioni che dal “parlato” si evolvono in una direzione opposta sia al “recitar cantando” sia alla “ritmica”, cioè trattando le parole soltanto “come se” fosse possibile su di esse comporre una partitura di note, e non realmente vincolandole a una qualunque consuetudine musicale.
(Una giostra: l’Agamennone, cit., p. 5)
Per quanto riguarda la vocalità attorale, i punti di riferimento sono da sempre Carmelo Bene e Marion D’Amburgo. Il primo per il suo lavoro sulla phoné e per la sua tecnica, essendo
l’unico attore in possesso dell’energia buona per tagliare le teste all’idra borbottante dei cortei in superfetazione psicologica, per mezzo del divino, anche se incidentale riappacificarsi (...) del Carme e del Melos, della parola e della musica.
(dal programma di sala di Palcoscenico ed Inno)
La seconda per la travolgente energia scenica, per il pathos trabordante delle sue interpretazioni.

Maria Luisa Abate in Bersaglio su Molly Bloom.
È un mix per certi aspetti improbabile, ma si è presto incarnato nei virtuosismi e nella potenza dei due primattori, lo stesso Marco Isidori e soprattutto la trascinante, fulminante, esplosiva Maria Luisa Abate, energetica e controllatissima artefice di potenti virtuosismi vocali. Dal punto di vista tecnico e in prospettiva solista, il problema è dunque risolto dalle due star del gruppo, almeno provvisoriamente:
I primi spettacoli erano ancora fortemente caratterizzati dal cosiddetto “grande attore” (Maria Lusia Abate, Lauretta Dal Cin, Ferdinando D’Agata, io stesso); ancora mi illudevo che la personalità del singolo attore potesse portare al teatro un contributo di Verità, ma non è più così: da Fedra in poi sono stati costruiti tenendo presente l’ipotesi un po’ folle dell’attore generale, cioè una conglomerazione di personalità attoriali. È una vicenda erotica, una partecipazione dei singoli che non dà una somma, una pluralità, una coralità, ma una entità nuova. (Marco Isidori, intervista di Christopher Cepernich, “Corriere dell’Arte”, 22 giugno 1996)
Altri fronti restano dunque aperti. In primo luogo il Coro, da rifondere e plasmare ogni volta per abbordare il “momento orgiastico del suono” e condurci “in prossimità del Mantra Assoluto”. Intrecciato a esso, il gran problema del senso e dell’equilibrio tra parola e musica, la conflagrazione tra immagine e phoné. Che la soluzione non sia semplice, lo provano numerosi indizi: primi tra tutti, la Grande Ballerina di Canzonetta, con il suo duplice corpo-anima; la programmatica endiadi di un titolo come Palcoscenico ed Inno; o più di recente l’ironica disperazione che tradisce il sottotitolo di Una canzone d’amore, “l’ultima possibile battuta di caccia grossa alle gazzelle della musica”. Persino il testo pirandelliano dei Giganti si ritroverà spezzato da dieci canzoni.

Il coro Marcido alle prese con Samuel Beckett in Trio Party.
La dialettica tra immagine e suono è da sempre uno dei motori costanti della ricerca dei Marcido, più volte esplicitata.
Vorremmo riuscire ad imbastire questa Sirenetta in modo che l’alto quoziente di stupore visivo, gareggi di continuo con la tensione della massa fonica verso una struggente qualità del suono,
si legge nel programma di sala di Palcoscenico ed Inno. Subito dopo si precisa che immagine e canto sono divisi da uno “scarto sintattico” che va superato in un “vortice enfatico”; sono “concorrenti”, ovvero “arieti che nell’eccitazione agonistica forzano il velario di tutti i sensi”.
In una prima fase la declamazione tende a essere volutamente enfatica, melodrammatica, ritmata e solenne, sostenuta da un’oratoria ora tronfiamente ridondante ora marcatamente grottesca, come deformata da un ricercato eccesso di pathos. In Musica per una Fedra moderna questo processo viene condotto all’estremo e insieme affinato: la frantumazione delle frasi, il dispersivo esibizionismo delle passioni, la sottolineatura isterica di ritmi e accenti, la sovrapposizione di tonalità e rumori trasformano il testo in una sorta di verbigenerazione futurista. Non a caso lo stesso regista, in veste di direttore d’orchestra, è in proscenio a governare questo magma vocale, accovacciato in una posizione quasi fetale (e si ritroverà spesso in questo ruolo à la Kantor). Così come per il successivo Spettacolo, sempre ispirato alla Fedra, il testo viene riscritto in una partitura che non segue – se non di rado – il pentagramma, ma indica volumi, ritmi e tonalità, ripetizioni e sovrapposizioni di voci, e offre precise indicazioni quasi a ogni sillaba: “voci mediamente acute”, “prevalenza bassi”, “Tarantella”, “pausa fantasmatica”, “esploso”, “legato”, “tagliente”, “a valanga”, “2 voci + tappeto”, “zoccoletti”, “voce maschera”, con una terminologia che tradisce la messa a punto di un articolato gergo tecnico. Frasi e parole vengono triturate e ricomposte dal coro, borbottate, sussurrate, gridate, martellate, svuotate di senso da frantumazioni, echi, riverberi, inciampi, balbuzie: pura materia sonora che esplode, si avvita su sé stessa e si ricompone secondo ritmi e melodie musicali, a metà tra le antipoesie futuriste e l’analisi fonetica alla Jakobson.
Di questa linea di teatro musicale il recente Bersaglio su Molly Bloom è il frutto più maturo ed equilibrato. Per certi aspetti lo spettacolo va nella direzione esattamente contraria rispetto all’originale joyciano: l’invenzione del flusso di coscienza, che avrebbe segnato tutta la letteratura del Novecento, viene letteralmente ribaltata. Il vagabondare dell’io nel monologo notturno, il flusso soggettivo dell’anima, vengono declinati come pura oggettività, parole e suoni disincarnati. La voce di Molly Bloom, il suo fantasticare tra sonno e veglia, tra memoria e desiderio, vengono oggettivati, epicizzati e affidati addirittura a un coro (al cui centro giganteggia però la solista Maria Luisa Abate), che si esibisce in una partitura musicale ancora più raffinata di quella di Spettacolo. Anche in questo caso il copione, sul leggio di fronte al regista-direttore d’orchestra Isidori, è meticolosamente rimarcato da segni e segnacci neri, sottolineature, cesure, grumi, in una notazione impressionisticamente efficace, con il suo codice di pause e crescendo, assoli e unisoni. Da un lato la scena crea uno spazio di relazione, una relazione tanto profondamente necessaria che a volte risulta addirittura perversa, sadicamente determinata. Dall’altro il recitarcantando corale crea una massa sonora destinata a risuonare nei corpi e a farne vibrare le viscere. Sono esercizi che presuppongono una sapienza, ovvero un’idea di teatro intuita e perseguita con ferrea determinazione. È un duro lavoro, un feroce esercizio di affiatamento, una fatica che forse nessuno, oltre a questi forsennati autodidatti e puntigliosi pedagoghi, può sopportare.
Questa deriva della Parola verso la Musica – verso la creazione di veri e propri “melodrammi da camera” – tradisce però anche una sfiducia, o la perdita d’una fede: per il poeta Isidori (e non solo per lui, ovviamente) a un certo punto la parola sembra perdere la capacità di trasmettere il senso – o almeno il senso autentico.
E’ curioso che Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa, nata facendo fiorire l’esasperazione su di un’ipotesi fonico/recitativa assurta come fosse il campo esclusivo dell’espressione in atto, sia venuta costruendogli accanto, un edificio figurale e che in qualche modo ribadisce i temi del moto sonoro.
(dal programma di sala di Il cielo in una stanza)
Allora è necessario in qualche modo rivitalizzarla, la Parola, e riempirla di nuovo senso, ridarle vita attraverso il respiro e la voce, e insieme svuotarla sospingendolo verso la pura phoné. O meglio, prima è necessario liberarla dalle scorie e dai residui di senso spurio che ancora vi sono incistati, incagliati. Una didascalia di A tutto tondo spiega che Suzie “s’innesterà capricciosamente (...) facendo tutto lo scempio del senso che sarà necessario e possibile, onde stanare il teatro maiuscolo, e disporlo, invece, buono buono, alla comunione dei sensi”. Poi, in feroce polemica contro il “teatrone (...) di prosa, mera, una dizione testuale, quella, quello che al più (non) accadeva in scena”, si spiega che la voce deve “scovar Musica Sonante dentro la struttura semantica che un’enunciazione puramente utilitaria della parola recitata, aveva impastoiato silente” (dal programma di sala di Una canzone d’amore). Come ammoniva Tadeusz Kantor, “gli attori non si identificano con il testo. Sono piuttosto un mulino che macina il testo”. Così ecco Isidori prefigurare e invocare una nuova figura: l’Attore Generale. A questo “Attore Che Più Non Recita” chiede di
sensualizzare (dunque profondamente confondere) il binomio semantico musicale, affinché (...), per un effetto d’accumulo, la portata del nucleo significante si scinda in un’entusiasmante polivalenza prismatica (...) poiché nessun corpo linguistico tollera una carica così onerosa di segnali.
(dal programma di sala di L’Isi fa Pinocchio)
In A tutto tondo sono la stessa disarticolazione sintattica, l’accumulo di metafore oscure, l’esplosione di lapsus e calembour nel testo di Marco Isidori a far esplodere il senso:
Codesta Seratina solo una Festa è dell’empietà autorale Sua: flusso sturato, deficiente al massimo,
del tutto incontinente e cieco veramente è questo tale male.
È quasi un’ansia di rendere impossibile ogni interpretazione, in un delirante parossismo verbale e metaforico. Martellante parodia dell’ineffabile caro alla lirica, questo rap barocco s’avvita come uno sfogo provocato dal gas esilarante. La forma è quella di un “teatro canzonetta” che – addensando banalità e discontinuità logiche, finte vertigini e sfuggenti ironie – obbliga lo spettatore a un faticoso esercizio di decifrazione destinato all’insuccesso e alla frustrazione, per spingerlo a de-pensare per trovare diversi livelli di percezione.
Non si tratta più di comunicare attraverso la lingua ma nella lingua, avventurandosi “nel cuore di una metafisica della parola sonante che giustizi l’inconsistenza attuale di qualsivoglia drammaturgia del testo”; la scomposizione sonora opera “una ricerca sulla stratificazione del senso, che obbliga le parole ad emettere una pluralità di segni” (dal programma di sala di Musica per una Fedra moderna).
Gli Eroi e le Eroine dei Marcido, conficcati al centro della scena, vengono crocifissi sull’altare della Parola e diventano protagonisti di riti in forma spettacolare, con il Coro in veste di sacerdote. Ma, va aggiunto, sono squartamenti e orge senza sangue e sperma: solo pelle e parole, e poi ingranaggi e immagini, pulegge e fondali, effetti speciali e trucchi da circo. Alla fine di Spettacolo, Fedra viene schiacciata tra due pareti irte di frecce, che insieme tessono la ragnatela di fili rossi destinati a denudarla: ultima metamorfosi oscena e terribile di un Mistero.
Con quel loro “Io” ipertrofico, con la loro mostruosa soggettività, le vittime sacrificali dei Marcido si ritrovano pressoché immobilizzate dalle implacabili macchine di tortura che le ingabbiano e le possiedono, e quasi le stuprano e sodomizzano. Nei corpi dei primattori, che la regia comprime fino al punto di rottura, si accumula un’incontenibile energia fisica, psichica e poi vocale, che stratifica la parola in una pluralità di significati. Questi corpi “preparati” possono dunque eruttare le parole con un mostruoso eccesso di senso, far esplodere il testo nello sfrangiamento prismatico dei significati, esondare nel “caos prelinguistico”.
Questa perdita di senso, su quel Palcoscenico Elementare che è anche “Camera di Demenza”, è una manifestazione di deficienza e di splendente imbecillità, perseguita attraverso una sistematica decostruzione, un giocoso de-pensarsi.
Del linguaggio / il libertinaggio / fino a quell’overdosaggio / che lo sbatte a dovere / il linguaggio / lo sgratta stracciato / a splendente / lo piaga / finalmente / lo piega a demente / diamante / infinito / vagito / kaputt!
(Ballata del reale secondo, da Facciamo nostri questi Giganti!)
L’ansia di stupidità viene condensata nell’esemplare icona di Sabino, “il portiere più cretino del mondo” che accoglie l’unico spettatore sulla soglia del Cielo in una stanza: la sua chioma-copricapo è sormontata da un grappolo di palloncini che tirano verso l’alto e ne alleggeriscono – per così dire – la mente.
E’ un segno decisamente autoironico, come se ne incontrano molti in questo bestiario, e che forse sarebbe stato impensabile nei primi lavori dei Marcido. In effetti, a ben guardare nell’unità profonda di temi e motivi c’è qualcosa che in questi vent’anni ha modulato in maniere diverse e sempre variate l’ispirazione dei Marcido: un vivace senso dell’ironia, che parrebbe in contrasto con la serietà enfatica, la violenta tensione creativa e le battaglie cultural-teatrali del gruppo.
Le fonti di questo atteggiamento sono ugualmente variegate. In primo luogo il gusto della parodia (un lascito del primo Carmelo Bene) e dunque del gioco, con la sua libertà e gratuità, in contrasto con la precisa determinazione delle strutture spettacolari, l’implacabilità della macchina, il rigore delle forme. Di qui irrompono la felicità e il piacere del teatro, con il suo mix di esibizionismo e virtuosismo. Di qui fanno breccia il caos, l’irresistibile bisogno eversivo, il gorgo delle ossessioni, la furia delle pulsioni, di qui emergono incontrollabili – nelle strutture chiuse degli spettacoli, nelle loro ferree predisposizioni – l’errore, la dissonanza, il lapsus, il calembour, l’invenzione fantastica.
Non a caso l’autoironia si intreccia a una riflessione sul teatro che si è fatta via via più consapevole ed esplicita con il passare degli anni. Perché quella di Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa è anche, come s’è visto, la lunga, consapevole invenzione ed esplorazione del Palcoscenico Elementare. Sono stati vent’anni di sperimentazione sul teatro, sui suoi elementi costitutivi e sui loro rapporti, sulla grammatica e sulla sintassi dell’evento spettacolare. Non sorprende dunque che la tematica del teatro nel teatro venga esplicitata di frequente, e a volte in maniera scherzosa: nei titoli (Spettacolo, Palcoscenico ed Inno...), nella scenografia della Locandiera, e in certi costumi: in L’Isi fa Pinocchio c’è un allegro Jolly con un costume-tenda sul quale sventola lo stendardo “W il teatro”, che potrebbe diventare l’emblema della compagnia.

La locandina di Facciamo nostri questi Giganti!
In questa deriva la Marcido doveva prima o poi incontrare un testo chiave per questa tematica, come i pirandelliani Giganti della montagna: e il teatro nel teatro trova in scena varie sottolineature, dal costume del Mago Cotrone-Isidori, decorato con un carosello di burattini, fino alla straordinaria parodia della Grande Attrice, con l’ingresso di Ilse-Maria Luisa Abate,aggrappata come la Duse alla tenda-sipario del suo carro-teatro, che ulula:
PER CHI? PER CHE? STO TEATRO? PER CHI? PER CHE? STO TEATRO?
Soprattutto, val la pena di ripeterlo, l’ironia tradisce e rivendica la propria ignoranza e deficienza, il desiderio in qualche modo di de-pensarsi, per scardinare la soggettività che del senso è la depositaria:
Ego / ego / ego / boom!
Facciam fare all’ego boom!
Facciam fare all’ego questo benedetto trip!
Sì! Sì! Oh! Sì! L’egastro in slip! MUTANDA FIRMATA: VOLGE E SMAMMANA!
si canta sempre nei Giganti.
L’ironia offre infine una consolazione di fronte all’impossibilità della “rivoluzione teatrale”, all’irraggiungibile approdo in un’altra realtà, vagheggiato agli inizi e ostinatamente perseguito, spettacolo dopo spettacolo, e arenatosi spettacolo dopo spettacolo nella vischiosa inerzia di questo mondo, teatrale e non.
Ma l’ironia è anche, naturalmente, il sorriso di Dioniso – o forse la sua eco. E questo non è secondario, in un gruppo che ha fatto del dionisiaco il suo irraggiungibile bersaglio. Perché questo teatro-corpo-macchina è anche la Maschera di Dioniso. Da questa identità sorge, per il Poeta e la Pittrice, la imprescindibile necessità di misurarsi proprio con la Scena. Tuttavia vedere il Dio è un’esperienza insostenibile, e la maschera è insieme un veicolo e una barriera: attraverso il teatro che mostra e svela, ne possiamo avvertire solo i riflessi, gli echi (anche nelle sue indecisioni, nelle velleità, nelle impasse). Nei loro esperimenti i Marcido hanno cercato di modulare la Maschera di Dioniso nella maniera più precisa e perfetta, per togliere la maschera alla realtà, per portarci in un’altra dimensione dell’esperienza, per regalarci quell’epifania.
Maschera e skené sono “forme di passaggio”, che abbracciano l’intera attività dionisiaca, non al fine di condurre a perfezione la persona, ma per plasmarne una nuova, straniera al mondo. Non avviene un processo di evoluzione ma di trasformazione: mistero, komos, teatro sono fasi diverse di questo viaggio; il teatro si fa necessario perché, rispetto al komos, sposta l’azione dal luogo reale (la strada) della vita rifiutata a quello fittizio del limen (la vita autentica invocata): la skené.
(Teatro provincia dell’uomo, cit., p. 9)
In questa aspirazione a una pienezza originaria che è insieme perturbante apertura sul futuro sta la tensione rivoluzionaria (e insieme profondamente reazionaria) dell’“arte teatrale, l’arte che l’uomo/tramite/l’uomo/fa”: il tentativo di superare d’un balzo il moderno, il presente romantico e psicologico, per perdersi in una nuova rivelazione.

Daniela Dal Cin per il programma di sala del Cielo in una stanza.
La Maschera di Dioniso – il Palcoscenico Elementare – viene prefigurata e contornata dai pastelli e dalle matite di Daniela Dal Cin, insuperabile illustratrice, meticolosa nella resa illusionistica del dettaglio ma anche capace di sintesi grafiche fulminanti, tra il fumetto e il cartellone: vedi il groviglio di rose e i ventagli erotici gialloblu per Il cielo in una stanza, il Gatto e la Volpe rosaneri del Pinocchioe il giocoso Sipario delle Commedianti per La locandiera. Questa pignola maestria tecnica riesce a dare credibilità alla poesia surreale dei costumi e delle acconciature, ma anche precisione progettuale alle complesse strutture architettoniche e alle ardite macchine sceniche.
A dar conto della competenza teatrale della scenografa-costumista c’è l’impressionante corrispondenza tra i bozzetti e le foto di scena. Le sue visioni pittoriche – già dotate di un innegabile fascino – sono anche illuminate invenzioni teatrali, che solo sulla scena s’inverano appieno. Sono anche, quei disegni, quei fondali, quei costumi, quei carri, la gran parte della memoria del Palcoscenico Elementare dei Marcido – forse la più vivida. Sono, al tempo stesso, il travestimento rutilante e meticoloso dietro cui si nasconde un mistero, un sapere segreto, la materia su cui sperimentare l’alchimia isterica del metallo performativo, alla ricerca dell’oro teatrale, invasati dall’“idea che il delirio abbia la capacità d’incidere sul reale” (Le serve, Comunicazione numero due).

Quelle forme dettagliate e quei colori squillanti, questo labirinto di demoni e chimere sono il sostrato infantile della fiaba crudele di Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa. Sono i paramenti sacerdotali del rito. Sono il residuo che ogni sacrificio lascia inevitabilmente dentro di sé.
Santa Maria Maggiore, Natale 2006.
Sulla natura teatrale del Test di Turing
In appendice a Valeria Patera, La mela di Alan. Hacking the Turing Test, Di Renzo, Roma, 2007
di Oliviero Ponte di Pino
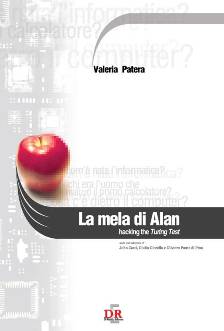
Un testo teatrale o uno spettacolo che hanno per protagonista Alan Turing, l’inventore della Macchina e del Test che portano il suo nome, costringono – per la stessa natura dei temi trattati – ad alcune riflessioni sul teatro e a una parallela serie di riflessioni sulla scienza. E naturalmente a qualche pensiero sul rapporto tra teatro e scienza.
(La Macchina di Turing è l’archetipo di tutti i moderni computer – o meglio, di tutti i possibili calcolatori umani ed elettronici. E’ dunque il punto di partenza di ogni discussione sull’intelligenza artificiale.
Si può immaginare la Macchina di Turing come un apparato collegato a un nastro di lunghezza infinita, che può compiere operazioni semplici. Dopo aver letto il simbolo su una casella del nastro, la Macchina può cambiare il simbolo sulla casella e/o spostarsi a destra o a sinistra entro un certo numero di caselle; sceglierà quali operazioni svolgere in base al proprio “stato della mente”, ovvero alla propria configurazione interna; inoltre l’osservazione dei simboli sul nastro potrà cambiare il suo “stato della mente”.
Per fare tutto questo alla Macchina di Turing sono sufficienti lo 0 e l’1 del codice binario e gli operatori logici.
Al di là delle sue implicazioni filosofiche – da un lato il problema della decisione di Hilbert e il teorema di incompletezza di Gödel, dall’altro il grande enigma della mente – e delle sue applicazioni pratiche, l’intuizione di Turing è straordinaria perché offre una connessione diretta tra i simboli astratti e il mondo fisico.)
(Il Test di Turing è ispirato a un gioco di società e di ruolo, centrato sull’identità di genere: l’interrogante deve determinare, sulla base esclusiva di risposte scritte, quale degli altri due giocatori – chiusi in un’altra stanza – sia un uomo e quale una donna. L’uomo ha per obiettivo di ingannare l’interrogante, la donna invece quello di aiutarlo.
Lo stesso meccanismo si può applicare – questa l’intuizione di Turing, semplice, geniale e molto discussa – anche al pensiero o all’intelligenza: basta sostituire all’uomo e alla donna un calcolatore – o meglio una Macchina di Turing – e un essere umano.
A rendere celebre il Test di Turing è stata soprattutto la prima scena del film Blade Runner di Ridley Scott, tratto dal romanzo di Philip Dick Do Androids Dream of Electric Sheep?, dove viene utilizzato per smascherare gli androidi.)
Qualche semplificazione sarà inevitabile, altrimenti il discorso rischia di farsi lungo e un po’ noioso. Ma proviamo ugualmente a tirare alcuni fili, anche se sono molti e di diversi colori: dunque il disegno sul tappeto sarà un po’ sgangherato e i fregi avranno qualche incoerenza.
O forse emergeranno solo suggestioni, analogie un po’ stiracchiate o addirittura infondate, fuorvianti: e il disegno sul tappeto risulterà confuso, sfuocato.
(Anche Charles Babbage, mentre inventava la sua Macchina Analitica, si ispirò alle schede perforate impiegate nei telai per tessere complicati disegni sul broccato.)
Per cominciare, immaginiamo che ogni personaggio letterario o teatrale – in questo caso l’Alan Turing immaginato da Valeria Patera – sia un nastro prodotto da una Macchina di Turing e che al lettore venga proposta una variante del Test di Turing. In effetti abbiamo una striscia di segni (un testo facilmente riducibile a un nastro di 0 e 1) e dobbiamo immaginare quello che succede “là dentro”, figurare chi c’è “dietro”.
Siamo molto bravi a farlo, e ci piace moltissimo immaginare lo “stato della mente” delle invenzioni letterarie. Ci riveliamo abilissimi nel riempire i buchi della storia, a coprire i salti nello spazio e nel tempo, a non accorgerci delle incongruenze logiche. A ricostruire – nel nostro “stato della mente” – una narrazione.
(Ovviamente ci sono enormi differenze tra la lettura di una pagina scritta e il Test di Turing. Per esempio, la “sospensione dell’incredulità”: noi sappiamo che quello che stiamo leggendo è “finto” e ciononostante ci commuoviamo come se fosse “vero”.
Alan Turing era pressoché incapace di mentire.)
Ora proviamo a pensare a un attore che legge il copione e deve interpretare un personaggio. Magari l’Alan Turing del testo di Valeria Patera. Anche qui, possiamo immaginare un’altra variante del Test di Turing.
Quando i comici arrivano al castello di Elsinore, Amleto assiste a una sorta di prova e vede l’attore immedesimarsi nel personaggio:
“Non è mostruoso che quell’attore lì, / solo fingendo, sognando la sua passione / possa forzare l’anima a un’immagine / tanto da averne il viso tutto scolorato, / le lacrime agli occhi, la pazzia nell’aspetto / la voce rotta, e ogni funzione tesa / a dare forma a un’idea? / E tutto ciò per niente! / Per Ecuba! / Ma chi è Ecuba per lui, o lui per Ecuba / da piangere per lei?”
(Amleto, II, 2, trad. Nemi D’Agostino, Garzanti, Milano, 1984)
Chi è Turing per l’attore, o l’attore per Turing, da piangere per lui?
(Ai tempi di Shakespeare, come in altri momenti chiave della storia del teatro, alle donne era vietato calcare le scene. Dunque nell’Amleto l’attore che interpretava Ecuba era un giovane uomo che recitava en travesti, dissimulando la propria identità sessuale.
Inutile sottolineare il ruolo dell’omosessualità di Turing e le dissimulazioni dell’identità sessuale in un ambiente repressivo nell’ideazione di un test che obbliga uno dei giocatori a mentire sul proprio sesso.
Ma che cosa succede nell’interiorità di un attore quando si cala nel personaggio? Deve davvero provare le sue stesse emozioni, i suoi stessi sentimenti? Oppure deve semplicemente produrre con il proprio corpo – a freddo – i segni attraverso cui lo spettatore riconoscerà quelle emozioni e quei sentimenti?
Quale deve essere lo “stato della mente” dell’attore quando interpreta un personaggio?
Nella prospettiva dell’intelligenza artificiale, il paradosso dell’attore caro a Diderot – che parla proprio di questi due diversi modi di essere attore, quello in grado di immedesimarsi nel personaggio caro a Stanislavskij e la supermarionetta di Kleist e Gordon Craig – evoca il problema della mente. E’ riduzionisticamente possibile scomporre tutte le operazioni del cervello umano – e dunque la sua biologia – come se fosse una Macchina di Turing? Oppure è necessario qualcos’altro? Magari l’anima?
Questa divagazione rimanda a una nota variante del Test di Turing, quella della stanza cinese immaginata da John Searle. Non conosciamo il cinese e siamo chiusi in una stanza dove abbiamo a disposizione un testo da tradurre in quella lingua, una cassettiera con tutti i possibili ideogrammi e un manuale con le regole di traduzione; se applicando quelle regole riusciamo a dare una corretta traduzione in cinese del brano che ci è stato assegnato, possiamo con questo dire di conoscere e di capire il cinese?
Insomma, un traduttore elettronico o meccanico può davvero “capire” un testo? E’ sufficiente utilizzare correttamente un insieme di regole formali per essere intelligenti?Per avere una mente – e un “io” – basta che l’hardware dei circuiti elettronici, oppure di neuroni e sinapsi, superi una certa massa critica?
C’è chi, come George Steiner, ipotizza che senza un principio trascendente il linguaggio non possa avere senso.)
Ora stiamo osservando un uomo. Tutti lo chiamano Alan Turing, parla come Alan Turing, è vestito come Alan Turing, si muove come Alan Turing, gli succedono le cose che capitano ad Alan Turing. Forse vive le stesse emozioni di Alan Turing.
Ma non è Alan Turing, lo sappiamo benissimo. Eppure allo stesso tempo, in momenti come questi, crediamo che sia Alan Turing: tanto è vero che possiamo piangere (o ridere) di quello che gli accade, soffrire e gioire delle sue vicissitudini.
Sappiamo che non è lui e crediamo che sia lui. Non è logico.
(C’è un aspetto simpaticamente teatrale nel Test di Turing: per superare la prova, la Macchina deve fingere, per simulare in maniera convincente il comportamento di un essere umano. Insomma, per prima cosa la Macchina di Turing deve imparare a recitare.
Se per esempio le viene sottoposto un complicato calcolo matematico, un’operazione che è in grado di eseguire correttamente in poche frazioni di secondo mentre il suo concorrente umano dovrà impegnarsi per settimane e magari sbagliare, la macchina calcolatrice non può seguire il proprio “istinto” ma deve tergiversare, forse inventarsi un risultato sbagliato – credibilmente sbagliato.
Insomma, per superare il Test la Macchina di Turing deve diventare un attore.
Anche il ricorso a una logica non strettamente aristotelica e l’empatia sono probabilmente tra gli elementi critici necessari per superare il Test di Turing.
Potremmo chiederci se anche la Macchina di Turing ha bisogno dei neuroni specchio o se può farne a meno. In altri termini, è possibile pensare una mente senza un corpo?)
(Parentesi nella parentesi: la scena della recita dell’Amleto è l’esempio più classico di “teatro nel teatro”, ovvero di mise en abyme, che in campo artistico è l’equivalente del paradosso del mentitore. Ceci n’est pas une pipe è il titolo del celebre quadro di René Magritte che raffigura proprio una pipa.
Teatranti, pittori e scrittori usano da sempre la mise en abyme per arricchire gli effetti della loro arte, e al tempo stesso per riflettere sulla sua natura – e magari anche per regolare i conti con i rivali: per esempio Shakespeare nell’Amleto se la prende con le compagnie di ragazzini che andavano molto di moda e facevano concorrenza ai suoi Queen’s Men...)
Vediamo il nostro Alan Turing e gli altri attori muoversi sulla scena dal momento in cui si apre il sipario al momento in cui si chiude. Si possono usare altri marcatori per delimitare la rappresentazione (e si possono anche pensare confini più fluidi tra lo spaziotempo feriale e quello festivo), ma la sostanza non cambia: la rappresentazione ha un inizio e una fine nel tempo e nello spazio.
Di più. La rappresentazione è stata – almeno nelle grandi linee – preparata in anticipo: il drammaturgo ha scritto il copione, lo scenografo ha allestito lo spazio, gli attori hanno imparato la parte a memoria, il regista ha delineato i loro gesti e movimenti. Ancora, proprio grazie a questo lavoro preparatorio la rappresentazione può essere replicata: lo spettacolo è andato forse in scena ieri sera e forse tornerà in scena domani.
Per molti aspetti, è la struttura di un esperimento scientifico.
(Gli spettatori guardano verso l’alto. La scenografia è la Torre di Pisa, il teatro è piazza dei Miracoli. Questa volta gli attori sono due sfere o, come è scritto nel copione, due “gravi”: quale toccherà terra per prima? Quanto tempo ci metterà? Lo spettacolo è destinato a passare alla storia: è infatti il più classico degli esperimenti scientifici.
Galileo Galilei, regista dell’evento, è figlio di Vincenzo, musicista e uomo di spettacolo. Lo stesso Galileo è autore di testi teatrali per certi versi assai curiosi: in uno di essi, per esempio, fa sostenere dal personaggio del contadino dall’aspetto di sempliciotto – il finto tonto, diciamo – la teoria eliocentrica, mentre invece qualche anno dopo, in un curioso rovesciamento di posizioni, nel Dialogo sui massimi sistemi Simplicio sarà il goffo sostenitore della visione aristotelica.)
Una quindicina d’anni fa la computer designer Brenda Laurel ha scritto un saggio fondamentale sulle interfacce, Computers as Theatre (Addison Wesley, Reading, Mass, 1991). Secondo Brenda Laurel, come è evidente fin dal titolo, il teatro ci offre la metafora più chiara ed efficace del rapporto tra l’uomo e il computer. Lo confermano l’intera storia dei videogame, dei giochi di ruolo, delle chat... (Un’altra metafora assai diffusa delle interfacce è quella della scrivania, il desktop.)
Qualche anno dopo una progettista di sistemi interattivi, Janet Murray, in Hamlet on the Holodeck. The Future of Narrative in Cyberspace (MIT Press, Harvard, Mass., 1998) ha studiato le forme della comunicazione e della narrazione nell’era dei computer e di internet, per tracciare una “poetica del cyberspazio” e delineare la figura del “narratore virtuale”.
E’ buffo e curioso (insomma, sintomatico) che per maneggiare il frutto più tipico della modernità, per coglierne tutta la forza dirompente, sia stato necessario utilizzare come riferimento un medium come il teatro, così antiquato e insieme profondamente inscritto nell’essere umano e nel suo modo di vedere e capire il mondo.
Del resto ormai la Macchina di Turing non è in grado solo di simulare il comportamento della mente umana (o almeno di simulare alcuni dei suoi comportamenti). Ora, pochi decenni dopo la visione di Turing, il computer è anche in grado di creare – come il teatro – mondi paralleli, alternativi. Il simbolo – lo 0 e l’1 del codice binario – crea la realtà: immagini, suoni, azioni... L’uso di nuove interfacce (sensori, visori, datagloves, eccetera) apre un vertiginoso ventaglio di possibilità.
Nasce la Realtà Virtuale. O, se preferite, riappare il Gran Teatro del Mondo.
(Gli scienziati hanno progettato e utilizzato i primi calcolatori elettronici per eseguire rapidamente una gran mole di calcoli complessi e ripetitivi. Progressivamente però hanno iniziato a utilizzare i computer anche per creare modelli di simulazione.
A parte l’osservazione diretta della realtà e la ricerca sul campo, i modelli di simulazione sono diventati ormai il terzo strumento della ricerca scientifica, accanto alla teoria e agli esperimenti di laboratorio.
I modelli di simulazione offrono al ricercatore diversi vantaggi: costringono a adottare una struttura logica ferrea e coerente nella scelta e definizione delle variabili e nelle procedure con cui farle interagire, eliminando buchi e contraddizioni nascoste; sono aperti all’interazione e anzi la sollecitano, in molte forme: dal cambiamento dei valori delle variabili e delle variabili stesse alle diverse modalità di gioco e interattività; offrono una mappa che muta nel tempo e dunque restituiscono meglio dei modelli bi- o tridimensionali il flusso e il cambiamento; la struttura narrativa consente inoltre all’osservatore di cogliere la loro logica attraverso la propria esperienza, in una sintesi visiva, e non solo attraverso una schematizzazione astratta e puramente quantitativa.)
I progressi degli ultimi dieci-quindici anni sono stati davvero impressionanti. Grazie a reti di sensori, green e blue screen, protesi percettive, sistemi di motion capture, motion tracking e motion graphics, tecniche sempre più sofisticate di animazione, modellazione e rendering tridimensionale (e naturalmene utilizzando programmi in grado di gestire una mole enorme di input e di calcoli), ormai i maghi degli effetti speciali e dell’animatronics sono in grado di creare e far vivere creature di stupefacente verosimiglianza, con interfacce grafiche di crescente sofisticazione.
Tra poco uno di questi avatar potrà facilmente superare il Test di Turing: sullo schermo vedremo (magari in 3D) l’attore in carne e ossa accanto al suo doppio virtuale, e non saremo più in grado di distinguere l’uno dall’altro.
Forse qualche attore virtuale è già in grado di superare il Test. Ma hanno preferito non farcelo vedere, perché pare che le animazioni troppo perfette – quelle troppo vicine al reale – generino angoscia nello spettatore.
(Quando Alan Turing decise di suicidarsi, addentò una mela in cui aveva iniettato del cianuro.
La mela è un simbolo fin troppo ovvio: il frutto dell’Albero del Bene e del Male, Newton e la scoperta della legge di gravità, Biancaneve e la Matrigna Malvagia...
Ha mangiato la mela avvelenata, ma non è arrivato nessun Principe Azzurro a risvegliarlo. Eppure lo sapeva, fin da bambino: “Quando aveva un’opinione, Alan diceva di sapere, o di aver sempre saputo: per esempio aveva sempre saputo che il frutto proibito del paradiso terrestre non era una mela, ma una prugna”.)
Se vai in rete, su una qualsiasi chat o su un forum, puoi scegliere l’identità che vuoi. Cambiare sesso ed età, preferenze e gusti, come gli hacker nel testo di Valeria Patera. La rete è diventata un Test di Turing planetario, quella stanza chiusa è un labirinto e ora occupa l’intera rete.
(In uno dei suoi “messaggi dal mondo invisibile”, spediti pochi giorni prima della morte, Alan Turing ha annotato: “Religion is a Boundary Condition”, “La religione è una condizione al contorno”.
Negli stessi anni, Kurt Gödel affinava la sua prova matematica dell’esistenza di Dio...)
Proviamo a immaginare un Test di Turing per le condizioni al contorno. O per l’esistenza dell’anima.
Elogio del preservativo in forma di ballata ai tempi dell’aids
L’amore buono, il nuovo spettacolo africano di Marco Baliani, a cura di AMREF
di Andrea Balzola

Dopo il grande successo del Pinocchio Nero (vedi ateatro 84), Marco Baliani ha debuttato a Roma, Teatro Il Vascello, con un nuovo spettacolo realizzato in Africa con ragazzi e ragazze recuperati dagli slum di Nairobi grazie allo straordinario impegno dell’associazione laica a href="http://www.amref.it" target="_blank">Amref. Il Pinocchio nero adattava con ispirata vena poetica e forza teatrale un archetipo della letteratura occidentale come Pinocchio al vissuto dell’infanzia abbandonata di Nairobi. L’amore buono è un’operazione molto diversa, più didascalica e militante, con un obiettivo molto preciso e dichiarato: sensibilizzare le nuove generazioni africane (ma non solo) all’uso indispensabile del profilattico per prevenire l’ulteriore diffusione del flagello dell’Aids che sta sterminando le popolazioni africane. I dati sono agghiaccianti: nel solo Kenya muoiono ogni giorno circa 300 persone a causa dell’Aids, i sieropositivi di età compresa tra i 15 e i 49 anni sono almeno 1.100.000, mentre il numero degli orfani sono decuplicati rispetto agli anni ‘90. Oggi la lotta e soprattutto la prevenzione all’HIV è la priorità assoluta dell’Africa, soprattutto presso le aree più degradate e i ceti sociali più poveri, è perciò naturale conseguenza orientare anche gli strumenti dell’arte e della comunicazione a farne tema e finalità privilegiata di lavoro. Baliani, che è un grande viaggiatore del teatro attraverso le sponde del mediterraneo e ha lavorato molto con i giovani di diverse origini, sa che la scelta del tema non è mai sufficiente per parlare ai cuori e alla mente degli attori e del pubblico, bisogna trovare le strade, passo per passo e mai a priori, attraverso i laboratori sul campo, per raccontare nel modo giusto, per trovare il linguaggio espressivo più efficace in quel momento per quel contesto e per quello scopo. Ancora una volta, come nel Pinocchio nero, il materiale drammaturgico di partenza è la raccolta delle testimonianze dirette da parte dei ragazzi e ragazze che hanno vissuto in prima persona o da vicino la tragedia del contagio e della malattia. Testimonianze tanto più atroci quanto più rispecchiano un sistema di vita fondato sull’ingiustizia più radicale, dai racconti emerge infatti un’altra malattia che sicuramente precede, fa da sorgente e alimenta l’Aids, una malattia sociale dove la povertà si spinge alla mancanza di cibo e acqua, dove il territorio è completamente devastato dalla speculazione economica internazionale (leggi ad esempio le estrazioni petrolifere, e poi ci lamentiamo del pericolo di rapimenti politici…), dove la condizione della donna è allo stadio di puro sfruttamento sessuale (le ragazze che hanno appena raggiunto la pubertà rischiano di essere immediatamente stuprate, ingravidate e contagiate), dove la cultura tradizionale è sradicata con l’imposizione di dubbie forme di proselitismo religioso, dove l’innovazione tecnologica occidentale è un miraggio inarrivabile, dove le istituzioni governative sono quasi sempre corrotte e tiranniche, eccetera.
E come dice Baliani, in questo contesto “amarsi è difficile, amarsi bene, nutrirsi d’’amore quasi impossibile… Dove la vita è pura sopravvivenza non c’è tempo per crescere un sentimento…. Tempo e spazio per i sentimenti appartengono solo alle classi più ricche, ai bianchi, alle nostre società del benessere diffuso… Quando l’amore è sempre rubato, è facile che diventi violento, si nutra di violenza…. Ed è facile allora che il virus dell’aids trovi campo libero, in corpi senza più difese, in corpi allo sbaraglio.”
Cosa resta allora? Lo straordinario spirito africano, un’imbattibile capacità di divertirsi, di amare la socialità e la vita nonostante tutto, di rigenerarsi attraverso l’invenzione creativa e la speranza.
Sono queste le “risorse umane” sulle quali hanno fatto leva il progetto Amref e il lavoro artistico di Marco Baliani e dei suoi collaboratori, per confluire in una specie di musical povero, dove i racconti rielaborati teatralmente si intrecciano con una serie di ballate cantate dai giovani attori africani e musicate da due prestigiosi musicisti come Mirto Baliani e Paolo Fresu. Fulcro dello spettacolo non è quindi soltanto l’aids e la promozione del preservativo (che pure è sempre presente con tanto di dettagliate istruzioni per l’uso), ma “l’amore difficile, l’amarsi spaventato” dei ragazzi e delle ragazze di Nairobi, così ben riassunto in un detto popolare africano: “Quando la povertà entra dalla porta, l’amore scappa dalla finestra”.
Ma gli africani non ci stanno a essere giudicati e magari considerati la causa stessa della peste del nuovo millennio (una delle ipotesi sull’origine del virus è il contagio ricevuto da un babbuino africano infetto), come recita ironicamente l’incipit della prima canzone dello spettacolo (Baboon Song): “Siamo babbuini, ma non siamo cretini/ Ci avete detto che il nostro popolo è infetto/che proprio da noi, da qui/ è partito il virus dell’HIV/ ma nessuno scienziato l’ha ancora dimostrato/ nessuno davvero l’ha ancora spiegato/ non sarà che per calcolo, o forse per caso/ qualcosina vi è scappata dal vaso/ sfuggita dai vostri esperimenti micidiali/ per avere armi sempre più mortali?/…”
Lo spettacolo riproduce la vita caotica degli slum di Nairobi mescolando racconti, lazzi clowneschi, canzoni hip hop di strada e scene che seguendo l’insegnamento shakespeariano incrociano parodia e tragedia, comicità e dolore, informazione militante e poesia. I protagonisti sono in parte reduci dall’esperienza di Pinocchio e in parte debuttanti, con una fortissima carica espressiva a cui Baliani e collaboratori sono riusciti con efficacia a dare la forma musicale di una vera e propria band e la forma teatrale di un’affiatata compagnia, senza privarli di una spontaneità che affonda le sue radici in un vissuto estremo.
L’amore buono
Protagonisti dello spettacolo: Micheal Mwaura, Wilson Franco, Mohammed Kamau, John Muthama, Nancy Ann Gitau, Peter Wangugi, Paul Kamau, Fresha Wangari, Mary Gachoka, Monicah Mbutu, Johna Kiarie, Peter Ngige, Daniel Ndichiu, Daniel Njoroge, Joseph Muthoka, Evans, Oluoch, Nahashon Mbugua.
Tra teatro e pedagogia
Il progetto "Teatro in visita"
di Clara Gebbia
“Teatri in visita” è un progetto finanziato dal Ministero della Salute, a cura dell’ ATCL- Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio e del CTE – Centro Teatro Educazione dell’ETI in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.
Partecipanti alla prima fase del progetto: Lidia Capalvo, Carla Carlevaris, Francesca Castellani, Ada Cristodaro, Ada D’Adamo, Adele D’Amico, Claudia Di Giacomo, Stefania Dusi, Francesca Ferri, Paola Franco, Francesco Galli, Clara Gebbia, Maria Mazzei, Piergiorgio Moresco, Roberta Scaglione, Almerica Schiavo, Giorgio Testa.
Da giugno di quest’anno, a partire da un’idea di Giorgio Testa, si è dato il via al progetto “Teatri in visita” presso la ludoteca dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.
Viene presentata per “ateatro” una sintesi della prima parte del progetto (il periodo da aprile a giugno). “Teatri in visita” si concluderà, almeno in questa fase, a dicembre 2006.
Seguirà quindi, sempre per “ateatro” la sintesi della seconda parte del progetto e le conclusioni tratte in seguito ad una giornata di studio prevista al termine dell’iniziativa.
Consideriamo “Teatri in visita” una “ricerca-intervento” dove si intrecciano sperimentazione e teorizzazione. Lo scopo della documentazione è quello di ricavarne un modello di utilizzazione del teatro, inteso sia come esperienza di visione che come pratica, negli ospedali pediatrici.
Speriamo che documentare questo progetto ci aiuti non soltanto a “sperimentare un modello di utilizzazione del teatro nell’ambito delle strutture sanitarie che ospitano bambini”, come esposto nelle prime righe del progetto, ma anche a mettere ordine nelle emozioni scaturite dal fatto di trovarci in un contesto emotivamente così coinvolgente.
Il 4 aprile 2006, convocati nella sede del Cte - Centro Teatro Educazione dell’ETI, Giorgio Testa ci parla di un progetto da sviluppare insieme: “Teatri in visita”.
Il progetto iniziale esposto da Giorgio (che qui riporto per grandi linee), intende sperimentare un modello di utilizzazione del teatro nell’ambito delle strutture sanitarie pediatriche con varie finalità: introdurre all’interno dell’ospedale momenti di gioco e di leggerezza che aiutino i bambini malati a non vivere il tempo della cura come traumatica interruzione delle normali attività quotidiane; creare, attraverso laboratori teatrali, occasioni ludiche ed espressive che portino il piccolo paziente a vivere la permanenza in ospedale con maggiore serenità; dare la possibilità, ai bambini (siano essi degenti, in day hospital o in visita) e ai genitori di fruire insieme di spettacoli teatrali adatti al contesto in cui si trovano.
Il luogo per la realizzazione del progetto viene presto individuato: l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, precisamente nei locali della ludoteca.
Giorgio ci dà dei riferimenti, ma in realtà il progetto è tutto da costruire: bisogna stabilire tempi, modi, luoghi, contenuti….Fin dalla prima riunione Giorgio ha fatto sì che il progetto crescesse con il contributo di ognuno, e questa linea di collaborazione a livello progettuale si è mantenuta per tutto il lavoro finora svolto.
Le primissime riunioni hanno riguardato gli operatori del Centro Teatro Educazione dell’Eti coinvolti nel progetto e i referenti dell’Atcl. Partendo dalla convinzione che le relazioni costruttive tra i piccoli pazienti e gli operatori teatrali, e il clima di festa dato dalla presenza di familiari e bambini “in visita” possano innescare una condizione psicologica atta a far vivere in maniera più serena la degenza ospedaliera, ci siamo interrogati anche sulla specificità del teatro che forse è quella di suscitare un senso di gioia e di meraviglia, di “trasportare” in un altro mondo, in un altro luogo: il più potente dei giochi. Il teatro che visita l’ospedale può forse aiutare i piccoli degenti e i parenti in visita a risignificare l’esperienza ospedaliera non soltanto come tempo e luogo per la cura del corpo, ma anche come periodo costruttivo e di conoscenza.
Subito comunque abbiamo sentito l’esigenza di chiedere all’ospedale di progettare con noi l’esperienza del teatro che “visita” l’ospedale. Durante gli incontri con l’ospedale si sono aggiunti gli operatori teatrali chiamati a lavorare con noi e interessante è stata l’osservazione dell’interazione tra queste diverse “famiglie” in fase progettuale.
La collaborazione con gli operatori dell’ospedale è stata essenziale. Al Bambino Gesù operano già molte associazioni di volontari e non, quindi il nostro desiderio era di comprendere che cosa servisse realmente: la nostra prospettiva è stata fondamentalmente quella dell’ascolto per conoscere le modalità e criteri di lavoro preesistenti e i reali bisogni della struttura. Il lavoro preliminare condotto insieme agli operatori della ludoteca, ha quindi concretamente permesso di stabilire tempi, spazi, contenuti, metodologie, organizzazione dell’intervento nonché, in seguito, di realizzare le attività previste.
Le questioni affrontate comunque non sono state tutte semplici e immediate.
Non sono mancate in fase progettuale divergenze di opinioni: in particolare per esempio riguardo alla proposta da parte nostra di prevedere la presenza di ragazzini esterni all’ospedale provenienti da altre scuole, ma l’ospedale ha vissuto in precedenza come un’esperienza traumatica, e che quindi abbiamo deciso momentaneamente di accantonare.
D’altra parte si sono avuti anche sviluppi inaspettati del progetto, di cui accenneremo in seguito.
Ma procediamo con ordine.
Per quanto riguarda le attività si decide che verranno condotte attraverso 4 linee espressive: musica, racconto, figura, affabulazione.
Si stabiliscono due linee di intervento: uno spettacolo di apertura che è un sorta di benvenuto che il teatro fa all’ospedale, con presenze esterne di familiari, volontari, medici e tutti coloro i quali lavorano e gravitano intorno all’ospedale; e i laboratori, che si svolgeranno per 2 giorni alla settimana con inizio e cadenze da concordare durante il seminario con il personale ospedaliero. In questa prima fase ogni operatore sperimenterà una modalità di laboratorio da adattare via via alle esigenze che il contesto richiede.
Per quanto riguarda i luoghi, in ludoteca in cui è possibile usufruire di due spazi, uno po’ più grande e uno un po’ più raccolto, dove normalmente non è prevista la presenza di visitatori esterni; fondamentale è stato dibattere il problema del tempo: si sono previste attività che abbiano un inizio e una fine, poiché non saranno fruite sempre dagli stessi bambini, se non in alcuni casi. Inoltre i laboratori devono essere in grado di far entrare e far uscire i bambini in qualunque momento. Per quanto riguarda la realizzazione del primo spettacolo, vengono proposte e discusse con gli operatori della ludoteca le schede degli spettacoli da realizzare. Viene scelto “Pulcinella che passione”.
Il 14 giugno comincia così la “visita del teatro” in ospedale. Fin da subito ci accorgiamo che il teatro “modifica”l’assetto e la percezione della ludoteca. Nella sala giochi della ludoteca quando entriamo per assistere allo spettacolo, campeggia un teatrino con il faccione di Pulcinella. Dopo aver sistemato le sedie e sedioline, pronte ad accogliere il pubblico, la stanza ha proprio l’aspetto di un piccolo teatro. Ci sono i bambini, che diventano sempre più numerosi, e una educatrice dell’ospedale che in maniera molto efficiente si dà da fare per chiamare tutti i reparti ed avvisare dello spettacolo imminente, cercando di presentare lo spettacolo come qualcosa che vale assolutamente la pena di non perdere. Questo particolare ci fa molto piacere: è evidente come sia scattato un clima di collaborazione e fiducia reciproca intorno al progetto e tra i vari gruppi di lavoro, interni ed esterni all’ospedale.
L’atmosfera è da subito carica di aspettative. Non appena comincia lo spettacolo, i bambini, con età veramente diverse, dai piccolissimi, neanche in grado di parlare o di camminare, ai più grandi, vengono rapiti da “Pulcinella che passione”.
Lo spettacolo è divertente e a tratti entusiasmante per i bambini, grazie alla sapienza con cui è costruito per un pubblico di giovanissimi. Ottiene l’effetto di trasportare i bambini totalmente dentro la storia e a creare un clima di festa e di divertimento. Nell’ottica di una risignificazione del ruolo e della valenza della degenza ospedaliera in chiave positiva e costruttiva, credo che l’esperienza della “festa del teatro” possa avere una sua validità tangibile. Ci sono mamme che finalmente vediamo sorridere, cosa forse che accade di rado in quel contesto. Chiaramente la situazione di “fluidità”, ossia il via vai di bambini genitori continua anche durante lo spettacolo: qualcuno deve andare via, altri sono attesi dai medici per la visita o per la terapia.
Questa “fluidità” comunque caratterizza sotto vari ponti di vista tutto “Teatri in visita”, in cui tutti gli operatori e gli artisti sono chiamati ad adattare momento per momento le attività che stanno svolgendo: all’età, al numero dei bambini, alla presenza dei genitori, alle patologie che ci si trova di fronte, all’improvviso entrare e uscire dei piccoli pazienti.
Inizialmente, abbiamo pensato che il periodo da aprile fino a giugno potesse essere quello che Piaget definisce “esperienza per vedere” per poi far partire i progetto vero e proprio. In realtà ci siamo resi conto che, vista la complessità del contesto in cui ci siamo trovati, tutto il periodo fino a dicembre sarebbe servito per strutturare l’intervento in corso d’opera, per preparare gli operatori (per altro già professionali) alla peculiarità dell’ospedale, per poterlo in seguito esportare. Le problematiche legate all’ospedale infatti sono parecchie e naturalmente con una peculiarità che esula dai contesti strettamente teatrali. Alla fine del periodo fino a giugno, comunque abbiamo tratto varie conclusioni sulla nostra esperienza. Cito qui alcune tra le più significative: oltre alla situazione di via vai all’interno della stessa giornata, molti tra gli utenti dei laboratori si trovano in ospedale per effettuare un day-hospital. Questo impedisce di fare delle attività continuative, ma i singoli laboratori devono avere significato in sé ed “compiersi” nello spazio di poche ore. A fare da contrappunto questa altra forma di fluidità, si è pensato ad un “diario di bordo”, una sorta di “libro creativo delle presenze” dove si potrà lasciare un ricordo, una frase, un segno, che potrà essere ritrovato. Si definiscono inoltre i ruoli che servono alla realizzazione del progetto: il ruolo progettuale è ovviamente affidato a tutto lo staff presente sotto varie forme. Le figure di cui il progetto necessita sono varie: un operatore del CTE sempre presente a tutte le attività, affiancato a turno da una delle ludotecarie dell’ospedale; gli operatori teatrali ossia coloro i quali svolgeranno le attività dei laboratori; gli organizzatori teatrale, che si occuperanno dei rapporti con gli operatori di ludoteca e le compagnie teatrali e della organizzazione e logistica delle feste-spettacolo; lo “storico all’interno del gruppo” che si occuperà di documentare l’attività e dell’aspetto della ricerca.. I ruoli naturalmente non saranno rigidi, possono confondersi, mischiarsi, sovrapporsi e arricchirsi del contributo di ognuno e della ricchezza data dalla pluralità delle voci presenti.
Ci rendiamo conto che oltre alle conclusioni appena tratte ce ne stanno altre che stanno alla base di tutto il progetto, più difficili da analizzare.
Il contesto in cui “Teatri in visita” si svolge è estremamente complesso e delicato. L’ospedale è un luogo di grandi emozioni, non solo negative, ma comunque molto forti. E’ un luogo in cui si si reca per una malattia, piccola o grande, ed è quindi un luogo in cui ci si imbatte nella grande gioia della guarigione, nella sofferenza e nella morte. Anche gli operatori hanno dovuto riplasmare i loro metodi già consolidati e trovare un giusto equilibrio tra “leggerezza” e “gravità” per affrontare il loro lavoro con il grado giusto di distanza e coinvolgimento al tempo stesso, operazione non certo facile. Credo comunque che questo periodo da aprile a giugno sia servito comprendere che se le attività continuative sono praticamente impossibili all’interno del lavoro in ospedale, “Teatri in visita” deve portare con sé, sia nei laboratori che negli spettacoli, un “hic et nunc” capace però di rimanere a lungo nella memoria.
Nel prossimo intervento su “ateatro” parleremo del periodo settembre-dicembre del progetto “Teatri in visita”, e dei suoi nuovi sviluppi.
Della Rivoluzione di uno stabile
A proposito di Prato
di Emanuele Nespeca
Scrivo questa lettera dalle pianure bonificate del Sud-Est romano, a pochi passi dall’ostiense, la via che porta verso Ostia, verso il mare… scrivo per rispondere, o per aggiungere domande, a tutti coloro che hanno partecipato al blog sulla faccenda che riguarda il Teatro Metastasio di Prato – Stabile della Toscana.
Conosco bene il problema pratese, essendo nato a Prato nel pieno del boom economico, quando ancora non c’erano rotonde se non quella di piazza San Marco, la piazza col buco, quando i telai trottavano come cavalli al galoppo e le fabbriche parevano scuderie, quando nel bisenzio (il fiume) ci si andava a catturare i girini. Conosco bene, insomma, il problema della stabilità pratese, che di stabile da qualche anno non c’è più nemmeno il sistema industriale del tessile.
Io c’ero quando ragazzino guardavo curioso i grandi che discutevano della stabilità, di quei passi strategici che avrebbero finalmente e ufficialmente riconosciuto a Prato la sua importanza storica culturale e artistica all’interno della Regione Toscana. Sembra strano ma a Prato, a partire dalla fine degli anni ’60 fino all’inizio degli anni ‘90, ci sono stati Strehler, Ronconi, i Magazzini Criminali (Lombardi-Tiezzi), Remondi & Caporossi, e si potevano vedere spettacoli di Kantor, Brook, Stein e di altri importanti autori internazionali. Insomma, questa piccola laboriosa città toscana, che proprio in quegli anni assisteva ai primi spettacoli di Benigni e del Nuti, era viva e produceva “arte” oltre che stoffa. Tanto è vero che nel 1983 un gruppo di giovani artisti, riuniti sotto il nome di Teatro di Piazza o d’Occasione, poteva ambire a vincere e vincere con la loro opera prima il PREMIO ETI STREGAGATTO, premio riservato al teatro ragazzi. Forse “non era tutt’or quel che luccicava” però le basi erano certamente solide per consegnare alla cittadina un Teatro Stabile.
Eppure, la stabilità non è impresa facile! Problemi, invidie, necessità e volontà a volte non coincidono, a volte superano le possibilità di ogni comprensione. Viviamo in un paese che ha fatto lotte e rivoluzioni, che parla di pace, libertà ed eguaglianza, ma poi gli stessi fautori della libera circolazione della cultura sono gli stessi che la bloccano, la ingolfano, la ostacolano.
A Prato, oggi, potrebbe quindi essere arrivato il momento giusto per mettere in pratica una veloce inesorabile e stabile rivoluzione. Dopo i fasti di Castri, le intransigenze luconiane e la fugace esperienza di Paganelli, salutiamo con rispetto i dimissionari co-direttori Bertini-Sinisterra, e proviamo a immaginare una di quelle rivoluzioni che vengono dal basso, e proviamo a ridare a Prato il senso originario del termine Teatro.
Teatro è il luogo dove si ascolta, il luogo delle assemblee pubbliche, ma bisogna fare in modo che chi parla abbia veramente qualcosa da dire. Teatro è il luogo del cuore, delle emozioni, della carne e del sudore, e lo si deve far vivere. Il teatro, oggi più che mai, deve riaffacciarsi verso la città, raccontarla, anche drammaturgicamente, in tutte le sue sfaccettature e complessità, ormai globali. La comunità cinese, quella africana, gli albanesi, i rumeni, i pakistani sono una presenza visiva forte per chi passeggia nel centro di Prato. Ma soprattutto un teatro nel XXI secolo è una struttura complessa che deve essere gestita con efficienza ed efficacia da personale competente e qualificato, che deve rapportarsi con la tradizione e contemporaneamente con la ricerca, che deve salvaguardare il potenziale del proprio territorio e al tempo stesso proiettarsi oltre i confini regionali e nazionali. Insomma un teatro è un organismo vivido e politico, perché l’arte siamo noi stessi, ci rispecchia e ci permette di andare oltre.
Presidente, su dunque, renda effettiva quella rivoluzione che si trova, forse involontariamente, a dover guidare. Riguardo alla scelta del nuovo direttore?
Niente di più semplice!
1. Deve essere disposto a esserci fisicamente, perché il teatro lo rappresenta e lui rappresenta la struttura. Non deve solo produrre il suo spettacolo e il resto è silenzio.
2. Deve essere disposto a vivere la città, perché il teatro è il suo cuore.
3. Deve saper proseguire i progetti ottimi che pongono la città all’avanguardia, come il Festival Contemporanea, che rappresenta una vetrina internazionale di ampio respiro.
4. Deve interessarsi al territorio provinciale e comunale, riallacciando un tessuto formativo capillare che ha contraddistinto Prato negli ultimi decenni del 1900.
5. Deve essere in grado di dialogare con il circuito nazionale e internazionale del teatro.
6. Deve conoscere Prato e la sua realtà.
Finisco la lettera, mentre scende la notte, restando nel vago, per chissà magari un domani scendere nel dettaglio, se la luna me lo consiglierà… e dono un pensiero che qualche tempo fa… nella selva Lacandona proprio il Sub Comandante Marcos mi disse:
“Non vale la pena fare la rivoluzione, ma in un preciso momento della nostra vita dovremmo almeno tentare di rivoluzionare noi stessi”.
L'inventore di Arlecchino
Siro Ferrone racconta Tristano Martinelli
di Oliviero Ponte di Pino

Arlecchino, il bel libro di Siro Ferrone, è in apparenza più fedele al suo sottotitolo, Vita e avventure di Tristano Martinelli attore, che al titolo. E’ infatti la biografia d’un attore, di un grandissimo attore, nato nelle campagne vicino a Mantova e poi apprezzato, amato e protetto dai più potenti sovrani d’Europa.
Fin dall’inizio Ferrone spiega chiaramente che non si occuperà più di tanto delle radici mitologico-folclorico-etimologiche della maschera più celebre, e nemmeno delle sue successive evoluzioni sui palcoscenici di tutto il mondo. Tuttavia il titolo del saggio di Ferrone è quanto mai pertinente: perché anche se “Arlecchino non può esibire un testo che certifichi la sua nascita (...) a inventarlo fu un attore del secolo XVI, Tristano Martinelli”.
Prima di lui ci furono gli “zanni”, naturalmente, che continueranno a esistere anche dopo di lui, ma all’interno di questa tradizione, con una serie di “invenzioni” (o di “trasgressioni”, a cominciare dall’abbandono della “Bergamascha lingua”), Martinelli riuscì a distinguersi “come primus inter pares”. Soprattutto, seppe far emergere - a tutto suo vantaggio - una maschera e soprattutto un nome che “era stato per molto tempo un borborigmo, un balbettamento che circolava (...) soprattutto nelle favole e nei riti pagani della Francia e dell’Europa del Nord”. Sulla scia del suo straordinario successo, dopo di lui arrivarono altri famosi Arlecchini, a partire da Dominique Biancolelli, per arruvare fino a noi con Moretti e Soleri. Ma, appunto, arrivarono tutti dopo di lui, il primo Arlecchino riconosciuto come tale: “un perdente di classe che dalla sua condizione di inferiorità (maldestro guerriero, stonato cantante, amante tradito, marito cornuto, osceno ruffiano) seppe ricavare la delega a rappresentante principe della nazione comica italiana” (p. 88).
Ferrone segue passo passo questa invenzione, sia nella rete dei segni su cui lavorò Martinelli, sia nelle motivazioni che lo portarono a quello che fu, senz’altro, un vero colpo di genio, che infiammò all’istante il pubblico di Parigi, con immediato contorno polemico. Grazie anche, va aggiunto, a “una sottile strategia pubblicitaria” (p. 88) a opera di Tristano e del fratello Drusiano, con meccanismi di sorprendente modernità. E’ un vero piacere seguire i tortuosi percorsi di questo avventuriero del teatro, le sue astuzie e le sue bassezze, le sue ambizioni e le sue astuzie di guitto. Pagina dopo pagina, sulla base di una ampia documentazione però sempre distillata in forma di godibile racconto, vediamo Martinelli imporsi alla corte dei Gonzaga, anche come supervisore e gabelliere dei suoi meno fortunati colleghi; per poi partire in cerca d’avventure e di fortuna con la sua scalcagnata troupe verso il Nord, per approdare ad Anversa, Londra, Vienna e Madrid, e naturalmente soprattutto a Parigi, che sarà il teatro dei suoi massimi trionfi ma anche la levatrice della sua immortale creazione.
Ma tutto questo è meglio lasciarlo al piacere della lettura, pagina dopo pagina, in quella che assume spesso i toni di un’avventura, sempre in bilico tra le piazze dove si esibivano i cantimbanchi e le splendide corti dove il nostro eroe aveva grandissimi fan, a cominciare da Maria de’ Medici. Perché al di là romanzo picaresco, il saggio di Ferrone offre anche altri spunti di riflessione, a cominciare da un approccio esplicitamente biografico a un episodio chiave della storia del teatro: privilegia infatti l’attenzione alla parabola individuale rispetto alla storia degli archetipi (e Arlecchino è anche questo) e ai tempi lunghi dell’analisi dei miti, così come alla ricostruzione di un orizzonte comune, dove le singole parabole trovano senso solo nella rete di relazioni e trasformazioni storiche (anche se ovviamente tutti questi elementi continuano a fornire lo sfondo da cui far risaltare, come a contrasto, il protagonista; anche se Ferrone preferisce nell’occasione attingere a studi più focalizzati, come quelli di Sara Mamone e Delia Gambelli).
Questo Arlecchino preferisce concentrarsi sul nodo tra la creatività personale e un’arte collettiva come il teatro (e ovviamente nel collettivo teatrale entrano anche il pubblico e gli sponsor-protettori-mecenati). Nel contrasto tra l’invenzione individuale e la tradizione. E lo fa in un terreno storiografico come questo, dove si sono accumulate letture molto diverse, dalle grandi sintesi (a volte semplificatrici) come quelle di D’Ancona e di Allardice Nicoll alle raccolte di copioni, materiali e documenti sulle compagnie dei comici raccolte e pubblicate degli scorsi decenni - anche dallo stesso Ferrone, per Mursia, Einaudi e Le Lettere - e che hanno cambiato la nostra lettura della Commedia dell’Arte (ma privilegiando appunto “il movimento”, la tendenza, rispetto ai singoli).
La figura di Martinelli assume così un rilievo esemplare, sospesa com’è tra il vecchio e il nuovo. Da un lato l’attore mantovano pare profondamente radicato nella tradizione dei guitti poveri e scalcagnati, e dunque molto lontano dalle ambizioni impresariali e dalle velleità di riscatto culturale letterario che già allora infiammavano le velleità di molti suoi colleghi (proprio da questa volontà di riscatto parte del resto una della rare frecciate polemiche di Ferrone, contro gli innominati - e non citati - professori che “danno l’impressione di voler correggere i colleghi moralisti e fingono di vedere” in certi attori “ qualcosa di più, qualcosa che non furono e che a loro - i professori -, non si capisce perché, piace di più”, p. 120).
Dall’altro Martinelli incarna ancora, per molti aspetti, il ruolo del buffone di corte: basti pensare ai suoi rapporti “alla pari” con principi e sovrani, che facevano a gara per far da padrino ai suoi numerosi figli, e alle spassose missive che inviava loro (nella speranza, spesso soddisfatta, di doni preziosi).
Insomma, un solitario, per certi aspetti ancorato a tradizioni e realtà superate, ormai avviate al tramonto da una nuova situazione politica, da nuove esigenze artistiche e da una nuova organizzazione delle compagnie: e proprio in questa frizione, suggerisce Ferrone, esplode l’invenzione di uno dei rari miti moderni. Schiacciato tra arcaismi e spinte modernizzatrici, Marrtinelli si ritaglia un suo ruolo. Con molte ambiguità, sia chiaro: perché emerge il ritratto di un uomo forse più furbo che simpatico, attentissimo a curare i propri interessi dopo decenni di miseria, con una scarsa solidarietà per i suoi colleghi - che peraltro spesso lo guardavano dall’alto in basso.

Siro Ferrone, Arlecchino. Vita e avventure di Tristano Martinelli attore, Laterza, Roma-Bari, 2006.
Tra gli altri volumi indicati nell’articolo sono disponibili:
Siro Ferrone (a cura di), Commedie dell’Arte, 2 voll., Mursia, Milano, 1985-86.
Siro Ferrone, Attori mercanti e corsari. La Commedia dell’Arte in Europa tra Cinque e Seicento, Einaudi, Torino, 1993.
Siro Ferrone (direzione), Comici dell’Arte. Corrispondenze. G.B. Andreini, N. Barbieri, P.M. Cecchini, S. Fiorillo, T. Martinelli, F. Scala, a cura di C. Buttarelli, D. Landolfi, A. Zinanni, 2 voll., Le Lettere, Firenze, 1993.
Delia Gambelli, Arlecchino a Parigi. Dall’Inferno alla corte del Re Sole, 2 voll., Bulzoni, Roma, 1993.
Sara Mamone, Firenze e Parigi, due capitali dello spettacolo per una regina, Maria de’ Medici, Silvana Editrice, Milano, 1989.
Allardice Nicoll, Il mondo di Arlecchino, Bompiani, Milano, 1965.
Naira González: autoriratto dell'attrice da giovane
Il saggio di Editoria&Spettacolo
di Fernando Marchiori
Ho conosciuto Naira González al suo arrivo in Italia insieme a César Brie. Usciti dall’Odin Teatret, giravano con un Romeo e Giulietta che lasciava a bocca aperta e già tiravano la cinghia risparmiando fino all’ultima lira per quel Teatro de los Andes che avrebbero fondato, di lì a poco, in Bolivia. “Noi non parliamo dei nostri spettacoli”, mise subito in chiaro César quando mi presentai, alla fine di una replica al Festival di Santarcangelo. Poi cominciammo a parlarne e da allora non abbiamo mai smesso. Naira rimase invece più evasiva, per sua natura o per fedeltà a un rigore appreso in Danimarca. O forse era solo molto giovane e in balia di vicende artistiche ed esistenziali che neppure le sicurezze tecniche dell’enfant prodige potevano farle comprendere a pieno. A diciannove anni può capitare di scoprire il teatro. A quell’età lei aveva già un’esperienza di tre lustri che ne faceva un piccolo mito tra i giovani attori. Ma era pur sempre una ragazza. E “quello spettacolo – leggo ora nella bella monografia che le edizioni Editoria&Spettacolo le dedicano – era una lettera indirizzata all’Odin scritta da un’adolescente disperata. È stato il gesto d’amore di un uomo innamorato a darle voce. In fondo il teatro è questo: tante lettere d’amore”.
Con questo sguardo finalmente distanziato e lucido, ma anche con la consueta ed energica ironia, Naira risponde a tutte le domande che Veronica Tinnirello ha saputo rivolgerle in una conversazione viva, veloce eppure ricca di riferimenti a personaggi e situazioni non comuni: l’infanzia strappata tra il nomadismo artistico del padre e la militanza politica di una madre troppo presto desaparecida, il magistero di Iben Nagel Rasmussen, il sodalizio con César Brie, il carisma di Eugenio Barba, il teatro sull’altopiano boliviano e nei centri sociali in Italia, i seminari per giovanissimi aspiranti attori e quelli nelle carceri, le tournée internazionali e i piccoli interventi di teatro nelle osterie veneziane, fino al recente ritiro in Umbria con Massimiliano Donato in una casa-teatro che ospita workshop residenziali e produce spettacoli defilati e intensi in un contesto creato apposta “perché l’anima non venga distratta”.
Emerge così un ritratto dell’artista da giovane e insieme il profilo tenace di una donna che il teatro ce l’ha nel sangue e che non smette di spargere il contagio, di mostrare che si può diventare “maestri di se stessi”, a patto che si sappia “scacciare tutti i fantasmi che abbiamo dentro e fare uno sforzo per buttar giù le pareti e vedere chi c’è dall’altra parte e ascoltarlo senza pregiudizi”.
Come i figli d’arte delle compagnie di giro d’un tempo, anche Naira González debutta bambina, a quattro anni, e cresce in quello spazio indefinito dove il mondo reale si confonde con i colori della scena e il vagabondaggio teatrale percorre i margini delle comunità umane. Eleonora Duse a quell’età era un’impaurita Cosetta nei Miserabili di Victor Hugo. Naira si traveste da animaletto in uno spettacolo del Teatro Runa diretto da suo padre. Il burattinaio argentino Edgar Darío González, uno dei primi esempi di teatro non folklorico nella Bolivia degli anni Settanta, girava allora i pueblos boliviani, “luoghi sperduti, paesini poverissimi e polverosi con grandi teatri all’italiana lasciati dai colonizzatori a beffarsi della miseria. La maggior parte cadeva a pezzi …. Se teatri non ce n’erano allora allestivamo la scena all’aperto, anche fuori dalle miniere. I lavoratori correvano per vederci con i loro sacchi di carbone come poltrone”. Un gioco e un apprendistato che per anni la vedrà accanto al padre, anche dopo la scomparsa della madre in Argentina, vittima delle repressioni del regime militare.
Incalzante ma leggera, generosa nel lasciare sempre spazio alla voce di Naira ma a tratti complice e mimetica, la curatrice del volumetto ha trovato tono e ritmo giusti per far parlare un’artista comunque restia a “spiegare” i suoi spettacoli, a raccontare quelli cui ha partecipato. Un’interlocutrice che anche quando si lascia andare all’aneddoto sembra sfuggire o sfidare, che rilancia con risposte interrogative o enigmatiche. Eppure sa farci sentire le bocche impastate di polvere nelle tournée boliviane, la magia degli anni danesi con la scoperta delle proprie potenzialità attorali, l’unicità di esperienze teatrali ormai storiche. Ecco allora il celebre Talabot dell’Odin rivisto in una carrellata di immagini, quasi un rimontaggio personale attraverso le figure rimaste impresse nella sua memoria. Ecco il colorato e divertente Colón del Teatro de los Andes. Ma anche l’importanza del proprio lavoro di attrice e regista che ha voluto mettersi in disparte, tacere a lungo, cercare la propria strada. Perché Naira González vive di teatro ma può stare anni senza andare in scena. Negli ambienti teatrali tutti la conoscono, ma lei rimane rigorosamente estranea ai circuiti produttivi e distributivi istituzionali. Dopo le esperienze di Holstebro e Yotala, ha diretto a Venezia un proprio gruppo, Il cervo disertore, con il quale ha verificato vocazioni e obiettivi teatrali nei contesti più disparati, sempre cercando il contatto diretto con gli spettatori in situazioni non formali. Sono nati così spettacoli come Figli senza padri e Pediluvio. La vocazione pedagogica – eredità paterna messa a fuoco nelle esperienze europee e latinoamericane – l’ha portata a confrontarsi ben presto con attori e attrici spesso poco più giovani di lei, riuscendo anche perciò a instaurare relazioni artistiche e scambi umani, prima che professionali, di forte presa. Senza mai dimenticare che i giovani hanno bisogno di raccontarsi, che “non possono imporre un nome alle cose, ma si muovono soltanto con la forza dell’odio e dell’amore”.
Mentre cresceva l’idea dell’impresa umbra – un rudere con una chiesetta che, restaurata in proprio, è diventata la sala prove della compagnia – è nato un intenso lavoro su Pasolini che vedeva Massimiliano Donato dare corpo a un inquietante e angelico transessuale (Il fiore dell’orgia). Il ritorno in scena di Naira come attrice è invece più recente: Kronos Gelato. 331 modi di fermare il tempo debutta a Venezia nell’occasione di un omaggio della Biennale a Carmelo Bene e oggi può capitare di trovarlo in qualche coraggiosa rassegna periferica. Raccontandone la genesi, a partire da un testo di Luca Clabot, Naira ammette un’eredità che continua a sorprenderla, come se non avesse mai lasciato l’Odin, e riconoscibile nelle azioni fisiche e vocali, nel training, nel lavoro di montaggio sulle improvvisazioni, nell’avanzamento per metafore lungo il processo di scrittura scenica, nella violazione di quella stessa scena tanto precisamente definita, nel graffio che ne squarcia la visione (“Sì, alla fine lo spazio dev’essere sporco, ribelle”).
Ma la nuova consapevolezza dello straordinario percorso vissuto, la freschezza con la quale Naira continua a cercare il proprio teatro, nonché la sempre più intensa attività negli spazi del Centro Teatrale Umbro (sono centinaia i ragazzi che accorrono ai periodici seminari sulla scena e sulla voce) fanno presagire nuove strade per questa artista ostinata e indipendente, che sa usare e trasmettere le tecniche, e sa anche che non bastano, perché “una verticale a testa in giù possono farla cani e porci, ma per farla con coscienza bisogna prima di tutto avere un profondo desiderio di capovolgere la testa!”
Il taccuino di un'attrice in cerca della sua voce
Pietre d'acqua di Julia Varley, Ubulibri, Milano, 2006
di Fernando Marchiori
Pietre d’acqua di Julia Varley (Ubulibri 2006) è un libro consigliabile a chi si avvicina ai manuali di antropologia teatrale e rischia di credere di aver capito. Non solo ci offre una interessante declinazione personale (femminile) del lessico familiare all’Odin Teatret, all’ISTA e a una galassia di studi ormai canonici, ma soprattutto ci mette di fronte all’evidenza di una comprensione e di un sapere che precedono e trascendono la loro stessa – fondamentale e sempre insufficiente – fissazione nei libri. Come nei seminari, nei quali
“i principi che all’Odin Teatret sono incorporati implicitamente in tempi lunghissimi (…) sono spiegati, analizzati ed esemplificati in poche ore”,
anche nei manuali si rischia infatti di leggere delle conclusioni come se fossero i presupposti di un lavoro che è fatto invece di ricerca ed esperienza concrete. Mentre conferma l’importanza del lavoro dell’Odin Teatret nella definizione di un linguaggio comune per saldare la teoresi e la pratica teatrale, questo “taccuino di un’attrice” è dunque anche un utile monito per coloro che scambiano lo studio di principi e tecniche per il “metodo Barba”, e insieme rappresenta un tentativo di salvaguardare ciò che sempre si perde nel passaggio dalla pratica tacita e lenta, dall’esercizio dell’intelligenza del corpo, alla comprensione meramente intellettuale di elementi tecnici.

L’autrice racconta prima un’iniziazione al teatro ancora immerso nel mondo “dell’ideologia e dell’entusiasmo disarmato”, poi il lungo, faticoso e in un certo senso sempre incompiuto apprendistato nell’Odin Teatret, dove ha dovuto “imparare a pensare con il corpo per esistere come attrice”. Qui dapprima la crisi:
“Avevo scelto il teatro come modo di dire no, per essere ribelle attraverso l’azione (…) All’Odin Teatret avevo scoperto che non sapevo cosa fosse realmente un’azione”.
Poi l’“adozione” da parte di Tage Larsen, l’apprendimento del training come se fosse “una forma di preghiera pratica”, il “samurai” insegnato da Iben Nagel Rasmussen, le figure del mimo studiate con Ingemar Lindh, i trampoli, l’acrobatica, il lungo lavoro sulla sua voce fragile e insicura. Nel definire la propria drammaturgia d’attrice, Julia Varley ne rinomina il livello dinamico come “presenza”, quello narrativo come interpretazione del tema, del testo e del personaggio, e quello evocativo come “universo personale fatto di necessità e rigore, di immaginazione impulsività”. Associazioni, equivalenze, organicità, opposizioni, improvvisazione e composizione, azioni fisiche e azioni vocali, montaggio ed elaborazione: sono concetti e procedimenti che l’autrice affronta sempre cercando di assecondare il “pensiero del corpo”, il corpo pensante che dev’essere lasciato decidere da sé. Anche l’azione più astratta
“è concreta nel pensiero dei piedi e nel respiro delle cellule. È il risultato di una reazione a qualcosa che sento e conosco, ma sono incapace di parafrasare in figure”.
Nel “micro-laboratorio” che è oggi il training per Julia Varley – zona non pubblica di ricerca, archivio personale e “intercapedine di indipendenza dal regista” e dagli obiettivi dell’Odin – l’attrice lavora in autonomia senza sapere dove andrà a parare, “ma consapevole che sto piantando i primi semi del bisogno di fare un nuovo spettacolo di cui ignoro tutto”. Può nutrirsi del paragone con la pittura o della ricerca vocale. Può tradurre in azioni fisiche un testo, trasformare in azioni vocali una partitura fisica e persino fissare una partitura vocale che serva da sottotesto. Cuore dell’azione è il torso, come nelle sculture di Rodin. È lì quel nodo senza il quale l’azione non esiste, ma non si vede, scorre, è fatto di tensioni in movimento. Mentre improvvisa e crea materiali ha completa libertà e totale fiducia da parte del regista. Poi è con quei materiali che il regista improvviserà a sua volta.

Le pagine dedicate al montaggio e al rapporto dell’attrice con Barba sono tra le più interessanti del libro, proprio perché svelano una prospettiva differente sulle varie fasi di lavoro, compresa quella più dura, “quando Eugenio abbandona il punto di vista dell’attrice per passare dalla parte dello spettatore”. È un grande potere quello del regista, che la Julia Varley conosce bene, sia per un rapporto di incontro-scontro con Barba che dura da trent’anni – è interprete di tutti gli spettacoli da Anabasi in poi – sia perché è lei stessa a sua volta creatrice di assoli e dimostrazioni.
Certamente il libro sarà utile, come si augura l’autrice, “a un’attrice in cerca della sua voce” anche perché è un esempio di storiografia al femminile. Uno sforzo riuscito proprio perché la ricerca di un atteggiamento, di un procedere nuovo che sia anche un discorso di gender, non si riduce mai ad antagonismo pregiudiziale o a polemica rivendicativa. È in realtà una ricerca aperta e concreta. Cioè ancora una volta più praticata (nella scrittura) che teorizzata. Fin dalla scelta del sostantivo femminile “attrice” per parlare anche del mestiere in generale, sovvertendo così “l’uso corrente di includere il femminile nel maschile universale”. Una scelta che potrebbe condizionare pesantemente lo stile ma che invece è risolta con delicatezza e dichiarata come un semplice contributo al riconoscimento del ruolo delle donne all’interno di quella “storia che danza” che è la storia della professione teatrale. Dare volto e voce a persone apparentemente anonime è uno degli obiettivi per i quali Julia Varley ha dato alle stampe questi suoi taccuini d’attrice. E lo raggiunge senza mai perdere di vista le relazioni, così importanti per le donne di teatro, che spesso
“trovano più soddisfazione nel partecipare a un progetto comune che nel vedere il proprio nome stampato su un libro”.
Ecco allora gli interessanti richiami al lavoro di The Magdalena Project, un’iniziativa di donne di teatro fondata da Jill Greenhalgh che organizza festival, esperienze seminariali, approfondimenti teorici. Ecco una galleria di veloci e intensi ritratti di artiste scontornati con decisa sensibilità politica: il coraggio della cilena María Canepa, impegnata dopo il golpe del 1973 nelle poblaciones di Santiago in “corsi di dizione” che davano occasioni e strumenti alle donne di quei quartieri popolari di prendere la parola in pubblico; la magia di Zofia Kalinska, collaboratrice di Kantor in Polonia; la grande maestra di danza Odissi Sanjukta Panigrahi, che “danzava sulla scena e nella vita come una bambina e un guerriero”; la cubana Flora Lauten che continua, nonostante le difficoltà materiali, a dirigere il Teatro Buendía in una chiesa ortodossa sconsacrata all’Avana; Patricia Ariza, regista e attrice del Teatro La Candelaria, che in Colombia ha lavorato con prostitute, bambini di strada, mendicanti, e coordina un’associazione di artisti per la pace. E naturalmente Iben Nagel Rasmussen, la cui straordinaria attenzione alla pedagogia teatrale l’ha ormai resa vera e propria “capostipite di una tradizione” i cui esiti sono disseminati nel mondo.
La Hollywood della Brianza, naturalmente
Digital reality a Busto Arsizio
di Perfida de Perfidis
Anzi, di più! La Brianza cinematografica dev’essere più moderna dei vecchi e antiquati Studios! La meraviglia sono gli effetti speciali, il futuro è nel digitale, il cinema è già nel virtuale! Altro che Hollywood in Brianza, il varesotto deve diventare la Sylicon Valley europea... Ecco, bella idea: perché non facciamo concorrenza alla Dreamworks di Steven Spielberg, tra Busto Arsizio e Milano 2?
Che ci vuole? Che ci serve?
Prendiamo un giovane regista di belle speranze. Si chiama Dario Picciau, ha trent’anni, si è formato come graphic designer, adesso è impegnato a esplorare le nuove tecnologie applicate al cinema, è autore del primo lungometraggio italiano completamente realizzato in 3D, insieme classico e moderno: "Il ritmo narrativo dell’Uovo, la caratterizzazione e l’animazione dei personaggi sono simili a quelli del teatro greco antico. I personaggi esprimono i grandi valori che sono alla base della morale umana e contemporaneamente incarnano altrettanti enigmi. Sono esseri enigmatici posti al centro di un flusso di eventi che li superano, li mettono alla prova, misurano la loro consistenza. Ognuno si trova, nel proprio ruolo, di fronte a un bivio e a volte — come nella tragedia greca — il bene ha l’aspetto del male o viceversa". Nel 2003 L’uovo ha vinto persino qualche premio. Molto prestigioso, naturalmente.
Poi prendiamo un produttore volonteroso, con gli agganci giusti e molte buone intenzioni. Si chiama Andrea Jarach, ha cinquant’anni, è presidente dell’associazione Italia-Israele, oltre che proprietario della casa editrice Proedi che ha curato numerose pubblicazioni sulla Shoah: si è dunque lodevolmente impegnato a far conoscere gli orrori dell’Olocausto e a combattere l’antisemitismo (nel maggio 2006 si candiderà tra mille polemiche al Consiglio comunale di Milano nella lista di Letizia Moratti, senza essere eletto, ma questa è un’altra storia).
Poi ci vuole un’idea, naturalmente. Ed è l’idea perfetta. Ci faranno vedere "Anne Frank viva, con il suo viso". Tutto grazie alle nuove tecniche digitali, naturalmente: "Poiché non c’è più Anna Frank e non c’è più la Amsterdam dove era nascosta, quella degli anni Quaranta, vogliamo ricostruirla fedelmente, al millesimo, con le nuove tecniche digitali che in questo momento mi sembrano lo strumento ideale per comunicare", spiega Picciau. "Non per produrre meraviglia ma dare anche un messaggio di ricordo, forse di speranza". Per gli effetti speciali, il modello sarà Polar Express, il film con Tom Hanks, ma naturalmente Cara Anna sarà ancora meglio, naturalmente, perché sono passati due anni e sono stati fatti notevoli progressi.
Per fare questo tutto questo, naturalmente, non basta la buona volontà di un artista di genio: ci vogliono collaboratori di prima qualità. La casa di produzione, che si chiama 263Films (la sigla rimanda all’appartamento-rifugio di Anna Frank ad Amsterdam), raccoglierà decine di persone da tutto il mondo. Quanti? Diciamo tra gli 80 e il 40. Alcuni di loro, specifica Picciau, "hanno già lavorato a progetti di case ben più conosciute, per pellicole come Il Grinch e Alien". Anzi, meglio: nei curriculum si va "da Star Wars a Harry Potter", naturalmente.
Ma c’è qualcosa in più: l’emozione. La storia della giovane bambina ebrea e della sua famiglia perseguitata dai nazisti si intreccia nella pellicola (anzi, nei pixel) con quella di un altro personaggio. Sarà, spiegano, una narrazione poetica che si svolge nel chiuso di quattro mura, raccontando in maniera "sincronica" due storie tra loro molto diverse.
Perché, come spiega lo sceneggiatore Roberto Malini, abituale collaboratore di Picciau, "vogliamo un pubblico di giovani, che impari il valore positivo della memoria, non solo un film di effetti speciali. Abbiamo fatto una lunga e meticolosa ricerca storica con immagini, documenti, testimonianze: sarà come un museo in movimento pieno di citazioni visive. L’idea non è quella del remake del Diario (forse c’è stato un problema di diritti), ma di iniziare la storia di Anna oggi in America, a cavallo tra due mondi con una ragazza malata di leucemia che si chiama Emily ed è costruita sulle fattezze della poetessa Dickinson. Con il regalo del Diario Emily fa un viaggio fantasy e le due giovani si incrociano nei loro infelici destini, poi si torna nel reale". Le due storie continuano parallelamente fino a intrecciarsi: "Anna guarda dalla finestra i bombardamenti su Amsterdam e Emily guarda col padre i fuochi d'artificio", rivela il regista, "finché i due periodi si fondono fino a incontrarsi. E' un esempio di sincronicità jungiana", naturalmente.
Alla fine "Emily riesce a sopravvivere grazie alla lettura del Diario che, dunque, è ancora in grado di donare speranza, confortare chi soffre e ricordare a tutti che dalla discriminazione, dal pregiudizio e dall'odio nascono solo morte e distruzione".
Non mancano altre citazioni colte: oltre a Emily Dickinson, anche Oscar Schindler e Helga Deen, autrice di un diario scritto nel campo di concentramento di Vugh in Olanda e uccisa a 18 anni. Per il trailer, si vanterà Picciau, "abbiamo utilizzato le luci di un quadro di Jan Vermeer". Naturalmente.
Infine ci vogliono i soldi. Molti soldi, naturalmente. Ma il progetto è inattaccabile, non può non affascinare, gli ingredienti ci sono tutti: un grande personaggio (anzi, due), una storia commovente, un tema importante e politicamente corretto, la pulsione pedagogica, le nuove frontiere dell’arte e della tecnologia, un giovane genio, il matrimonio degli effetti speciali made in Usa con la capacità italiana di creare emozioni, la fondazione di un nuovo polo creativo e tecnologico italiano...
Così alla 263Films arrivano più o meno 10 milioni di euro, da investitori etici e dal Ministero dei Beni Culturali italiano, che ha ammesso l’opera al finanziamento pubblico in virtù del suo valore artistico.
Ora Cara Anna può finalmente decollare. Con grandi squilli di trombe, naturalmente.

Il ministro Urbani e le autorità locali all’inaugurazione della 263Films.
Il 25 gennaio 2005 a inaugurare il nuovo studio della 263Films al Museo del tessile di Busto Arsizio arrivano addirittura il ministro della cultura Giuliano Urbani, l’Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Regione Lombardia Ettore Albertoni, l’Assessore della Provincia di Varese Roberto Bosco, il sindaco di Busto Arsizio Luigi Rosa e il suo Assessore alla cultura Alberto Armiraglio, circondati da un codazzo di decine di fotografi e giornalisti (ne parleranno entusiasti al Tg3, usciranno servizi su molte importanti testate e sul web, la tv svizzera ci farà addirittura un documentario).

Il set di Cara Anna.
Dopo il rituale taglio del nastro e i flash dei fotografi, il ministro Urbani entra nella Stanza delle Meraviglie dei Raptor Studios: è popolata solo da tre attori in calzamaglia nera ricoperti da sensori mentre là in fondo decine di operatori sono affaccendati sui loro computer. E’ uno dei set che cercano di ricostruire nel modo più fedele assoluto la stanza segreta di Anne Frank.

Picciau spiega al ministro Urbani e alle autorità locali i segreti della motion capture.
«Qui a Busto», prosegue Picciau, «realizzeremo circa il 35% della pellicola, tra motion capture e data post processing».
Del resto la città è sede del BAFF, ovvero il B.A. Film Festival... E non mancano, come precisa il sito della rassegna, le "Personalità legate al mondo del cinema che sono nate, vivono o hanno vissuto a Busto Arsizio e dintorni: Rita Rusic, produttrice, Mariella Lotti, attrice, Anita Caprioli, attrice, Luigi Cozzi (in arte, Lewis Coates), regista, Alberto Sironi, regista, Gilberto Squizzato, regista, Max Croci, regista, Giorgio Bonecchi Borgazzi, regista, Giacomo Poretti, attore (di Aldo, Giovanni e Giacomo)". Un elenco impressionante, naturalmente.
Poi Picciau spiega al Ministro i miracoli della nuova tecnica cinematografica: "Con la motion picture si mettono 72-75 sensori sul volto e sul corpo dell’attore, fissandone i movimenti, ricopiando tutto, dai pori della pelle alle sopracciglia, la struttura ossea e quella molecolare del viso per prendere tutti i dettagli le espressioni possibili. Poi si registra tutto con una camera a raggi infrarossi, così trasferendo la realtà nel computer con tecnica digitale". Naturalmente. (Una delle società che fornisce supporto tecnologico per la motion capture è la Vicon, specializzata in sistemi di sorveglianza.)
Prima di iniziare il film vero e proprio, c’è stato più di un anno di prelavorazione, durante il quale si è fatta una ricerca per ricreare nel modo più fedele possibile i luoghi in cui ha vissuto Anne. Tutto è stato riprodotto nei minimi particolari, dalle mura della casa segreta alla lampada che teneva sulla scrivania. Questo lavoro, spiegano al ministro, ha permesso di ricostruire nella maniera più fedele l’alloggio segreto usato dalla famiglia Frank per nascondersi dai nazisti. "E per Anne", prosegue Picciau, "abbiamo usato la foto più recente disponibile, perché non si hanno immagini di lei da quando è entrata nell’appartamento segreto". Però nel virtuale sanno perfino far invecchiare i personaggi, e così alla fine del film la bambina Anna diventerà una giovane donna.
I toni sono trionfalistici. Si proclama che è l’occasione d’oro per Busto e per il cinema italiano. Anche se non presenta i budget esorbitanti delle produzioni americane il film ha un livello tecnico in grado di far tremare Disney e Dreamworks e una trama emozionante. Cara Anna promette di riempire le sale per settembre 2006. E la distribuzione mondiale? "Sicuramente", confessa Picciau, "abbiamo già il distributore, anche se non posso dire ancora il nome…". Naturalmente.
Passano pochi mesi e il 4 settembre 2005 Dear Anne viene presentato in anteprima mondiale, nell’ambito della conferenza sul cinema digitale del Future Film Festival, alla 62a Mostra del Cinema di Venezia. La trionfale conferenza stampa è ospitata alla Villa degli Autori al Lido. In effetti Picciau e Jarach non presentano il prodotto finito, ma un teaser-trailer di pochi minuti. E’ un successone, naturalmente. Si commuove per primo Carlo Rambaldi, il mago italiano degli effetti speciali, tre Premi Oscar, fino a ieri nemico giurato del computer: "Ho pensato più volte di utilizzare le nuove tecnologie del cinema tridimensionale per dare vita a mondi immaginari e creature fantastiche: i nipoti di E.T. e degli alieni di Incontri ravvicinati del terzo tipo. Fino a ieri, però, non ho mai trovato nelle soluzione proposte dagli effetti speciali una verosimiglianza sufficiente e soprattutto ho constatato che il computer toglie poesia al cinema. Poi ho visto, nel corso di una conferenza dedicata agli effetti speciali nel cinema, le prime immagini del film di Dario Picciau, Dear Anne. Ho provato un tale entusiasmo che ho esclamato davanti all’auditorio: ‘Adesso sì. Adesso siamo vicini alla perfezione!’. E’ una nuova era per gli effetti speciali e per il cinema che ne fa uso".
Si commuove anche Nedo Fiano, scrittore ed educatore sopravvissuto ad Auschwitz: "Sembra di tornare indietro nel tempo, fino a rivedere una realtà che in troppi hanno dimenticato. Dear Anne supera le frontiere del tempo e dello spazio per restituire al mondo una verità fondamentale per costruire un futuro migliore".
La 263 Films e il Future Film Festival decidono di dedicare il teaser-trailer alla memoria di Giuseppe Jona, l’eroico presidente della comunità ebraica di Venezia che nel 1943 sacrificò la propria vita per evitare la deportazione agli ebrei della sua città.
Nel frattempo il progetto ha ottenuto il riconoscimento della Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, il patrocinio e il sostegno scientifico di Yad Vashem e del Ghetto Fighter's House Museum: attestati di prestigio riservati a poche opere della cultura contemporanea.
Nei primi mesi del 2006 arrivano nuove informazioni sulla lavorazione, subito riprese dalla stampa e da internet. Cara Anna è più di un film, è un miracolo: "Il miracolo è portarci indietro nel tempo con questa artigianale bottega rinascimentale di cinema. Ogni millimetro del passato ci riappare identico a com’era e questo è il nostro fine artistico e morale, tanto che abbiamo voluto un viaggio immaginario nel tempo, l’incontro parallelo emotivo di due ragazze che sono, come gli altri, due attrici di teatro, Sabia del Mare (Emily) e Martina Segre (Anne), 24 e 21 anni, che si modificano al computer. Dobbiamo sapere tutti cosa accadde veramente, ma il film si ferma all’arresto con i nazisti che arrivano nella soffitta. Tutto è stato faticoso e prodigioso, dirigere gli attori, veri o virtuali e doppiare le voci, dato che abbiamo girato in inglese, ma entusiasmante. Ma non voglio fare per sempre il cinema in grafica tridimensionale con le riprese a raggi infrarossi applicati ad attori virtuali. Credo che in futuro ci sarà spazio per tutti, ma che i due campi di ricerca resteranno separati".
Picciau approfitta dell’occasione per definire meglio il genere di Cara Anna. Non chiamatelo, per carità, cartone animato. Ma allora cos’è? Cara Anna è un digital reality, naturalmente.
L’uscita del film non è più fissata a settembre: slitta un po’, è prevista per il Natale 2006, "o al più tardi a gennaio 2007", annuncia Picciau. "Dopo due anni di produzione, e uno e mezzo di pre-produzione, siamo quasi al 70 per cento e stiamo valutando il miglior distributore. Vogliamo che ci si concentri sul messaggio e non sul fatto che è tecnologicamente avanzato, altrimenti rischiamo di penalizzare il messaggio di speranza e di memoria".
Nell’autunno 2006 a Roma Walter Veltroni lancia la Festa Internazionale del Cinema, Naturalmente Cara Anna non può bucare il grande evento. Infatti è in programma, il 19 ottobre. L’uscita è vicina, il film dovrebbe essere praticamente finito. Grande attesa.
Disattesa. Il video che viene presentato è un docu sugli autori con interviste e backstage. Del film si vedranno a malapena due minuti con molte ambientazioni esterne e una scena con i due personaggi principali, Anne e Otto, ancora però under construction, che non mostra quindi risultati definitivi.
Problemi? Gli autori dichiarano che il braccio di ferro con alcuni finanziatori di Dear Anne è stato e continua a essere una dura prova. Questa presentazione romana fa dunque parte del gioco del marketing. "Forse non ne valeva la pena", si lascia scappare Picciau, reduce da quattro notti in bianco: " Certo è andata bene, ma abbiamo lavorato due mesi e mezzo per questi dieci minuti, alla fine togliendo tempo al film. Non si può fare un backstage su un film che ancora non c’è. Ma loro volevano vedere...". Alla fine, rassicurano, il film uscirà nelle sale, a settembre 2007 sul mercato Usa e a Natale 2007 in Italia. Naturalmente.
La dichiarazione che avrebbe dovuto stupire, visto che il più quotato James Cameron - da oltre tre anni al lavoro su un film in performing capture dal titolo Avatar, simile quindi a Dear Anne - proprio nei giorni scorsi ha posticipato di oltre un anno l’uscita: ora punta all’estate del 2009. L'unica differenza è che Cameron ha un budget di 200 milioni di dollari di budget e quindi può prolungare la produzione.
E la 263Film? Ha solo una decina di milioni di euro, che non permettono ritardi perché non può contare su ulteriori finanziamenti. E allora? La soluzione italiana è molto semplice: meglio chiudere in silenzio l’intero baraccone, al più presto, mandando tutti a casa e destinando eventualmente gli avveniristici studi della Hollywood brianzola ad altre iniziative.
Cara Anna rischia di restare per sempre nel virtuale. E il digital reality? E´ quello che ha per protagonista Picciau e soci, naturalmente. E i soldi? Quelli sono finiti giù per il tubo, come la Hollywood brianzola...
 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
Amleto giù per u-tube
to tube or not to tube?
di Anna Maria Monteverdi
Il tubo è quello della rete, o meglio quello di YouTube, la piattaforma più frequentata del web diventata un fenomeno di massa senza precedenti dove caricare, scaricare e condividere liberamente video in streaming.
Scendendo giù per il tubo si trova una quantità sorprendente di materiale teatrale. Forse troppo, d’accordo, ma si scova anche qualche memorabilia digitale e qualche clip video divertente.
Hamlet: living in a box
Il box è l’interfaccia simil televisiva ormai familiare che impera su MySpace e YouTube all’insegna del broadcast yourself!
Chi fa upload? Ovviamente chiunque, basta che sia registrato: studenti alla prova finale di qualche school project, registi in erba. Per lo più si tratta di video domestici, amatoriali, di genere demenziale, magari girati con il videofonino, impostati su una micronarrazione (1 o 2 minuti al massimo), senza montaggio e senza pretese; nel migliore dei casi estratti di prove o di spettacoli. Alcuni sono invece veri e propri videoclip d'arte o creazioni di un qualche pregio. Molto spesso però si tratta di frammenti di film famosi, di serial tv o di cartoni, catturati impunemente dalla tv o da qualche canale digitale e riversati sulla pagina del proprio "profilo utente" nella speranza di finire nella playlist dei "preferiti" di qualche navigatore.

Certo la questione dei filmati con copyright resi disponibili su YouTube è stato il punto dolente dell'azienda in passato, ma siamo già a una svolta se la stessa NBC Universal ha deciso di diffondere i propri materiali proprio attraverso questo canale, visitato da più di venti milioni di navigatori.
Una semplice ricerca tematica sul motore interno sulla base delle TAG descrittive lasciate dagli stessi autori o detentori dei video ("Hamlet" o "Shakesperare Hamlet" o "theater Hamlet") una volta eliminati i commercial della marca di sigarette Hamlet e i clip dell’omonimo gruppo musicale madrileno, dà alcuni risultati esilaranti, segno dei tempi più che trasgressivi, direi blandamente dissacranti. Il principe Amleto riletto dalla giovane "my media generation" diventa Harry Potter, Schwarzenegger, un supereroe Marvel, un cantante reggae, un combattente ninja, un pirata o un samurai...

Ofelia beve birra e ha sembianze orrendamente simili a una Christina Aguilera animata in grafica 3D o a un trans. Imperano un po’ ovunque l’estetica da cartoon e da bande desinéé, ma anche il trash, il fetish, il pop.
Le citazioni dalle sit-com più famose e dal cinema di serie B si sprecano e spesso i titoli sono più divertenti dei video: l’omaggio alla pizza connection con Mafia Hamlet, alla fantascienza con Star Wars Hamlet, al genere horror con Hamlet Vampyr e ai musical con Hamlet on Ice. Il più votato è indubbiamente un Amleto in versione Simpson. HamLego è una versione realizzata in stop motion con i personaggi della Lego.

Il duello con Laerte diventa lo scontro iperuranico tra Amleto e DragonBall o Godzilla, oppure un regolamento di conti tra bande di rapper in strada, sopra i banchi della mensa scolastica o nei campi da calcio o da baseball. L’incontro di Amleto con il fantasma del padre raggiunge livelli di demenza inimmaginabili, con lenzuolame svolazzante tra le pareti del tinello di casa. Il liquido velenoso è una Seven Up in lattina versata sull’orecchio di Amleto padre, mentre questi è appoggiato sulla tazza del water.

Carmelo Bene faceva un hommelette di Hamlet, ma il palato di oggi, assuefatto ai Big Mac preferisce un Hamburger for Hamlet.
In mezzo, clip dagli Amleti di Kenneth Branagh e dalle versioni della BBS. E poi, strano ma vero, un estratto dallo spettacolo Hamlet Machine di Dominik Barbier, uno dei più complessi progetti di teatro multimediale ideato dal videomaker francese in collaborazione con Heiner Müller, prima della morte del drammaturgo della DDR.

Il tutto in un mare di spazzatura video-amletica e di pura idiozia mediatica. Roba appunto, da tirare giù per il tube.
Il teatro del futuro, il teatro della nostalgia
Grazia Toderi - Rosso Babele al PAC di Milano
di Oliviero Ponte di Pino
Dopo la fine del mondo classico e le invasioni dei barbari, come ricorda in un suo folgorante racconto Jorge Luis Borges, i teatri antichi rimasero a lungo abbandonati, finché non si perse la memoria degli spettacoli che avevano ospitato. Passarono i secoli e gli uomini iniziarono a interrogarsi sulla funzione di quelle imponenti rovine. Trovarono nei testi la parola che i greci e i latini utilizzavano per identificare quegli edifici, e capirono che “teatro” voleva dire più o meno “qualcosa da guardare”. Allora immaginarono che quegli edifici fossero come grandi teche, e che le nicchie che li ornavano venissero riempite di oggetti da esplorare e ammirare. E’ anche da questa ipotesi errata che nacque l’idea dei Teatri della Memoria (l’ha spiegato in un suo bellissimo saggio Franco Ruffini).
I teatri e gli stadi nelle videoinstallazioni di Grazia Toderi guardano invece al futuro.

Nell’immaginario dell’artista padovana hanno certamente un ruolo centrale le prime missioni extraterrestri (le astronavi che orbitano nel cielo, le passeggiate degli astronauti, la terra come un’arancia blu...) e le immagini dello spazio (i vortici delle galassie, con l’ombra dei buchi neri, e poi le foto del pianeta dal satellite, ben prima che Googlemaps le democratizzasse); ma anche i videogame, dal “primitivo” Space Invaders in poi, con i loro effetti luminosi e sonori. E poi una forma, quella dell’ellissi, dell’orbita: il loop dell’eterno ritorno, con le sue sottili e quasi impercettibili variazioni, diventa quasi l’archetipo di un altro spaziotempo, che trascende le attese della quotidianità. Questo movimento circolare (o meglio, questa variazione dinamica del cerchio) viene spesso adottato dalla telecamera, e quindi dall’osservatore, con un duplice effetto: da un lato la ripresa, spesso dall’alto o dal basso e in genere da una prospettiva insolita, distanza ed estrania l’oggetto, immergendolo in una sorta di vuoto astratto, siderale; dall’altro il movimento ritornante crea progressivamente una sorta di intimità, l’effetto di un abbraccio. Di più, combinando più di un movimento ellittico si ottengono effetti (e illusioni ottiche) complessi, quasi musicali: come accade nella prima delle installazioni presentate al PAC, Rendez-vous (2005).

Due schermi affiancati riprendono dal basso la cupola dello Juvarra alla Chiesa di Sant’Uberto nella Venaria Reale di Torino, mentre la telecamera ruota lungo un’ellisse; al centro della cupola ruotano le immagini delle due capsule Gemini 6 e 7, colte nel momento in cui si riprendono a vicenda, in occasione del loro incontro nello spazio. Sono dunque quattro orbite leggermente sfalsate l’una rispetto all’altra: in ciascuno dei due video, si contrappongono e dialogano immagine e sfondo; affiancate, le due proiezioni innestano un ulteriore gioco di simmetrie e asimmetrie, ottenendo un effetto di grande complessità - e quasi di vertigine - con elementi tutto sommato abbastanza semplici.
Stadi, arene e teatri (tra gli altri, ha dedicato video al Teatro La Fenice di Venezia, al Rossini di Pesaro, al Massimo di Palermo e al Comunale di Ferrara) vengono colti e osservati come oggetti, come “cosa in sé”. Sono visti spesso dall’alto, con la loro forma pressoché ovale; i teatro d’opera vengono a volte ripresi dal boccascena, valorizzando l’abbraccio avvolgente dei palchi (come accade con Eclissi). E vengono colti in genere in un momento particolare, dotato di una sua speciale magia: quando la sala si è riempita ma lo spettacolo non è ancora iniziato, e l’atmosfera si carica d’attesa, di aspettative.

Il decollo (1988) utilizza un’immagine dal cielo dello Stade de France, ripresa in occasione dei Mondiali del 1998; i raggi di luce dei proiettori creano una figura colorata e quasi astratta, una stella mandalica, mentre l’immagine ruota lentamente e in sottofondo il boato del pubblico crea un tappeto sonoro.

Due anni dopo, San Siro (2000) utilizza un altro punto di vista, ugualmente insolito: le trobune e il terreno di gioco vengono invece ripresi dall’angolo più alto, e dunque di scorcio: il terreno di gioco si oscura dal verde del prato al nero, mentre una serie di macchie luminose evidenzia il contorno rettangolare del campo e il suo centro, per poi ritornare al colore del prato. Mentre echeggiano i rumori della folla, l’immagine è punteggiata da lampi luminosi: sono come i flash e gli accendini dei “momenti magici” dei concerti, e al tempo stesso i segni delle esplosioni delle bombe dei videogame: in un’altra installazione, chiaramente ispirata all’11 settembre, Empire (2002) la carta degli Stati Uniti emerge come una rete di punti e macchie di luce, che a volte s’accendono ancora di più - e in sovrimpressione e nello schermo a fianco è visibile il mirino che inquadra e identifica il bersaglio.


In una delle due installazioni realizzate per la recente personale al PAC di Milano, Scala Nera (2006) è composta da due video in loop, che riprende la platea e i palchi del teatro da due punti di vista insoliti, ma familiari all’artista: dal boccascena verso la platea, con camera fissa; e dal centro della platea verso l’alto, con il soffitto ora oscurato a nero e l’immagine che ruota.

E questa seconda immagine è davvero impressionante: gli ordini dei palchi ruotano come i bracci di una galassia intorno al centro del vortice, mentre gli spettatori all’interno dei palchi baluginano come stelle. In sottofondo, il brusio del teatro che si riempie, con le due immagini costantemente punteggiate da piccole esplosioni luminose.
Grazia Toderi, si dice, “ha sempre pensato al paradiso terrestre come a un luogo di contemplazione e, allo stesso tempo, di svago: i suoi luoghi di spettacolo sono in fondo la nostalgia di un paradiso perduto”.
Grazia Toderi - Rosso Babele
a cura di Francesca Pasini
PAC - PADIGLIONE D'ARTE CONTEMPORANEA
Milano, via Palestro 14 (20121)
13 dicembre 2006-11 febbraio 2007

Totopoltrone news ETI, Teatro di Roma, Metastasio, Mercadante...
Con qualche soffiata di Perfida de Perfidis
di Redazione ateatro
Riassunto delle ultime puntate.
Avevamo appena lasciato Napoli, dove nella meravigliosa cornice di Castel dell’Ovo abbiamo dibattuto del teatro a Sud. E la nostra Perfida, che origliava distrattamente i nostri pettegolezzi, ha lanciato il Totopoltrone e ha cominciato a indagare, proponendoci una serie di concorsi. Li trovate nel numero 104, con approfondimenti nei forum. Ma le novità incalzano...
L’ETI
Tra le cariche in palio, c’era quella dell’ETI. Il nuovo direttore generale sarà uno dei primi candidati ipotizzati da Perfida: Ninni Cutaia, attuale direttore del Teatro Mercadante-Stabile di Napoli.
Per Ninni si tratta di un ritorno. Con lui l’ETI ideò e realizzò il Progetto Aree Disagiate, tante volte in questi anni citato come modello innovativo di programmazione condivisa fra enti locali, organismi pubblici e teatri di produzione. Ripartire da lì può essere un modo di ridare un futuro ad un ente che da quattro anni a questa parte non riesce a giustificare a tutto il teatro italiano (ed ai contribuenti che lo sostengono con oltre dieci milioni di euro all’anno) la propria sopravvivenza.
Nel corso di BP3 - La questione meridionale, Ninni Cutaia ha lanciato un appello al teatro italiano, prima che alla politica: servono fantasia per ridefinire le regole comuni e coraggio nell’affrontare il rischio culturale delle scelte. Che sia lui il prossimo direttore dell’Eti costringe tutti, lui per primo, a misurarsi con questa necessaria inversione di rotta.
Il Teatro Metastasio di Prato
Ma a questo punto, che farà Marco Giorgetti, che aveva debuttato in pubblico proprio nel primo incontro delle Buone Pratiche a Milano? Forse tornerà a Firenze, da dove era partito, per rilanciare la Pergola. E magari proverà a rifondare lo Stabile di Toscana, viste le patetiche convulsioni del Metastasio a Prato? (A proposito, vista la confusione, per Prato il forum ha aggiunto alcuni nuovi candidati, in quello che si preannuncia un arrivo in volata. Per esempio:
Il Teatro di Roma
Non abbiamo nemmeno avuto tempo di lanciare il Totonomine (ma qualcosa già Perfida lo sapeva...). La poltrona è stata ri-assegnata proprio ieri, con grande fretta, a Giorgio Albertazzi.
Una ulteriore conferma, se ce ne fosse stato bisogno, della continuità tra vecchio e nuovo governo, e dunque di un patto di ferro nel mantenimento dello statu quo e della ferrea spartizione tra destra, Margherita e Ds...
Il Teatro Mercadante di Napoli
Eh, sì! Se Ninni va all’ETI, al Mercadante chi ci va?
Napoli ha l’unico teatro stabile pubblico dell’Italia meridionale peninsulare e deve essere in grado di rappresentare sempre di più il nuovo corso del Sud teatrale, con la dovuta attenzione ad uno sguardo internazionale sul resto del Mediterraneo e d’Europa.
Dalle dichiarazioni dello stesso Ninni Cutaia, della presidente Rosaria Rummo, di Mario Martone e di Maurizio Scaparro, si evince la necessità di dare continuità al metodo di lavoro di Ninni e l’opportunità di una direzione organizzativa che dialoghi con gli artisti napoletani e mediterranei.
Anche se ci sono molti candidati, e un po' troppi gregari che provano a lanciare la volata (andate un po’ a vedere nel forum Fare un teatro di guerra?).
Naturalmente abbiamo chiesto a Perfida di indagare. Ecco che cosa ha raccolto.
Infine una indicazione di metodo, che ateatro propone all’attenzione di tutti i cda:
“I teatri devono essere diretti da uomini di teatro o perlomeno da uomini che conoscano psicologia, tecnica, organizzazione, metodo, valori estetici ed artistici del teatro, che vivano in teatro, che chiedano al teatro e diano al teatro tutto il possibile. Altrimenti ci troviamo di fronte a strutture che possono essere dei teatri come altre cose”.
(Paolo Grassi)
Ultimissima Totopoltrone Prato
Manifesto per il migliore dei Teatri possibili
di Attori, registi, drammaturghi coinvolti nell’attività culturale della città di Prato e della Regione Toscana
Mentre a Prato si discute sul nuovo direttore del Metastasio (e mentre la stampa locale dà in fuga verso il traguardo la coppia Pamela Villoresi-Stefano Massini, che pare se la stiano giocando in volata), riceviamo e volentieri pubblichiamo questo documento. (n.d.r.)
E ancora una volta il Teatro Metastasio sta attraversando un momento difficile, una costante degli ultimi anni che porta via con sé persone, lavoro e progetti in corsa.
E noi spesso da teatranti ci troviamo a lavorare nell'emergenza e nell’incertezza.
Ma sappiamo bene che le difficoltà possono essere un grande stimolo a crescere e a creare esperienze nuove, stimolanti e durature.
Per questo sentiamo la necessità di dare il nostro contributo di idee e di aiutare il Teatro della nostra città a migliorare e a ricostruire un rapporto, che sta perdendo, con le persone e il territorio.
Quelle che seguono sono una serie di richieste e di proposte che rivolgiamo
Alla Direzione Artistica del Teatro,
alla Presidenza e al Consiglio di Amministrazione,
agli Enti che sostengono il Metastasio.
Queste proposte nascono da un confronto comune, da una valutazione di quanto di buono è stato fatto fino ad adesso e di quanto si può migliorare nel futuro.
La nostra idea è di un Teatro capace di guardare lontano, che prosegua e rafforzi il rapporto con altre realtà europee, investendo e coinvolgendo al tempo stesso la realtà che lo circonda.
Per questo chiediamo al Teatro Metastasio Stabile della Toscana
Di essere e di volere essere un punto di riferimento forte e vivace, il faro che illumini la potenziale creatività della Regione Toscana e che sia referente di prestigio a livello nazionale e internazionale.
Prato è una città che è sempre riuscita a vivere della sua fantasia, è stata e continua a essere fucina di grandi talenti in ogni campo artistico, chiediamo che il Teatro sia finalmente sensibile e riesca a riconoscere e a valorizzare questo potenziale
1. Destinando e pianificando a lungo termine, chiaramente, una parte di risorse di bilancio per realizzare progetti che coinvolgano attori, registi, drammaturghi di talento e di qualità, legati al nostro territorio in modo che siano stabilmente impiegati nelle produzioni e nella programmazione del Teatro, mantenendo una particolare attenzione ed una curiosità generosa verso i nuovi talenti.
Chiediamo inoltre di:
2. Continuare a seguire la strada di una programmazione e di una produzione che leghi il Teatro ad altre realtà europee, rafforzando i rapporti di scambio e di coproduzione già avviati in questi ultimi anni. Avvicinare l’Europa significa aprire il nostro orizzonte, allargare le nostre prospettive, permetterci di capire il nostro tempo e la modernità.
3. Aprire un confronto permanente con le realtà teatrali a livello regionale e nazionale, organizzando incontri periodici che siano occasione di scambio, confronto e dibattito. Il dialogo aiuta a crescere e a capire. Chiedere un confronto significa convincere le persone che il Teatro è di una comunità, non è distante e non è di pochi.
4. Istituire una “stanza della creatività”, che impieghi un piccolo gruppo di attori, registi, drammaturghi e studiosi che siano punto di riferimento e garanzia della attività di produzione del teatro.
5. Realizzare attività formative che coinvolgano le realtà teatrali del territorio, con un riguardo particolare ai più giovani. E’ fondamentale non smettere di imparare. I maestri sono importanti, c’è una necessità di sconfiggere la superficialità, con l’approfondimento, lo studio, l’apertura a nuove esperienze.
6. Rilanciare l’attività promozionale del Teatro, a livello locale utilizzando la collaborazione di gruppi teatrali, associazioni culturali, singoli cittadini per l’organizzazione di incontri e dibattiti, cercando in particolar modo di coinvolgere gli studenti delle scuole superiori e dell’università; a livello nazionale: potenziando fortemente l’ufficio stampa e comunicazione e aggiornando il sito internet del teatro, realizzandone una versione in più lingue.
7. Coinvolgere nell’attività e nella promozione i territori della provincia e della regione. Portando spettacoli, occasioni di incontro, iniziative promozionali e didattiche anche fuori da Prato.
8. Coinvolgere gli interessi dell’industria pratese delle arti e dei mestieri legati alle arti sceniche (ad es. atelier di costumisti che stimolino la ricerca nel tessile, utilizzo di artigiani del legno per la scenotecnica, esperti di nuove tecnologie etc).
9. Promuovere iniziative che aprano gli spazi pubblici del Teatro alla città, in orari diversi da quelli della normale programmazione, offrendo ad esempio uno spazio da adibire a sala di lettura, con un servizio di prestito di testi ed una videoteca.
10. Credere fermamente che il Teatro e la cultura siano un’urgenza imprescindibile per la nostra città. Credere che gli investimenti culturali, anche se non comportano un evidente e immediato ritorno economico, costituiscono un arricchimento spirituale indispensabile che ci permette di vivere e non semplicemente di sopravvivere, che ci coinvolge e ci rende partecipi alla vita della nostra comunità.
Attori, registi, drammaturghi coinvolti nell’attività culturale della città di Prato e della Regione Toscana
"Hystrio" 1/07 Speciale Canada
Il sommario
di Hystrio
HYSTRIO numero 1 • gennaio - marzo 2007
2 vetrina
Il festival di Charleville-Mézières
L’invasione delle marionette
di Remo Melloni
Nella piccola cittadina del nord della Francia per dieci giorni si ritrovano tutte compagnie di teatro d’animazione del mondo occupando non solo i teatri ma ogni altro spazio possibile: strade, piazze, cortili, palestre e anche case private
Puppet Festival di Gorizia
Se Beckett avesse la testa di legno
di Roberto Canziani
dal testo alla scena
Guerra dei sessi e orizzonti metafisici
di Franco Perrelli
Il massimo studioso strindberghiano in Italia, che per la prima volta ha tradotto la pièce direttamente dallo svedese, riflette sulle ragioni della fortuna scenica di Danza di morte
Inferni coniugali tra pietas e disincanto
di Ugo Ronfani
Recensione di "Danza di morte" di August Strindberg. Traduzione di Franco Perrelli. Regia di Marco Bernardi. Produzione Stabile di Bolzano.
Pierre Cardin
Il re della moda nel castello di De Sade
di Rita Sanvincenti
Sono terminati pochi mesi fa gli imponenti lavori di ristrutturazione del castello di Lacoste nel Luberón, che può contare su tre spazi teatrali e dove da sei anni si svolge il Festival d’art lyrique et de théâtre - Da sempre appassionato di teatro, danza e musica (suoi l’Espace Pierre Cardin a Parigi e l’anfiteatro da 500 posti a Palais Bulles a Thoule-sur-mer in Costa Azzurra), arti per le quali ha realizzato innumerevoli lavori, Cardin ha esteso il suo mecenatismo dalla Francia alla Cina
9 la questione teatrale
Auspici e qualche apprensione per il Tricentenario goldoniano
di Ugo Ronfani
La “carnevalizzazione” delle manifestazioni sembra acquisita, ma ci si può domandare se, languendo nel Paese il dibattito culturale, la ricorrenza avrà un adeguato spessore, per completare l’incontro con un Goldoni “nostro contemporaneo” avviato, e non concluso, con le attività del Bicentenario della morte
commedie in dvd
Dagli archivi Rai sette perle goldoniane
di Roberto Canziani
12 teatromondo
Parigi bella d’autunno
Da settembre a dicembre, sulle scene parigine si affollano gli avvenimenti. Un gran numero di spazi della capitale francese viene invaso dal Festival d’Automne, che presenta importanti esposizioni d’arte, spettacoli di musica, danza e teatro. L’edizione di quest’anno, dedicata in particolare all’America, si è aperta con Quartett per la regia di Bob Wilson ed è continuata con il Wooster Group, con il Big Art Group di Caden Manson, con coreografie e installazioni di William Forsythe e con una personale dedicata a Richard Maxwell, controverso regista newyorkese che prova ad abbattere le barriere della rappresentazione portando in scena reietti, dilettanti, personaggi e persone sbiadite, fuori dai luccicori della società dello spettacolo. Ma il Festival ha anche prodotto la versione definitiva di Hey Girl! di Romeo Castellucci, ha dedicato un ritratto a un drammaturgo del frammento come Martin Crimp, un ricordo a firma Marcial Di Fonzo Bo a Copi, un’opera lirica con le musiche di Pascal Dusapin al mito del dottor Faustus. Sui palcoscenici di un altro festival, Le Temps d’Images della Ferme de Buisson, scena nazionale di Marne-La-Vallée, nell’immensa periferia parigina, si è vista la straordinaria rievocazione degli orrori di Auschwitz per piccoli pupazzi degli olandesi Hotel Modern, in tournée in tutta Europa. Alla Comédie Française, infine, Jacques Lassalle ha aperto con Il campiello le celebrazioni del terzo centenario della nascita di Goldoni.
Lille
Otello? Un indiano geloso
di Roberto Canziani
Nel Nord della Francia, il festival Lille 3000 si addobba con le luci, i colori, le mitologie della nuova India - L’ Othello in inglese e indi prepara il tour europeo delle spettacolari creazioni di Roysten Abel
Bologna/Teatri di vita
Corpi indiani come bambole di carta
di Lorenzo Donati
Recensione dee "Paper Doll", coreografia di Padmini Chettur, produzione Springdance Festival, Utrecht - Sw & G, Berlino - Grand Theatre, Groningen - KunstenFestival desArts, Bruxelles; e de "The Alien flower", ideazione e coreografia di Sudarshan Chakravorty. Parole di Sanjay Vasa e Rakesh Ratti, produzione Sapphire Creations Dance Workshop, Calcutta.
Stratford Upon Avon
Un anno vissuto shakespearianamente
di Delia Giubeli
Spettacoli in inglese e in antico mandarino, letture tradizionali, innovative messinscena e dissacranti versioni per tartarughe ninja: nella città natale di Shakespeare, dall’aprile 2006 all’aprile 2007, vengono rappresentate tutte le opere del più grande autore di teatro del mondo nel Complete Works Festival, un’impresa lunga un anno realizzata dalla Royal Shakespeare Company
Londra
Onde di immagini e suoni per Virginia Woolf
di Laura Santini
Recensione de " Waves", dal romanzo Le onde di Virginia Woolf. Adattamento e regia di Katie Mitchell. Produzione National Theatre, Londra.
Pinter incontra Beckett
Harold, Samuel & Dustin
di Roberto Canziani
Harold Pinter torna in scena dopo il Nobel e la malattia in L’ultimo nastro di Krapp di Samuel Beckett - Dustin Hoffman accorre a vederlo - Cronaca di un incontro intorno a una bottiglia di vino italiano
due Nobel in scena
Pinter nei silenzi di Beckett
di Roberto Canziani
Krapp's last tape di Samuel Beckett. Con Harold Pinter. Prod. Royal Court Theatre, Londra.
Roberto Recchia
Un italiano a Wexford
di Francesca Bonazzoli
Da sei anni l’attore e regista milanese è ospite fisso, e con successo, al festival irlandese, dove ha di recente curato un’applaudita messinscena del Don Gregorio di Donizetti
Spagna/Cile
Il teatro della colpa
di Dimitri Papanikas
Un teatro che semina dubbi più che nutrire certezze è quello del cileno Benjamín Galemiri, che abbiamo intervistato al Festival de Otoño di Madrid - Il drammaturgo cileno ci racconta la storia della sua famiglia ebrea, il conflittuale rapporto con il padre giudice, l’ossessione del potere e molto altro ancora, in attesa di arrivare in Italia con alcuni dei suoi “scandalosi” drammi
Madrid
Festival de Otoño 2006
di Dimitri Papanikas
28 dossier
Canada
a cura di Claudia Cannella
La drammaturgia di questo Paese, a lungo colonia di Francia e Inghilterra e diventato stato sovrano nel 1867, è in realtà molto giovane. Solo dopo la Seconda guerra mondiale cominciò infatti a maturare un’idea di indipendenza culturale sancita, nella Montréal francofona del 1948, dal manifesto Il rifiuto globale e dalla commedia Tit-Coq di Gratien Gélinas, considerata come l’atto di nascita del teatro moderno del Québec. Più lento, invece, il processo di sviluppo di una drammaturgia autoctona nel Canada anglofono dove, nel 1951, fu scritto il Rapporto Massey, che gettava le basi per la futura fondazione, nel 1957, di un’agenzia governativa delle arti con la funzione di sostenere talenti locali e compagnie professionali: il Canada Council for the Arts. Lo sviluppo fu rapido, molti spazi furono aperti in tutto il paese, mentre il Québec, sotto la spinta indipendentista, si metteva in luce producendo testi particolarmente innovativi per contenuti e linguaggio (primo fra tutti Le cognate di Michel Tremblay, nel 1968). Attualmente, le differenze produttive tra drammaturgia francofona e anglofona si sono attenuate e, tra i numerosi artisti delle ultime generazioni possiamo ricordare Michel Marc Bouchard, Normand Chaurette, René-Daniel Dubois, Robert Lepage, Marie Brassard, Judith Thompson, Jason Sherman, Maureen Hunter e Morris Panych.
Canada: un’anima divisa in due
di Robert Allen
(testo di Robert Allen, critico, operatore teatrale e, negli ultimi dieci anni, funzionario per il teatro del Canada Council for the Arts, traduzione di Fabrizio Caleffi)
Michel Tremblay
E in principio furono "Le cognate"
(estratto dal libro di Maria Rosa Baldi, "Michel Tremblay: da Les Belles-Soeurs a Le Vrai monde?", in catalogo Intercity Montréal II, 1993)
il grande innovatore
Le macchine della visione nel teatro di Robert Lepage
di Anna Maria Monteverdi
Star incontrastata del panorama internazionale, il canadese Lepage si è affermato grazie a un’originale drammaturgia che gioca su più livelli narrativi, mescolando teatro di parola e uso della tecnologia - Apartire dal recente The Andersen Project, “summa” tematica e formale precedenti spettacoli, un percorso ritroso nella sua idea di teatro
la musa di Lepage
Le voci di dentro di Marie Brassard
di Anna Maria Monteverdi
Autrice e attrice, ha raggiunto la notorietà internazionale grazie alla lunga collaborazione con Robert Lepage, con cui partecipa alla creazione della Trilogia dei dragoni, Polygraphe e Les sept branches de la rivière Ota - Nel 2000 inizia un percorso in proprio con la sua compagnia, l’Infrarouge Théâtre, realizzando Jimmy creatura di sogno e Peepshow, presentati anche a Milano
MilanOltre
Fiabe nere per spettatore voyeur
di Valeria Ravera
Recensione de Peepshow, scritto, diretto e interpretato da Marie Brassard. Produzione Infrarouge Théâtre (Québec).
Michel Marc Bouchard
«Racconto le ferite dell’anima dell’infanzia tradita»
di Claudia Cannella
Figura di spicco della drammaturgia canadese francofona degli anni Ottanta, è considerato l’erede di Michel Tramblay - Nei suoi testi, tradotti e rappresentati in tutto il mondo, si intrecciano riferimenti alla terra d’origine e temi più universali come la crisi della famiglia, l’omosessualità e la ricerca di un’identità nazionale in precario equilibrio tra i valori del vecchio e del nuovo mondo
Milano/Bouchard
Grovigli di famiglia in interno canadese
di Claudia Cannella
Recensione de Le muse orfane di Michel Marc Bouchard. Produzione Intermedia 86-Teatridithalia, Milano.
drammaturgia del corpo
Dal Canada con furore nuove e vecchie star della danse actuelle
di Domenico Rigotti
Dave St Pierre con l’esplosivo La pornographie des âmes è l’ultima rivelazione del teatrodanza canadese - Ma punte di diamante in area francofona sono ancora oggi i veterani La La Human Steps, con i loro mix di fisicità violenta, musica rock e immaginario tecnologico, e la femme sauvage Marie Chouinard, che fonde danza e arte concettuale in spettacoli di provocatoria bellezza; accanto a loro numerosi sono ormai gli epigoni
Judith Thompson
«Do voce alle mille culture di un Paese di immigrati»
di Francesco Tei
Spettacoli, letture, mise en espace, video e incontri hanno animato per un mese, lo scorso autunno, l’ultima edizione del Festival Intercity, fiore all’occhiello del Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino, dedicata quest’anno alla drammaturgia contemporanea canadese, soprattutto a quella della meno conosciuta area anglofona - Tra gli ospiti, Judith Thompson, attrice-autrice tra le più affermate, nella cui scrittura si mescolano realismo magico e necessità di fare i conti con la “nuova” multietnicità del suo Paese e con una tragedia del presente come la guerra in Iraq
Intercity-Toronto
di Francesco Tei
Recensioni de Alias Godot, di Brendan Gall. Produzione Festival Intercity, Sesto fiorentino (FI) e de Bigger than Jesus, di Rick Miller e Daniel Brooks. Produzione Wyrd Productions-Necessary Angel Theatre Company, Toronto (Canada) e Festival Intercity, Sesto Fiorentino (FI).
46 humour
II diavolo veste Savoia
di Fabrizio Caleffi
48 drammaturgia
ritratti di drammaturghi italiani/9
Letizia Russo: piccoli prodigi crescono
di Chiara Alessi
A ventun anni con Tomba di cani vince il Premio Riccione, a ventitré, con lo stesso testo, l’Ubu per la migliore novità drammaturgica. Nel frattempo intraprende un grand tour tra la sponda anglosassone e quella portoghese. Oggi chi si entusiasmò della scoperta della giovane irriverente penna romana si chiede che fine abbia fatto l’enfant prodige della drammaturgia italiana
51 nati ieri
i protagonisti della giovane scena/28
Mutamenti di Scenario
di Nicola Viesti
Nasceva vent’anni fa il Premio dedicato ai progetti teatrali di giovani gruppi, in un periodo in cui la creatività giovanile non trovava più nel teatro un momento di espressione privilegiata. Messi per la prima volta attorno a un tavolo comune il teatro ragazzi e quello di ricerca, l’Associazione Scenario, che oggi riunisce ben 35 imprese teatrali, ha dato vita, collettivamente, al particolare concorso, destinato a rappresentare, soprattutto nelle sue prime edizioni, uno stimolo per inventare ed elaborare un progetto di spettacolo. Riconoscimento fra i più ambiti, oggi il Premio è una risposta al prepotente ritorno della necessità di teatro fra le nuove generazioni. Ce ne parla Cristina Valenti, da sempre suo infaticabile direttore artistico
54 critiche
Oltre 90 recensioni della stagione in corso.
Una parabola sudafricana per Peter Brook - Cechov al Teatro dell’Elfo - Le lacrime amare di Petra von Kant secondo Latella - Doppio Mozart per Malosti e Korsunovas - Il dittico sul male di Marco Martinelli - Nekrosius alla prova del Faust - Le voci di dentro di Rosi/De Filippo - Baliani torna a Nairobi - Cinque rose per Arturo Cirillo - Gli Zingari di Iodice e Nino D’Angelo - Antonio e Cleopatra al Castello Ursino
94 danza
Ferrara
Simbolismi e buone cause una logica ormai usurata
di Andrea Nanni
Alla rassegna Prime Visioni deludono le star Saburo Teshigawara con il suo raffinato esercizio di stile Black Water e Monica Casadei con l’imbarazzante Cuba 2006 - Più interessanti, pur fra disparità e acerbità, i sei brevi spettacoli proposti da altrettante giovani formazioni, tra cui spiccano Doma di Sonia Brunelli, Àrebours 100 di Daniele Albanese e Desert-Inn del gruppo Nanou
97 teatroragazzi
“Segni d’infanzia” a Mantova
Baruffe fra ritmo e melodia
di Sara Chiappori
Teatro Kismet OperA
La fiaba iniziatica di Andersen
di Nicola Viesti
Recensione de La regina delle nevi, dalla fiaba di Andersen, regia di Teresa Ludovico. Produzione Teatro Kismet OperA, Bari e Festival Ellenico Atene.
100 biblioteca
scaffale
Le novità editoriali
a cura di Albarosa Camaldo
102 testi
Cani di bancata di Emma Dante e Diario di viaggio verso lo spettacolo
lo spettacolo
L’ultima cena del Mammasantissima
di Claudia Cannella
Recensione de Cani di bancata, testo, regia e costumi di Emma Dante. Produzione Crt, Milano.
110 la società teatrale
Tutta l’attualità nel mondo teatrale
a cura di Roberto Rizzente
in copertina
Angelo del Canada, tempera di Cristina Gentile
hanno collaborato
Paola Abenavoli, Carmelo Alberti, Chiara Alessi, Robert Allen, Marco Andreoli, Laura Bevione, Patrizia Bologna, Francesca Bonazzoli, Filippo Bruschi, Simona Buonomano, Fabrizio Caleffi, Roberto Canziani, Davide Carnevali, Anna Ceravolo, Sara Chiappori, Linda Dalisi, Emma Dante, Rudy De Cadaval, Lorenzo Donati, Gastone Geron, Delia Giubeli, Giuseppe Liotta, Stefania Maraucci, Antonella Melilli, Remo Melloni, Marco Menini, Giuseppe Montemagno, Anna Maria Monteverdi, Andrea Nanni, Dimitri Papanikas, Franco Perrelli, Gianni Poli, Valeria Ravera, Domenico Rigotti, Laura Santini, Rita Sanvincenti, Enrico Saravalle, Giuseppe Schillaci, Francesco Tei, Francesco Urbano, Nicola Viesti, Giusi Zippo.
Bando per la rassegna NUOVE ESPRESSIONI TEATRALI
Uno spazio per giovani compagnie
di Associazione Terre d'Acqua
Prima Edizione, 2007
L’Associazione Terre d’Acqua organizza da qualche anno un Festival di teatro e musica nel territorio posto tra i fiumi Oglio e Po, a cavallo fra le province di Cremona e Mantova. Il festival, che reca il nome omonimo dell’Associazione, è rivolto alla scena contemporanea, e per la sua programmazione, con la presenza di grandi artisti, ha riscosso importanti riconoscimenti da parte di critica e pubblico, nonché dagli Enti provinciali e regionali, ed è patrocinato dall’ETI (Ente Teatrale Italiano).
Per il prossimo Festival la nostra idea è quella di offrire uno spazio ed una visibilità, spesso negata, alle giovani compagnie per dare loro un’opportunità di visibilità, di stampa e teatrale, mostrando i loro lavori dapprima ad una commissione di esperti di livello nazionale e poi al pubblico del teatro.
Il bando che segue specifica le finalità e le modalità richieste.
Finalità
L’Associazione Terre d’Acqua, un consorzio di circa venti comuni, promuovono la rassegna “Nuove espressioni teatrali”, un’iniziativa che si propone di selezionare e valorizzare gruppi giovani esordienti o semi-esordienti, offrendo loro una serie di ribalte su cui presentare il proprio lavoro e la possibilità di sottoporlo a una commissione di esperti e operatori.
Destinatari
La partecipazione al progetto, che si terrà nel periodo aprile-maggio, nei teatri o negli altri spazi di rappresentazione disponibili nei vari comuni, è aperta a formazioni italiane nate da non più di un paio d’anni con intento di ricerca e di qualificazione professionale, che non abbiano mai preso parte a festival o a rassegne d’altro genere, che non godano già di finanziamenti statali e/o regionali e che affrontino in questa occasione la prima o al massimo la seconda prova pubblica.
Modalità
a) Non si pongono limitazioni alla possibilità di allestire opere non inedite di autori classici o contemporanei.
b) Una particolare attenzione verrà tuttavia riservata a quelle formazioni che mirano a rappresentare una propria personale interpretazione della realtà attraverso i linguaggi del corpo, la parola, la tecnologia, il rapporto con la materia, con gli oggetti, con le arti visive.
c) Tutti coloro che sono interessati ad aderire potranno inviare una richiesta di partecipazione entro e non oltre il 31 gennaio 2007, allegando un breve curriculum del gruppo, testi scritti, video, fotografie ed eventuali segnalazioni dei luoghi in cui assistere a una replica dello spettacolo.
d) Il materiale va spedito all’attenzione del direttore artistico Giuseppe Romanetti c/o la sede dell’Associazione Via Aldo Moro 9, 26034 Piadena (Cr). tel. 0375 98398, posta elettronica: terredacqua@tiscali.it
e) Le proposte ritenute più in carattere con lo spirito della rassegna saranno visionate dal vivo – integralmente, o in versioni parziali di durata comunque non inferiore a mezz’ora - dai membri della giuria, che entro il 30 marzo sceglieranno quelle giudicate di maggior valore.
f) Gli enti organizzatori non partecipano con sussidi economici alla produzione dei risultati finali. A chi ne avesse bisogno, potranno essere tuttavia offerte formule di “residenza” con la messa a disposizione di spazi per le prove, di mezzi tecnici e di assistenza.
Partners. I Comuni dell’Associazione Terre d’Acqua, le Province di Cremona e Mantova, la Regione Lombardia, il GAL Oglio-Po, l’Università “Bocconi” di Milano, L’ANCT -Associazione Nazionale Critici di Teatro.
Per ulteriori informazioni contattare il Direttore Artistico Giuseppe Romanetti (0375 284424 tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 13.00)) o il segretario dell’Associazione dott. Giuseppe Placentino (0375 98938 ogni lunedì dalle 15.00 alle 19.00).
Dalla Compagnia di San Paolo oltre 3 milioni di euro per lo spettacolo in Piemonte e Valle d'Aosta
Verranno distribuiti tra 100 rassegne e stagioni
di Redazione ateatro
Mentre in Piemonte si combatte una vera e propria guerra della cultura (ampie info sul forum), arriva una buona notizia - anche sforse scatenerà nuovi appetiti e faide...
Ammonta infatti a 3,6 mln di euro lo stanziamento 2007 della Compagnia di San Paolo a sostegno di attività di spettacolo dal vivo di danza, musica e teatro, a favore di enti culturali non profit operanti in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Lo prevede il nuovo bando «Arti sceniche in Compagnia» che finanzierà fino a 110 iniziative che dovranno configurarsi come rassegne (non meno di quattro spettacoli diversi tra loro, ma collegati organicamente) o come stagioni (almeno otto spettacoli).
Con i fondi 2007 sale a 17,5 mln di euro il valore dell’impegno finanziario della Compagnia di SanPaolo per i sei bandi finora dedicati allo spettacolo dal vivo.
La scomparsa di Gianni Toti
Poeta e videoartista
di Un gruppo di amici
Lunedì 8 gennaio 2007 è mancato a Roma, all’affetto dei suoi familiari e amici e a quello della comunità artistica e culturale internazionale il poeta italiano Gianni TOTI.
Nato a Roma nel giugno del 1924, Gianni TOTI è stato una tra le figure più rappresentative della cultura italiana ed europea nella seconda metà del Novecento.
Esploratore raffinato delle possibilità della scrittura in tutte le sue forme – da quella letteraria a quella cinematografica e videoartistica – studioso di instancabile curiosità intellettuale, si è occupato di saggistica e di scienza, di poesia e di musica, di pittura e di astronomia, di filosofia e di letteratura, di cinema e di arti elettroniche.
Nella sua ricerca appassionata della realtà oltre l’apparenza nonché dell’arte come possibilità di riscatto etico e civile per l’umanità, ha sempre coniugato la ricerca espressiva anche più radicale con la passione: e con un autentico, profondo, intransigente impegno civile.
Partigiano a vent’anni nella Resistenza romana al fascismo e al nazismo, giornalista e reporter internazionale sul fronte delle rivoluzioni democratiche negli anni della Guerra fredda – dall’Ungheria del ’56 all’America latina degli anni Sessanta – poeta e scrittore, narratore sempre affascinante, romanziere e soggettista cinematografico, cineasta, ideatore nel ‘68 con Cesare Zavattini dei Cinegiornali Liberi, teorico del cinema e delle arti, dagli anni Ottanta era diventato un punto di riferimento insostituibile a livello mondiale nel dibattito sulle arti elettroniche: sia come autore di VideoPoemOpere che rimangono tra i capolavori della cinematografia in elettronica sia come filosofo delle relazioni tra le arti nell’epoca delle nuove tecnologie.
Ispiratore e animatore di manifestazioni, rassegne, mostre di cultura cinematografica che hanno fatto la storia del cinema in Europa – da quella del Cinema Libero di Porretta al Nuovo Cinema di Pesaro a l’Immagine elettronica di Bologna – nonché direttore di collane di libri e di riviste (“Carte Segrete” e “I Taschinabili” tra le più prestigiose), grande giornalista, poeta, regista e “poetronico” Gianni TOTI sarà ricordato da chi lo ha conosciuto, o anche solo ascoltato alla radio o visto in tv, per la sua affabilità e generosità oltre che per la passione con la quale sapeva esporre le proprie idee.
E sarà ricordato come un autentico Maestro dai numerosissimi giovani artisti, docenti e ricercatori universitari che dalle Americhe all’Europa, all’Australia, stanno studiando la sua opera e approfondendo la sua lezione, anche di vita.
Camera ardente: martedì 9 gennaio, Casa di cura “Quisisana”, via G.G. Porro, 5 Roma; ore 10-13, 17-19
Esequie: mercoledì 10 gennaio, Tempietto egizio, Cimitero monumentale del Verano, Roma, ore 11

