L'editoriale di ateatro 94
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and1
La questione meridionale a teatro
Le Buone Pratiche 3/2006
di Franco D'Ippolito
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and5
Una prospettiva condivisa per le arti e lo spettacolo
Il documento conclusivo dell'incontro di Firenze del 3-4 dicembre 2005
di ADAC Toscana
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and6
In anteprima dal Patalogo 28: Il regista-Sudoku e il regista-Kakuro con alcuni consigli a un giovane regista
dal dossier Il ruolo della regia negli anni Duemila
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and7
Semplicemente complicato (Parte I)
Un incontro con Luca Ronconi
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and8
Otellooooooooo!
Otello il nivuru di Mazzaria di Francesco Randazzo
di Anna Maria Monteverdi
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and12
Stravolgendo Shakespeare
Una intervista a Francesco Randazzo
di Anna Maria Monteverdi
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and13
Gli Artefatti tornano a Martin Crimp
Attempts on her life- Attentati alla vita di lei – 17 soggetti per il teatro
di Elena Lamberti
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and14
Le recensioni di ateatro: La Romanina di e con Anna Meacci
Drammaturgia di Luca Scarlini, regia di Giovanni Guerrieri
di Andrea Lanini
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and15
La voce dell’attore
Una riflessione
di Nevio Gàmbula
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and25
Dedicato a Julian Beck
Due testi per Anna Maria Monteverdi
di Judith Malina e Hanon Reznikov
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and30
That Time di Samuel Beckett interpretato da Julian Beck
Con la regia di Gerald Thomas
di Anna Maria Monteverdi
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and31
Ricordando Julian
Note inedite raccolte da Anna Maria Monteverdi
di Gerald Thomas
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and32
Teatro & storia è online
Una mail a ateatro
di Nicola Savarese
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and37
Virtual Ubu
Note di regia & foto
di Fortebraccio Teatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and44
Le catene virtuali di Ubu
Ubu incatenato di Jarry secondo Roberto Latini e Gianluca Misiti - Fortebraccioteatro
di Andrea Balzola
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and45
Le nuove frontiere dell’arte digitale
Christiane Paul, Digital art, Thames & Hudson
di Silvana Vassallo
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and50
Un carro carico di... storia del teatro
Il progetto di formazione del pubblico di Alessio Pizzech
di Anna Maria Monteverdi
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and60
I Premi Ubu per il teatro 2005
I vincitori e i link alla ate@tropedia
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and70
Il bando di Concorso Italia di Riccione TTV Festival
Con una nota di Fabio Bruschi sul Concorso Italia
di Riccione TTV
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and72
Progetto Domani: il teatro alle Olimpiadi
Con la locandina dei cinque spettacoli per le Olimpiadi di Torino
di Luca Ronconi
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and73
Buon compleanno, Samuel Beckett
1906BECKETT2006 & le manifestazioni per il centenario della nascita di Samuel Beckett
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and74

A Roma una festa per Pinter
In occasione dell'uscita di Harold Pinter. Scena e potere di Roberto Canziani e Gianfranco Capitta
di Garzanti Libri
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro94.htm#94and56
Beck & Beckett, Ronconi a Torino, le buone pratiche al Sud, la voce, la digital art...
L'editoriale di ateatro 94
di Redazione ateatro
Il 2006 celebra numerosi anniversari importanti: Beckett, Ibsen, Brecht... Nel corso dell’anno ci torneremo, naturalmente, ma per cominciare noi di ateatro abbiamo pensato di collegare il nostro contributo al ventennale della morte di Julian Beck (curato da amm & Fernando Mastropasqua) al centenario della nascita di Samuel Beckett, con un ricordo di Julian interprete di Samuel (e non è tutto...). In ogni caso sui due (e su molto altro...) potete sempre consultare la nostra poderosa ate@tropedia, l’enciclopedia più teatrale che ci sia! Se ci andate a curiosare, ci sono in pratica già 200 monografie...
(avvertenza per gli utilizzatori: ovviamente il materiale della ate@tropedia è a disposizione di tutti, e internet è il regno del copiancolla. Però, se fate un copiaincolla dalla ate@tropedia vi conviene sempre citare la fonte: ci vengono tutti (compresi moltissimi professori universitari), ci leggono tutti(compresi moltissimi professori universitari), e dunque vi sgamano subito. Per evitare noie, basta ricordare una semplice regoletta: all'università copiare è permesso, si chiama citare.
Ma intanto, che piaccia o no, il 2006 comincia anche nel segno di Luca Ronconi e degli spettacoli olimpici torinesi. Ognuno è libero di pensare quello che vuole di Ronconi, delle Olimpiadi, degli spettacoli olimpici di Torino 2006, dei loro costi e dei loro risultati.
Quella torinese è però un’ottima occasione per fare il punto sul lavoro del più importante regista italiano: in anteprima dal volume Luca Ronconi. Spettacoli per Torino, che verrà pubblicato dalla Società Editrice Umberto Allemandi & C. poco dopo la conclusione dei giochi torinesi, presentiamo un “incontro” con il regista, uno sguardo al suoi spettacoli, al suo percorso, al suo metodo (o non-metodo) di lavoro, alla sua bottega.
Se qualcuno ha voglia di divertirsi, ateatro 94 sistema anche il regista degli Ultimi giorni dell’umanità sulla scacchiera dei registi kakuro e dei registi sudoku (ma nello speciale sul futuro della regia sull’ultimo Patalogo ci sono anche riflessioni molto più serie e ponderate sulla faccenda).
Val forse la pena di approfittare dell’occasione anche per cercare di sciogliere un equivoco. Noi di ateatro non pensiamo che la produzione di uno spettacolo teatrale della necessariamente costare poco, che tutti gli spettacoli e i festival debbano essere necessariamente poveri. Pensiamo che spettacoli e festival debbano essere necessari. E pensiamo che i soldi pubblici - tanti o pochi che siano - debbano essere spesi bene, e su questo da anni ci battiamo.
Pensiamo che gli spettacoli e i festival poveri siano importanti e necessari (e di questi, in genere, parliamo, anche in questo ateatro 94), e spesso più belli e necessari di quasi tutto il teatro “ricco”. Però sappiamo anche che non è possibile gestire un teatro stabile o un festival internazionale con budget sempre risicati, e che un teatro fatto solo di piccoli spettacoli e di piccoli festival non può bastare: né a noi né alla cultura di un paese.
Di più. Proprio per questo siamo convinti che l’investimento pubblico in cultura debba aumentare, e non diminuire (e l’abbiamo detto e ripetuto, e abbiamo lanciato una campagna sulla faccenda). Riteniamo che questo investimento pubblico non debba essere distribuito a pioggia, ma che debba valutare la qualità e l’impatto dei progetti.
Sappiamo anche che di questi tempi i tagli alla cultura sono all’ordine del giorno, e che dunque la povertà diventa sempre più una necessità. Ma questa non deve essere una regola, che riduce il mondo del teatro a una continua guerra tra poveri.
Ma certamente ritorneremo, nei prossimi ateatro, sia su questo sia sugli spettacoli di Ronconi (e sull’intera operazione): ma se avete qualcosa da dire, il forum è sempre aperto.
Ma non c’è solo Ronconi, in ateatro 94. Franco D’Ippolito rilancia le Buone Pratiche al Sud, Nevio Gàmbula approfondisce la riflessione sul tema della voce, Silvana Vassallo fa finta di recensire un libro sulla digital art e invece scrive un saggio sulla materia che finisce dritto dritto nella ate@tropedia. E si parla del Martin Crimp degli Artefatti, dell’Otello nivuru siculo e post-tutto di Francesco Randazzo visto dall'infaticabile Anna Maria Monteverdi, dell’Ubu di Roberto Latini incatenato dalla tecnologia del Brogi (a proposito, lo spettacolo sarà a Cecina il 28 gennaio), e la Meacci che fa la trans...
...ma basta, qui sotto trovate l’indice del numero dove potete curiosare, leggere, stampare, rileggere, e poi commentare, litigare, fare amicizia, trovare lavoro, segnalare spettacoli, iscriversi a seminari e workshop...
La questione meridionale a teatro
Le Buone Pratiche 3/2006
di Franco D'Ippolito
L’inconveniente beneventano nel rinvio della tappa al Sud delle Buone Pratiche 2 è evidentemente parte esso stesso della “questione meridionale in teatro”. Una questione in cui a punte di eccellenza e di efficienza organizzativa si accompagnano equivoci gattopardiani, laddove importanti aperture al confronto civile e culturale con strati sempre più ampi di popolazione si interrompono ad opera di improvvisi individualismi. Ma pur sempre una questione di cui vale la pena il teatro italiano si occupi seriamente, senza forzature e con lo stesso interesse mostrato per le patologie del fare teatro al Sud.
In un saggio dal titolo provocatorio Abolire il Mezzogiorno (Laterza, 2003), l’economista Gianfranco Viesti scrive:
Si guarda sempre e solo alla strada che c’è da percorrere e mai al fatto che si è iniziato a camminare, alle possibilità che ci possono essere, al pericolo che ci si possa fermare.
E’ per questo che affermiamo con convinzione che sì, la questione meridionale in teatro sta nel divario nord-sud dei finanziamenti pubblici, delle sale agibili, del numero delle recite programmate, ma sta anche (e forse negli ultimi anni, soprattutto) nella specificità del “pensiero meridiano”, nei modelli organizzativi ed artistici che funzionano, nella passione dei nuovi talenti, in una nuova necessità del teatro.
Pensare il sud vuol dire allora che il sud è il soggetto del pensiero: esso non deve essere studiato, analizzato e giudicato da un pensiero esterno, ma deve riacquistare la forza per pensarsi da sé, per riconquistare con decisione la propria autonomia…….. Significa non pensare più il sud o i sud come periferia sperduta e anonima dell’impero, luoghi dove ancora non è successo niente e dove si replica tardi e male ciò che celebra le sue prime altrove. (Franco Cassano, Il pensiero meridiano, Laterza, 1996).
Vorremmo creare le condizioni per porre a tutti noi alcune domande:
- “a cosa può servire il teatro nel superamento della questione meridionale intesa come “palla al piede” del sistema Italia?”;
- “quale grado di consapevolezza ha raggiunto l’imprenditoria privata nel considerare lo sviluppo civile parte irrinunciabile ed imprescindibile dello sviluppo economico del territorio?”;
- “cosa comporta e che significa per il sistema teatrale italiano il “sotto la media” delle produzioni, delle recite, delle sale teatrali, degli spettatori, delle risorse pubbliche e private del teatro meridionale?”;
- “come dare continuità alle pratiche teatrali meridionali e regolare le relazioni fra istituzioni, Enti Locali, organismi distributivi e teatri e compagnie?”;
- “quali politiche locali teatrali promuovere mentre si vanno definendo i nuovi assetti Stato/Regioni, magari avviando proprio dal Sud una ricomposizione degli obiettivi strategici (come ripartire il FUS, a chi e perché, qual è l’ambito nazionale e quale la rilevanza regionale).
La campagna elettorale che pervade ormai i livelli più diversi della comunicazione ci impone di cedere il passo all’invadenza presidenziale ed alle disquisizioni botaniche. Torneremo dopo il 9 aprile a confrontarci fra di noi ed a sollecitare alle istituzioni qualche risposta alle domande che da tempo avanziamo. La speranza (e qualcosa anche di più, la necessità) è che potremo dialogare (anche polemicamente) con un governo più serio e sobrio, meno volgare e presuntuosamente ignorante, più civilmente responsabile e capace di non smentirsi a parole e nei fatti di ora in ora (il che non è facile, bisogna ammetterlo, ci vuole una “certa” arte).
Dopo Benevento si sono candidate ad ospitare intorno a maggio 2006 le BP2 Sud altre città meridionali, Napoli, Cosenza, Catania, Palermo e Cagliari. Stiamo valutando le condizioni organizzativo-logistiche di ogni situazione e la disponibilità degli Enti Locali a darci una mano. Da meridionale del gruppo insisto. E molto presto mi auguro che riusciremo ad ufficializzare la tappa al Sud. Non per facili illusioni consolatorie, quanto per credibili prospettive di sviluppo.
Franco D’Ippolito
P.S. Ho appena letto Napoli siamo noi di Giorgio Bocca (Feltrinelli, 2006) e sono ancora più convinto che della “questione meridionale” è tempo che se ne facciano carico i meridionali.
Una prospettiva condivisa per le arti e lo spettacolo
Il documento conclusivo dell'incontro di Firenze del 3-4 dicembre 2005
di ADAC Toscana
Questo documento non contiene una proposta organica ma suggerisce alcuni temi di riflessione generale e raccoglie alcune delle proposte di lavoro emerse nell’incontro organizzato da ADAC Toscana e realizzato con il contributo della Regione Toscana, il 3 e 4 dicembre 2005 a Firenze: UNA PROSPETTIVA CONDIVISA PER LE ARTI E LO SPETTACOLO CONTEMPORANEI.
1. Cultura come bene comune
Un sistema della attività culturali vivace, libero, indipendente e pluralista è una garanzia indispensabile per la tutela della libertà di pensiero e della democrazia. E’ da affermare il valore della cultura, dell'arte, dello spettacolo e dell’istruzione come beni comuni che arricchiscono, anche senza ritorni immediati, la vita di una comunità e di una nazione. Hanno un valore di beni pubblici da coltivare e incrementare con interventi seri e approfonditi che rifuggano le sciagurate deformazioni di una “comunicazione” facile, volta a conquistare il consenso immediato. La cultura, lo spettacolo, l’istruzione lavorano sul profondo e sul lungo periodo; sono una delle fondamenta su cui si costruisce il futuro di una collettività e devono essere oggetto di un consistente intervento pubblico, lasciando a quello privato il ruolo di necessaria integrazione, senza trascurare – per lo spettacolo in particolare – una razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, delle strutture, della produzione e una necessaria ridistribuzione delle risorse che consentano al sistema di adeguarsi agli irreversibili mutamenti che la società sta subendo in questi anni e gli consenta di mantenere nel tempo una grande capacità flessibilità e adattamento.
2. Indipendenza della cultura
E’ necessario garantire l’indipendenza degli organismi preposti, a tutti i livelli, a gestire la cultura. E’ opportuno sottrarre la cultura e lo spettacolo allo spoil system, alla lottizzazione politica, alla discrezionalità e al personalismo e iniziare a creare una rete di “funzionari” dotati di competenze tecniche e culturali, con incarichi e possibilità di lavoro non condizionati dai cambi di personale e di indirizzo politico.
3. Sui criteri di finanziamento e i confini di genere
In attesa di un regolamento e di una legge per lo spettacolo, che gli schieramenti politici devono impegnarsi a rendere operanti al più presto, e comunque non oltre due anni dalle prossime elezioni, è opportuno rivedere la formazione delle commissioni ministeriali secondo criteri di competenza e indipendenza. E’ necessario, altresì, ridisegnare i criteri di gestione dei finanziamenti non più secondo divisioni in categorie (stabili, stabili privati, di innovazione eccetera), quanto premiando l’effettiva progettualità e ridisegnando i confini di genere secondo criteri più aderenti alla realtà dell'arte e dello spettacolo contemporaneo. Naturalmente questa idea di indirizzo vale per gli organi centrali e per quelli periferici.
All’interno di questo quadro vanno studiate misure particolari e urgenti per la danza, vera cenerentola del nostro sistema dello spettacolo, in particolare per la danza contemporanea, che cerca nuovi confini allontanandosi da quelli conosciuti, mettendo in discussione la stessa nozione di ambito disciplinare. Gli interventi devono garantire risorse, spazi, circuiti, occasioni di formazione per un incremento della qualità e per un necessario ricambio generazionale. Devono favorire dinamiche collaborative di rete.
4. La missione delle iniziative e delle strutture culturali
Ogni struttura e iniziativa culturale, stabile e no, deve definire la propria “missione” con carte d’intenti e quadri progettuali che possano diventare criteri di verifica dell’operato svolto.
5. Spazi
Improcrastinabile diventa una politica di creazione e gestione di spazi che comportino costi di esercizio più contenuti rispetto ai luoghi tradizionali, dove possano incontrarsi diverse arti, pratiche e idee, che attuino una politica di creazione di servizi al territorio e che permettano l’attivazione di economie di scala con l’effettiva costituzione di una rete di distribuzione decentrata ben articolata, capace di inventare e rendere stabili manifestazioni.
6. Arti contemporanee
Queste proposte si muovono in una prospettiva che pone al centro il concetto di arte contemporanea e le pratiche diverse che in questa direzione si sviluppano. Diventa quindi urgente, in tale prospettiva, una discussione approfondita intorno al significato preciso del termine contemporaneità, anche in relazione con l’idea di tradizione, per una ridefinizione degli interventi e degli spazi.
Questo è un punto nodale e controverso; non servono dunque scorciatoie o banalizzazioni ma un impegno di studio, di definizione, di discussione, per aprire strade per il domani delle arti.
7. La questione del pubblico
Un ulteriore, approfondito studio, interesse, impegno dovrà essere posto alla questione del pubblico, interrogandosi su come rendere accessibile la migliore offerta culturale possibile alla maggior parte possibile di cittadini. Altre questioni collegate sono come incontrare il pubblico, come farlo crescere, come permettergli di confrontarsi con linguaggi spesso complessi; come i linguaggi stessi possano o debbano misurarsi con i nuovi interlocutori e le loro urgenze sociali, individuali, estetiche, conoscitive. In questa direzione si pensa che possa essere risolutiva un’articolata apertura del territorio a una presenza costante degli artisti, con progetti di residenza capaci di operare in modo capillare e continuativo.
8. Per una diffusione della cultura delle arti sceniche
In queste prospettive, un particolare rilievo va assegnato a tutte quelle attività che mirano ad accrescere la cultura delle arti performativa (pubblicazioni, incontri, attività di formazione, di conoscenza, di scambio di informazioni, di studio). Centrale diventa la relazione con la scuola, dove le la cultura, le arti e lo spettacolo e i loro modi di affrontare l’espressione umana possono diventare modelli pedagogici. Importante anche la relazione con l’università e con altri centri di studio e di ricerca. Bisogna, inoltre, ridare un ruolo attivo (e rinnovato) all’informazione e alla critica, oggi avvilite da un sistema che da una parte nega spazi e dall’altra riduce tali importanti funzioni alla semplice promozione in vista di un immediato consenso. Non è un bene, non è socialmente sano, che i mezzi di comunicazione riservino i loro spazi unicamente ai prodotti più smerciabili dell'industria culturale.
9. Il rapporto con il territorio
Una particolare attenzione va dedicata al rapporto tra lavoro degli artisti e territorio. Quest’ultimo deve fornire agli artisti risorse, strumenti di lavoro, luoghi e strutture di residenza. Gli artisti, dal canto loro, devono aprirsi e mettere a disposizione del territorio un “saper fare” e una “creatività” capaci di innescare progetti – anche gestionali – innovativi e virtuosi.
10. Reti
Le reti di collaborazione devono diventare una realtà operativa, incoraggiata variamente, capace di scambiare opere, conoscenze, esperienze, di inventare occasioni, di promuovere, di formare, di incontrare nuovi pubblici, di avviare strutture di studio, di informazione, di circolazione di opere e esperienze anche con l’estero.
11. Osservare e promuovere il nuovo
E' necessario favorire il ricambio generazionale. Particolare attenzione deve quindi essere rivolta all’osservazione e alla promozione del nuovo, organizzando, senza dirigismi né favoritismi, percorsi per far maturare i segnali interessanti di giovani creatività e progettualità.
In anteprima dal Patalogo 28: Il regista-Sudoku e il regista-Kakuro con alcuni consigli a un giovane regista
dal dossier Il ruolo della regia negli anni Duemila
di Oliviero Ponte di Pino
In occasione dei Premi Ubu è stato presentato ieri sera il Patalogo 28, la nuova edizione dell’annuario dello spettacolo a cura di Franco Quadri, edito da Ubulibri.
Piatto forte di questa nuova edizione del Patalogo è un l’ampio dossier Il ruolo della regia negli anni Duemila, con contributi di Franco Quadri, Renato Palazzi, Colette Godard, Renate Klett, Enrico Fiore, Maria Grazia Gregori, Jean Jourdheuil, Claudio Meldolesi, Georges Banu, Siro Ferrone, Massimo Marino, Oliviero Ponte di Pino, Luca Ronconi, Antonio Latella, Enzo Moscato, Peter Kammerer, Jan Fabre, Jon Fosse, Annalisa Bianco e Virgilio Liberti, Jean-Paul Manganaro, Fausto Malcovati, Jorge Silva Melo, Romeo Castellucci, Renata Molinari.
Qui di seguito, il contributo di Oliviero Ponte di Pino al dossier.
In questi mesi vanno di moda sui giornali di tutto il mondo due giochini giapponesi con i numeri, il Sudoku e il Kakuro.
Nel primo rompicapo si tratta di riempire una griglia quadrata di 81 caselle con i numeri da 1 a 9 in modo che all’interno di ciascuna riga e colonna, e all’interno dei nove quadrati di tre caselle di lato che compongono la scacchiera, nessuna cifra si ripeta. E’ un gioco logico (e non matematico, anche se è fatto con i numeri). L’abilità del solutore consiste nel distribuire i diversi elementi a sua disposizione (le cifre) in uno spazio predeterminato.
Anche nel secondo gioco, il Kakuro, bisogna posizionare le cifre da 1 a 9 all’interno di una griglia – che ha però una forma meno regolare, più bizzarra. Ferma restando la necessità di non ripetere la stessa cifra all’interno di ciascuna riga e colonna, in questo caso si tratta di scomporre il numero che compare in testa a ogni riga e colonna, in modo che la somma di tutte le cifre all’interno di quella riga o colonna sia uguale, per l’appunto, a quel numero. Va ovviamente tenuto presente che un numero può essere la somma di diverse sequenze di cifre: ciascuna riga o colonna, presa a sé, può avere diverse soluzioni possibili (9=4+5 oppure 6+3 eccetera).
Nei due casi, in uno schema ben progettato, esiste una e una sola soluzione.
Il Sudoku e il Kakuro sono due giochi in apparenza abbastanza simili: ci sono dei quadratini da riempire di numeri, che devono rispondere a determinate caratteristiche. Tuttavia sono basati su principi assai diversi. Il primo sviluppa doti architettonico-combinatorie (a partire da elementi semplici); il secondo richiede invece su una abilità interpretativa: la capacità di scomporre un elemento complesso nei fattori – a prima vista invisibili – che lo compongono.
Se la regia teatrale fosse un giochino numerico, sarebbe probabilmente una combinazione di Kakuro e di Sudoku, in diverse proporzioni. Anzi, per certi aspetti la regia è sempre stata un po’ Sudoku e un po’ Kakuro. Tornando alle origini della regia moderna, da un lato c’è uno Stanislavskij-Kakuro, che analizza, scompone e ricompone gli elementi costitutivi del teatro (il testo e l’attore, per cominciare), intrecciandoli ed equilibrandoli tra loro. Dall’altro, ovviamente, c’è un Mejerchol’d-Sudoku, che lavora soprattutto sulla combinazione e armonizzazione dei vari elementi e compongono l’evento teatrale (il suono e il gesto, per cominciare), e li distribuisce nello spazio e nel tempo.
Sul versante Kakuro abbiamo una regia per così dire “ermeneutica”, che parte da un testo per “aprirlo” e interpretarlo: in una prima fase, quella della “innocenza”, lo compone utilizzando psicologia, filologia, storia, sociologia eccetera, per scoprire e rappresentare il significato, il senso di quel testo (insomma, per far tornare le somme); nella seconda fase, quella del “sospetto”, utilizza piuttosto gli attrezzi della psicoanalisi, del marxismo, dello strutturalismo per smontare il testo e smascherare il suo sottotesto, che viene portato alla luce con tutte le sue contraddizioni e conflitti (insomma, è un Kakuro in cui le somme non possono tornare).
Sul versante Sudoku abbiamo invece una messinscena che si muove nell’orizzonte architettonico dell’opera d’arte totale wagneriana, o in quello postmoderno del citazione e del frammento, per una ri-composizione in chiave architettonica e/o musicale dei diversi fattori elementari che concorrono all’evento teatrale.
Per richiamarsi a una celeberrima contrapposizione, il regista Kakuro lavorerà sull’anima, il regista Sudoku si divertirà a far esplodere il trucco.
Sono caricature, è chiaro, a cominciare dallo Stanislavskij-Kakuro e dal Mejerchol’d-Sudoku. Per di più, volendo restare ancorati alla nostra metafora ludico-matematica, queste semplificazioni colgono solo uno degli assi di un immaginario “Piano cartesiano della regia”, quello delle ordinate (se avete qualche reminiscenza scolastica, lasse delle x…)..
Per quanto riguarda invece l’asse delle ascisse, quello verticale, è opportuno individuare un’altra possibile polarità, effettuando un’altra semplificazione. Il teatro – nella prospettiva della regia – è un’arte personale, individuale: lo spettacolo è l’espressione della personalità del regista-creatore, del suo vissuto, della sua soggettività, delle sue passioni e idiosincrasie. Allo stesso tempo, però, il teatro è per sua natura un’arte collettiva, sia al livello della creazione sia al livello della fruizione: una forma artistica ed espressiva aperta al sociale e alla polis. Anche questa è una polarità che ha cominciato a evidenziarsi molto presto, intrecciandosi con l’altra. Per semplicità, rubando la terminologia a Jung, potremmo parlare di registi introversi e registi estroversi, di registi a spirale e registi freccia (ovviamente non stiamo parlando di personalità e simpatia individuale, e neppure di estroversione o introversione degli spettacoli: stiamo parlando delle poetiche registiche).
Così, su quello che abbiamo battezzato “Piano cartesiano della regia”, abbiamo tracciato due assi, quello Sudoku-Kakuro e quello Spirale-Freccia.
Adesso possiamo quasi iniziare il nostro gioco. Manca però ancora un passo: è opportuno suddividere il nostro piano cartesiano della regia in una serie di caselline quadrate, come quelle dei nostri rompicapi. Ogni casellina corrisponderà a un determinato livello nella gradazione Sudoku-Kakuro, e a un determinato livello sulla gamma Spirale-Freccia.
A questo punto basta sistemare i diversi registi all’interno della casella che meglio riflette la sua poetica. Per esempio, Robert Wilson è un teatrante esemplarmente Sudoku, mentre le regie di Giorgio Strehler e Massimo Castri tendono al Kakuro, rispettivamente prima e seconda fase. Luca Ronconi è Kakuro, ma con qualche tendenza Sudoku. Il Living Theatre tenderà più alla Freccia, Jerzy Grotowski più alla Spirale. Aldo Trionfo? Spesso Spirale. Tadeusz Kantor? Sublime Spirale. Peter Stein? Piuttosto Freccia. Ariane Mnouchkine? Ancora più Freccia.
Dopo di che, si può iniziare a giocare con le combinazioni del nostri fattori: avremo registi Kakuro-Spirale, registi Kakuro-Freccia, registi Sudoku-Spirale e registi Sudoku-Freccia, nei quattro quadranti in cui è suddiviso il Piano. Eugenio Barba, per esempio, potremmo metterlo nel quadrante Kakuro-Freccia (il lavoro sugli attori-la tecnica di montaggio drammaturgico). Robert Lepage sarebbe piuttosto Spirale (per la forte componente autobiografica di certi suoi lavori) e abbastanza Sudoku (per l’abilità con cui oggettiva e compone i materiali). I Motus sono più Sudoku-Freccia, Fanny & Alexander più Spirale-Kakuro.
Le figure registiche più tradizionali, e i padri storici della regia, tenderanno a posizionarsi verso il centro del nostro piano, vicino allo zero: in un giusto equilibrio tra Sudoku e Kakuro, Freccia e Spirale. Ma per il nostro gusto attuale questi registi produrranno spettacoli abbastanza prevedibili, un po’ accademici, e dunque non troppo interessanti (mentre un tempo se ne apprezzava l’equilibrio e magari la profondità). E’ anche possibile immaginare registi che, nel corso della loro carriera ed evoluzione artistica, si sono spostati nel piano della regia (per esempio da Freccia a Spirale), ma per il momento possiamo trascurare questo dettaglio.
Sistemati nelle diverse caselle alcuni Maestri ed Epigoni, il nostro Piano cartesiano della regia comincia a somigliare alla Tavola periodica degli elementi di Mendeleev. A questo punto, per un giovane regista in carriera, sono dunque sono aperte due strade.
La prima ipotesi di lavoro consiste ovviamente nel riempire le caselle vuote. Quando il geniale chimico russo tracciò la sua tavola, gli restarono molte caselle vuote: elementi chimici che all’epoca erano ancora ignoti ma che “dovevano” esistere in natura, e che infatti vennero scoperti negli anni successivi: gli elementi mancanti, si rilevò, avevano le caratteristiche previste da Mendeleev in base alla loro posizione all’interno dello schema generale. Piano piano la Tavola di Mendeleev si completò, dall’elemento più semplice, l’Idrogeno (un protone e un elettrone), a quello più pesante esistente, in natura, l’Uranio, con i suo 92 protoni ed elettroni.
Consiglio numero uno al giovane regista: scopri le caselle vuote nel Piano cartesiano della regia e riempile con i tuoi spettacoli.
In realtà (consiglio uno-bis) non è davvero necessario trovare una casella vuota. Anche perché probabilmente sono già state riempite tutte sin dagli anni Dieci e Venti del Novecento, in Russia. Va però tenuto presente il Principio della Moda: per un certo periodo i registi paiono concentrarsi su una certa zona del Piano cartesiano della regia, poi la generazione successiva si sposta verso un altro pascolo, e così via.
Consiglio numero due al giovane regista: scopri i pascoli meno frequentati e sfruttati, le caselle dove stanno pascolando meno registi-pecora, e comincia a brucare da quelle parti.
C’è ovviamente un’altra possibile evoluzione, quella seguita dalla fisica nel Novecento, che da un lato ha scoperto – o per meglio dire costruito – elementi chimici con peso atomico superiore a 92 (i cosiddetti elementi transuranici), arrivando ora a sintetizzare numerosi elementi più pesanti dell’uranio e non presenti in natura. Si tratta insomma di allargare i confini della materia conosciuta, estremizzando ulteriormente alcune caratteristiche. La Societas Raffaella Sanzio (che è senz’altro molto Sudoku e piuttosto Freccia) ha lavorato in questa direzione.
Consiglio numero tre al giovane regista: vai oltre il limite, inventati un teatro transregistico.
Ma attenzione. Per arrivare a un teatro transregistico sono necessarie enormi quantità di energia (potenza creativa e/o risorse), e si possono liberare enormi quantità di energia. E’ dunque di una strada piuttosto rischiosa, che può causare gravi danni al regista, ai suoi collaboratori e al pubblico. Tuttavia, muovendosi ai limiti del teatro conosciuto, e forzandoli, si possono ottenere risultati davvero interessanti. Per esempio, lavorare con i carcerati o con i portatori di handicap, può essere molto Freccia. Annettere ai territori della scena nuove tecnologie e discipline, contaminare altre arti, è un’operazione (piuttosto Sudoku) che porta a colonizzare fasce ancora inesplorate del nostro Piano cartesiano della regia (per sua natura, un teatro di poesia spingerà verso la Spirale, un teatro internet verso la Freccia: sul primo versante tenderà a esaltare la dimensione lirico-soggettiva, sull’altro quella della comunicazione, dello scambio e della creazione collettiva).
[Parentesi complicata. In parallelo, la fisica moderna è anche andata a spezzare gli atomi nei protoni, neutroni ed elettroni di cui sono costituiti, mattoni ancora più elementari della materia; in un secondo tempo, gli scienziati grazie a potentissimi acceleratori di particelle, hanno addirittura scomposto queste particelle in altre, ancora più elementari (quark, eccetera). Anche in questo caso sono necessarie grandi quantità di energia. Proseguendo nella nostra metafora teatrale, questa scomposizione potrebbe corrispondere al metateatro, e alla riflessione analitica sugli elementi costitutivi della scena che accompagna la riflessione registica novecentesca. Anche questa, ovviamente, è una strada aperta al nostro giovane regista con velleità subatomiche. Tenendo però presente che si tratta di un lavoro meticoloso e noioso, lungo e ripetitivo, e non garantisce la certezza del risultato.]
Naturalmente questo è solo un gioco. Il critico-studioso vede uno spettacolo, e d’istinto cerca di infilarlo in una delle caselline del suo Piano carteisano interiore della regia (ovvero il suo schema mentale), magari forzando l’interpretazione: crede di giocare a Kakuro e invece quello che ha di fonte è uno schema Sudoku, o magari quello di un altro gioco ancora. Perché in Giappone amano moltissimo i rompicapo con i numeri, e ne inventano sempre di nuovi. Di certo hanno già inventato uno schema ancora più affascinante di Sudoku e Kakuro…
Consiglio numero quattro al giovane regista: corri a cercare un altro giochino giapponese con i numeri e usalo come schema per la tua prossima regia.
Semplicemente complicato (Parte I)
Un incontro con Luca Ronconi
di Oliviero Ponte di Pino
Questo testo è in corso di pubblicazione nel volume Luca Ronconi. Spettacoli per Torino, Umberto Allemandi Editore, Torino, 2005. La seconda parte in ateatro95.
Una trentina d’anni fa, commentando la sua messinscena dell’Anitra selvatica di Ibsen, Cesare Garboli scriveva: “Come sempre, la genialità di Ronconi è di natura semplice”. La recensione apparve sul “Corriere della Sera” il 10 dicembre 1977 (ora la si può leggere in Cesare Garboli, Un po’ prima del piombo, Sansoni, Milano, 1998, p. 328).
E’ un’osservazione curiosa, se applicata a un regista noto e discusso per la complessità dei suoi spettacoli e per l’inventiva imprevedibilità di certe scelte. Applicata, in particolare, a uno spettacolo dove l’uso della macchina fotografica da parte di un personaggio era diventato lo spunto intorno a cui costruire la regia: una articolata macchina spettacolare con paratie mobili sezionava la scena teatrale in inquadrature fotografiche, per suggerire una riflessione sul rapporto con il tempo tra un medium della continuità (il teatro) e un medium dell’istantaneità (la fotografia), oltre che naturalmente tra il flusso della vita e la fissità della morte.
L’elenco degli azzardi ronconiani è lungo. Comprende molti dei suoi spettacoli più belli e geniali, ma anche qualche fecondo fallimento – perché Ronconi ama rischiare, e la possibilità dell’errore fa parte del suo percorso di ricerca, da sempre.
Una piccola antologia di strabilianti invenzioni ronconiane può prendere le mosse dal Riccardo III di Shakespeare, protagonista nel 1968 Vittorio Gassman.
Riccardo III è stato uno dei pochissimi testi che ho fatto su commissione, perché l’ha scelto Gassman, la proposta me l’ha fatta lui, forse su consiglio della sua ex moglie Nora Ricci. Riuscì proprio bene: c’era un cast fantastico, ci fu anche lì della gente che s’infuriò. Ma se la gente s’arrabbia, va pure bene…
Dallo Stabile torinese, che gli affida l’incarico, arriva con quel Riccardo III la prima consacrazione per un regista emergente. Il suo talento era esploso nell’estate del 1966, con il clamoroso e sorprendente successo di un dimenticato testo elisabettiano, I lunatici di Middleton e Rowley: il pubblico era rimasto sconvolto ed entusiasta, la critica aveva subito citato il teatro della crudeltà di Artaud e il Marat-Sade di Brook.
Per quel Riccardo III torinese, Ronconi non chiama uno scenografo ma utilizza le sculture di ferro e legno di Mario Ceroli, creando una claustrofobica scatola scenica di primitiva potenza (il regista progetta anche ingombranti costumi “materici”, dal fascino primitivista, che non potranno però essere utilizzati dagli attori). Sulla scia di Jan Kott – anche se per Ronconi i classici non possono certo essere banalmente “nostri contemporanei” – in scena campeggia “la grande scala del potere”; alla fine il sovrano “muore non ucciso da nessuno, in una battaglia che non ha luogo, travolto dall’apparire di enormi manichini di legno senza spessore, simbolo del Grande Meccanismo della storia” (Franco Quadri, La politica del regista, Il Formichiere, Milano, 1980, pp. 450-451).
Se lo scenografo è un artista come Mario Ceroli, la cosa migliore è usare le sue opere e non costringerlo a concepire una scenografia, che non è il suo mestiere. Per esempio, nel caso di Riccardo III, Ceroli aveva già fatto quella scala e quelle sagome. Con gli architetti è più difficile perché l’architettura, già di per sé, tende a essere vincolante, condizionante. Faccio un esempio. Nei miei spettacoli spesso le scene si muovono. Il motivo non è perché è bello far muovere il palcoscenico ma perché, probabilmente, siamo condizionati dal cinema, ed è importante che nel campo visivo ci sia solo ciò che serve in quel momento e che vada via quando non serve più.
L’anno dopo, per una Fedra sorprendentemente minimalista, condanna gli interpreti all’immobilità, all’interno di una scenografia semplicissima che li imprigiona per tutta la durata dello spettacolo, a declamare le torrenziali e furibonde invettive di Seneca.
Passano pochi mesi e quasi come contrappunto Ronconi crea con l’Orlando furioso una delle messinscene più movimentate dell’intera storia del teatro. Il poema epico-cavalleresco di Ludovico Ariosto, condensato dal poeta Edoardo Sanguineti intorno ad alcuni personaggi e nuclei narrativi, si trasforma in uno spettacolo-festa che invade chiese e piazze e diventa uno dei simboli della rivoluzione teatrale di quegli anni. L’Orlando furioso, che debutta nell’estate del 1969 al Festival dei Due Mondi di Spoleto, aggredisce e sorprende il pubblico da due palcoscenici scomponibili e mobili posti alle due estremità dello spazio scenico, ma anche irrompendo con carrelli di legno spinti dagli attori nella zona centrale occupata dagli spettatori, che vengono dunque utilizzati come una sorta di “scenografia vivente” e costretti ad assecondare l’azione, che spesso si sviluppa simultaneamente in più luoghi. Lo spettatore, spiega Ronconi,
fondamentalmente si trova (…) davanti a due scelte: o partecipa al gioco che gli proponiamo, o si mette in disparte e sta a guardare. E in questo caso si annoierà, perché, ripeto, lo spettacolo va vissuto, non certo visto e giudicato. Se, al contrario, lo spettatore entra nel gioco potrà, immediatamente, essere parte viva, attiva di esso.
(Un teatro dell’ironia, colloquio di Edoardo Sanguineti con Luca Ronconi, “Sipario”, nn. 278-79, giugno-luglio 1969, p. 71, cit. in Franco Quadri, Il rito perduto.Saggio su Luca Ronconi, Einaudi, Torino, 1973, p. 91)
L’Orlando furioso è uno straordinario successo, anche internazionale. Lo stesso Ronconi ne trarrà una memorabile riduzione per la televisione, trasmessa dalla Rai in cinque puntate nel 1975.
Un successo internazionale – prodotto da una cooperativa autogestita, come l’Orlando furioso – è anche la successiva “monumentale” Orestea, sette ore di viaggio alle origini della tragedia.
Motivo essenziale della tragedia è proprio il progressivo trasformarsi del mito e del senso dei miti, sia all’interno dell’opera di Eschilo, che nella relazione tra questa e le diverse epoche.
(Luca Ronconi, in Franco Quadri, op. cit., p. 200)
Bloccata al debutto romano “per la pretesa insicurezza del complesso di ascensori incorporato”, l’Orestea trionfa al Bitef di Belgrado nell’estate del 1972, dove vince il primo premio ex aequo con il Torquato Tasso diretto da Peter Stein, superando Yerma di Victor García e il Sogno di una notte di mezza estate di Peter Brook: Ronconi è in prima fila tra gli artisti che in quegli anni stanno rivoluzionando la regia e l’idea stessa di teatro.
Come in tutti i miei precedenti lavori, invece di puntare su una visione univoca del testo, preferisco organizzare lo spettacolo (e del resto è la lettura del testo stesso a suggerirlo), sulla compresenza di diverse interpretazioni: l’opera di Eschilo non viene considerata un blocco monolitico, ma, secondo il principio di discontinuità, un insieme disuguale che dia luogo a uno spettacolo scrupolosissimo, rispettoso del testo stesso ma fatto di tanti prismi, di dissimili frammenti, destinati a ricostruirsi in un tutto alla fine nella mente dello spettatore.
(ivi, p. 199)
Questa attenzione puntuale al testo – o meglio, a ogni singola battuta e parola, contro una lettura ispirata a un senso unificante dell’intera opera – è da sempre una delle caratteristiche del suo approccio al teatro di interpretazione. Il regista non è più il garante della coerenza e dell’organicità dell’opera, un partito preso destinato inesorabilmente a risolversi in un allestimento in cui i diversi piani (recitazione, gesti, scena, costumi, luci, musiche, luci, eccetera) vengono più o meno forzosamente armonizzati in una cornice unitaria. Al contrario, il regista e i suoi attori amano lavorare sulle zone d’ombra, sulle contraddizioni interne, sulle linee di frattura del testo e della rappresentazione, cercando di mantenere viva e pulsante la molteplicità (contraddittoria, irrisolta) dei significati. Come spesso accade in Ronconi, una lettura di questo genere impone quasi immediatamente l’invenzione di uno spazio; o meglio, di una serie di spazi.
L’Agamennone è intuito in uno spazio ancora magmatico, una zona cosmica, pressoché siderale; nelle Coefore l’azione si restringe entro l’ambito delle mura di una casa; mentre le Eumenidi vanno a situarsi nelle vie di una ipotetica città, preistorica come futura.
(ivi, p. 208)
Due anni dopo, a Parigi, per XX (La Roue) Ronconi occupa una palazzina con venti stanze. In ciascuno dei locali un gruppi di venticinque spettatori assiste ad alcuni frammenti del testo (scritto per l’occasione da Rodolfo Wilcock, avendo per tema un colpo di stato fascista), mentre nelle altre stanze si recitano in simultanea le altre diciannove scene. Poi la parete divisoria si apre e due stanze vengono unificate, e il meccanismo si ripete; alla fine tutte le pareti si alzano, in un’altra esplorazione della simultaneità delle azioni teatrali e del rapporto tra il testo, il personaggio e l’attore (in effetti, venti attori, metà italiani e metà francesi, che recitano nelle due lingue).
Nel 1971 Kätchen von Heilbronn di Heinrich von Kleist a Zurigo dovrebbe essere recitato su una piattaforma galleggiante sul lago, ma per motivi di sicurezza viene ricondotta in spazi più convenzionali. Passano gli anni e Ronconi non dimentica quel sogno acquatico: nel 1985, per Commedia della seduzione del prediletto Arthur Schnitzler, la scenografia di Margherita Palli utilizzerà “delle tavole scorrevoli, galleggianti sopra o intorno all’acqua” che invade il palcoscenico (Franco Quadri, “Panorama”, 31 marzo 1985).
Allestimento “impossibile” (e funestato dall’acqua) si rivela anche Utopia, meditazione sul tema del titolo a partire dalle commedie di Aristofane. Lo spazio scenico è una strada lunga cinquanta metri, tra le due gradinate su cui è sistemato il pubblico: la percorre una processione inesauribile di uomini, automobili e persino un aereo (tutti dipinti di ironico rosa…) in marcia verso un progresso forse illusorio. Lo spettacolo debutta nel 1975 alla Biennale Teatro di Venezia, che lo stesso Ronconi dirige per due vibranti edizioni, dal 1975 al 1977: in quegli anni passano in laguna con spettacoli e laboratori tra gli altri Jerzy Grotowski, il Living Theatre, Peter Brook, Robert Wilson, Meredith Monk…
Però poi la tournée che dovrebbe portare quella rosea Utopia nelle strade e nelle piazze (e nelle Feste dell’Unità) viene funestata da “traversie, contrattempi e disgrazie” causati soprattutto da “un cielo inclemente” (Cesare Garboli, op. cit., p. 144-45). Tanto è vero che dopo quell’esperienza Ronconi cercherà di evitare gli spettacoli all’aperto.
Negli anni successivi il regista è ideatore e artefice del Laboratorio di Progettazione Teatrale di Prato (con la complicità dell’architetto Gae Aulenti, anche in veste di scenografa). L’ambizione, più che auto-celebrativa, è auto-analitica. Si tratta di rifondare la grammatica scenica, a partire dai suoi elementi costitutivi: il tempo, lo spazio, il rapporto attore-personaggio e quello wittgensteiniano parola-pensiero, e – sullo sfondo – il rapporto del teatro con il pubblico e dunque con la città (anche se quest’ultimo aspetto resterà soprattutto a livello di intenzioni). L’impegno di Prato – la messa a punto di un metodo di lavoro destinato a riverberarsi negli anni successivi – si concretizza un memorabile trittico. La Torre di Hugo von Hoffmansthal (l’unico dei tre testi a essere rappresentato per intero) è ambientato in un ex stabilimento tessile, il Fabbricone, sul cui soffitto è stato riprodotto l’affresco che il Tiepolo ha dipinto nella reggia absburgica di Wurzburg: ne esce uno spettacolo-monstre che dura oltre dieci ore distribuite in due giornate, dove si esplorano tutti i possibili intrecci spaziali tra il pubblico e gli attori. Il Calderón di Pasolini unifica palcoscenico e platea del Teatro Metastasio come spazio destinato agli attori, costringendo gli spettatori nei palchi. Nelle Baccanti di Euripide – per 24 spettatori – tutti i ruoli vengono affidati a un’unica attrice, la straordinaria Marisa Fabbri, in una performance itinerante che attraversa ed esplora le stanze di un antico collegio.
Nel 1986 per Ignorabimus di Arno Holz, un altro testo interminabile (oltre 240 pagine), pressoché irrappresentabile e dimenticato d’inizio Novecento, sempre all’interno del Fabbricone, fa costruire dalla fida Margerita Palli una struttura scenografica in muratura, una sorta di facciata che si ribalta in un interno, con
materiali da costruzione come cemento, asfalto, brandelli di marmo, di stucco (…) per dare una scala che non è quella naturalistica, però l’impressione di più vero del vero.
(intervista di Gianfranco Capitta, “Westuff”, giugno-agosto 1986)
Questo spazio dentro-fuori, ambiguo, insieme vero ma non realistico, ospita una nuova maratona, più di undici ore filate (rispetto alle ventiquattro ore del 13 maggio 1912 che occuperebbe effettivamente l’azione della pièce). Ignorabimus si chiude con una trovata che avrebbe dato le vertigini all’inventore della teoria della relatività: minuto dopo minuto, accelerando o rallentando il moto delle lancette, gli orologi in scena adattano la loro velocità alla scansione dei tempi enunciata dal testo, che evidentemente non coincide con lo scorrere del tempo “reale”. A interpretare quello che è “il più naturalistico dei testi e insieme non lo è” sono quattro attrici (Marisa Fabbri, Edmonda Aldini, Franca Nuti e Anna Maria Gherardi) che si esibiscono in uno strepitoso tour de force, incarnando altrettanti anziani professori, ingoffite in abiti grigi e sfigurate da maschere e parrucche (con loro Delia Boccardo, cui tocca l’unico personaggio femminile). Peraltro Marisa Fabbri, generosa compagna di alcune tra le più spericolate avventure ronconiane, già nei Lunatici aveva interpretato un ruolo maschile, quello del governatore Vermandero.
Ronconi ricorre spesso allo scarto tra l’identità sessuale dell’attore e quella del personaggio, a esplicitare la convenzionalità del rapporto che li lega o per portare in primo piano certe ambiguità del testo. Nel 1996 fa interpretare il ruolo di Medea da un Franco Branciaroli vestito di una misera sottoveste nera. Nel 2003, al Teatro Farnese di Parma, porta in scena Peccato che fosse puttana di John Ford alternando due cast, uno di attori e attrici, l’altro di soli uomini.
Se faccio due versioni non è per farne una “come la facevano gli elisabettiani” con i ragazzi al posto delle donne ma perché, testo alla mano, mentre il rapporto tra Giovanni e Annabella [i due fratelli incestuosi protagonisti della tragedia, n.d.r.] è un rapporto chiaro, per niente ambiguo (si capisce benissimo cosa vogliono l’uno dall’altra, di che tipo di scambio o, meglio ancora, di non-necessità di scambio si tratti), i rapporti tra ciascuno di loro e i loro mentori – il Frate, la Governante – sono talmente ambigui che è difficilissimo capire se i personaggi maturi sono protettivi o se sotto le apparenze e i modi della protettività si nasconde invece la distruttività.
(intervista di Giovanni Raboni, dal programma di sala dello spettacolo)
In altre occasioni il casting crea uno scarto tra l’età anagrafica dell’attore e quella del personaggio, come nelle Tre sorelle, con attrici più mature rispetto all’età che Cechov aveva assegnato a Olga, Mascia e Irina.
Per accentuare il recupero di un tempo ormai svanito mi sembra legittima l’idea della non corrispondenza fisica delle tre protagoniste. Si tratta di un artificio drammaturgico, sulla scorta di parecchie indicazioni del testo. Il teatro di Cechov è pieno di ironia proprio perché lui mostra di saperne molto di più dei suoi personaggi: conosce in anticipo i loro tic, le loro manie, lo sviluppo del loro destino. Per mantenere queste sottigliezza ironica bisogna fare la stessa cosa con gli attori, informandoli un pochino di più sui personaggi, cosa che si può fare soltanto con una trasposizione, cioè leggendo il testo in modo da restituire quello che forse voleva comunicare ai suoi tempi.
(intervista di Donata Gianeri, “Stampa Sera”, 6 marzo 1989)
Nel 2002, quasi al culmine di questa sfaccettata esplorazione del tempo e dello spazio, Ronconi porta addirittura in scena l’infinito. L’idea di partenza è quella di mettere teatralmente a confronto – per innescare una feconda ibridazione – teatro e scienza, rifiutando le strutture drammaturgiche consuete (a cominciare dai testi che hanno gli scienziati come protagonisti), che riconducono la scienza entro i codici della rappresentazione; ma anche evitando le forme abituali della presentazione scientifica, come la conferenza.
Negli ultimi decenni, la drammaturgia ha dimostrato altre possibilità di fare teatro, per esempio attraverso lo spazio e la dilatazione (o la contrazione) del tempo che sono diventati delle figure teatrali, delle strutture drammaturgiche da usare, esattamente come il dialogo o il personaggio, che sono stati usati per secoli. Ne consegue la possibilità che un argomento, diciamo scientifico – ma potrei dire anche biologico, di alta finanza, economico -, può entrare in teatro non mascherato come il teatro tende sempre a fare, ma per quello che è, con le proprie asperità e difficoltà. Proprio da questo è nato il proposito di cercare di vedere se ci può essere un punto d’incontro a metà strada fra teatro e scienza che non sia tutto dalla parte del teatro o tutto dalla parte della scienza, o tutto formale tra virgolette e tutto divulgativo fra virgolette.
(intervista di Maria Grazia Gregori, dal programma di sala dello spettacolo)
Nasce così in un’altra vecchia fabbrica, alla Bovisa, nella periferia nord di Milano, Infinities, a partire da cinque testi saggistici dello scienziato John Barrow.
Volendo dare una struttura “infinita” allo spettacolo è stato indispensabile, necessario, trovare una soluzione spaziale e temporale che la riflettesse. Qui la situazione temporale è offerta dalla simultaneità, la spaziale invece della moltiplicazione degli spazi, da cui deriva non un teorema, ma semplicemente il fatto che all’interno dello spettacolo c’erano tanti spazi quante erano le sequenze. Ovviamente ciascuna di queste rimandava alle altre. E se, poniamo, come succedeva nella terza sequenza, il tema era quello della replicazione infinita, questa infinita replicazione era presente anche nello spettacolo dove le sequenze si ripetono per ben dieci volte. Ma siccome nel testo si parla anche di una possibilità di discontinuità e di “salti” della natura, le sequenze si ripetevano e il testo era ripetuto, ma in modi spesso differenti. Il movimento è la metafora del tempo e la rappresentazione del movimento è una delle metafore per rappresentare il tempo. In Infnities la sfida si è concentrata nella rappresentazione possibile dei rapporti fra tempo e spazio.
(ivi)
A volte le invenzioni ronconiane possono ricordare il gesto di un artista visivo. E’ quasi una installazione quella che realizza nell’estate del 2002, quando si misura per la seconda volta (dopo aver utilizzato il testo per un saggio per gli allievi dell’Accademia d’Arte Drammatica di Roma nel 1987) con Amor nello specchio di Giovan Battista Andreini. Con lo scenografo Marco Rossi lastrica corso Ercole d’Este, che corre davanti al Palazzo dei Diamanti, con una superficie – per l’appunto – specchiante, creando un colpo d’occhio abbagliante e vertiginoso. Perché al regista non interessa certo l’effetto-verità che si può ottenere ambientando lo spettacolo in uno spazio della quotidianità.
La commedia di Andreini, secondo me, soffrirebbe a essere rappresentata in una ambientazione “veristica”, in una “vera” strada o in una “vera” piazza. Sono altre le sue particolarità: se ne rispecchia meglio il carattere ponendola in un luogo più astratto: meglio le piazze italiane di De Chirico che non l’ambientazione realistico/popolaresca di tanto teatro italiano del rinascimento, e anche del Seicento.
(intervista di Gianfranco Capitta, dal programma di sala dello spettacolo)
Tutti questi exploit impallidiscono però di fronte a quello che finora resta il super-kolossal ronconiano, Gli ultimi giorni dell’umanità di Karl Kraus, allestito nella ex Sala Presse del Lingotto, il più famoso degli stabilimenti della Fiat (attualmente quello spazio fa parte del complesso fieristico torinese). E’ un momento chiave della storia di Torino: la scelta di allestire uno spettacolo in quel luogo crea un evento simbolico che segna la riconversione di una città industriale, automobilistica, al terziario.
Gli ultimi giorni dell’umanità è sì un testo teatrale ma pressoché irrappresentabile nelle sue duecentonove scene: per allestirlo, secondo lo stesso Kraus, sarebbe stato necessario “un teatro di Marte” e centocinquantasei ore distribuite in una decina di giorni.
Quando ho visto la sale presse del Lingotto mi è preso un colpo, con tutti quei pilastri… Mi sono detto: “Pazienza, non si può fare…”. Ma io Gli ultimi giorni dell’umanità volevo proprio farlo, da anni, anche se davvero non sapevo come. Una notte, viaggiavo in treno nel vagone letto Roma Termini-Milano, e mi dicevo: “Devo trovare qualcosa, qualcosa per cui venga naturale il movimento. Con tutti quei pilastri, bisogna fare uno spettacolo che si muova, altrimenti… Bisogna che ci sia un movimento continuo, per cui il movimento in qualche modo non sia ostacolato, qualcosa per cui quello non sia più un pilastro”. Avevo due alternative. Fare uno spettacolo mettendo il pubblico a sedere, ma non avrebbe funzionato. Ma se il pubblico fosse stato in piedi, ogni spettatore avrebbe visto tutti gli altri spettatori. Bisognava che il pubblico avesse un significato, che fosse un personaggio. E abbiamo adottato lo schema con il pubblico in mezzo, circondato da una specie di corona di macchine tipografiche. Oltre le macchine tipografiche, il campo di battaglia: il fronte ovest, il fronte sud, il fronte nord, il fronte est. Una mappa. Ho bisogno di immaginare una mappa, di generare una mappa dello spazio. Specialmente in uno spettacolo non frontale, dove non è possibile il dialogo. Come potevo farlo? La mattina mi sono svegliato con l’idea: se avessimo usato dei vagoni ferroviari, non sono nati per trasportare? E, se ci sono vagoni, ci sono binari.
Cosi le Ferrovie dello Stato posano un chilometro di strada ferrata, che collega di nuovo il Lingotto alla rete nazionale. I vagoni possono scorrere sui tre lati della sala, tutto intorno al pubblico, nel corso di quattro ore di strabilianti “effetti speciali teatrali”.
L’uso del pubblico come personaggio è un elemento imbarazzante, se dichiarato ostentatamente. Non lo è solo se fa parte di un processo naturale. Il pubblico deve sempre rimanere pubblico. D’altra parte, penso che il pubblico sia un personaggio anche quando è seduto in poltrona. Chi assiste allo spettacolo, lo condiziona esattamente, o quasi, quanto gli attori. Se qualcuno guarda uno spettacolo in mezzo a una platea distratta, è difficilissimo che resti concentrato. Se tutti si divertono, è probabile che le sue reazioni siano condizionate dalle risate altrui. O si uniforma o se ne distacca, ma non sarà più in un rapporto oggettivo con ciò che succede sul palcoscenico. Faccio un esempio. Guardavo il filmato degli Ultimi giorni dell’umanità in televisione e c’era una scena impressionante, un funerale. Non dico che le persone del pubblico dovessero rappresentare i parenti delle vittime, ma erano vicino a un feretro e sembrava che recitassero.
Per lo spettatore la serata al Lingotto non deve essere un normale spettacolo, ma un vero e proprio avvenimento.
Assistere a questo spettacolo vuol dire provare al massimo grado il gusto del teatro. Qui non si guarda una rappresentazione: la si visita, o meglio, la si attraversa. Come un evento, come una processione, una manifestazione di piazza, una mostra d’arte.
(intervista di Fiona Diwan, “Grazia”, 29 novembre 1990)
Quando Ronconi allestisce Gli ultimi giorni dell’umanità, nell’inverno 1990-91, sta per scoppiare la Prima guerra del Golfo (e forse inizia quella che in futuro chiameranno Terza guerra mondiale). La gioiosa festa popolare dell’Orlando furioso si ribalta in una inquietante denuncia dell’euforia bellicista, la stessa che ha portato all’“insensata strage” della Grande guerra e che ora spinge a nuovi conflitti. Oltretutto il Lingotto è un luogo della memoria, fino a poco prima teatro di lavoro, di fatica e di lotte operaie.
Quelli della Fiat ci hanno addirittura dato un camion, quello su cui entrava in scena Anna Maria Guarnieri. Era stato fatto lì, in quello stesso luogo. Anche i brani della musica dello spettacolo erano stati realizzati là dentro. Non c’era neanche bisogno di sentirla, c’era.
Un camion FIAT, modello 18BL, era stato ampiamente utilizzato nel corso della Prima guerra mondiale e nel 1934 a Firenze era diventato il protagonista di un altro spettacolo-kolossal, intitolato appunto 18BL, la velleitaria risposta del regime fascista al “teatro delle masse” della Russia sovietica (vedi Jeffrey Schnapp, 18BL. Mussolini e l’opera d’arte totale, Garzanti, Milano, 1996). A sottolineare il corto circuito tra attualità e memoria – mentre proprio in quei mesi la CNN si afferma grazie ai suoi servizi da Baghdad – è la riflessione sul ruolo e sul potere dell’informazione che Kraus aveva lucidamente (e profeticamente) individuato e che Ronconi rilancia con angosciante efficacia. Inutile aggiungere che come e più che in altre occasioni si scatena una feroce polemica, a cominciare dai costi dell’operazione, inconsueti per il teatro italiano.
Io sono un moralista. E allora dirò prima di tutto che mi scandalizzo se un teatro pubblico paga un attore due milioni a recita. Non se fa un’operazione culturale. Aggiungerò poi che di quei cinque miliardi [di lire, n.d.r.] soltanto una parte (un po’ più di due e mezzo) è spesa dallo Stabile [il teatro pubblico torinese che produce lo spettacolo, n.d.r.]: il resto arriva dagli sponsor, che per la prima volta sono intervenuti in modo davvero massiccio in un’operazione teatrale: con denaro o con materiali. (…) Una quantità davvero impressionante di enti pubblici e privati è intervenuta in modi diversi. Vuol dire che hanno creduto in quello che stavamo facendo. E allora era necessario dare una risposta grande. Non potevamo ricambiare la città, che ha investito molto in questa operazione, con uno spettacolo tradizionale, magari ben fatto, ma normale. Qui ci voleva l’evento. Che potrà non piacere, ma che sarà evento in ogni caso. Uno spettacolo di qualità non ci bastava, volevamo di più, il non-teatro.
(“Hystrio”, anno IV, n. 1; in generale sulla vicenda vedi Gli ottimisti e i criticoni. Le polemiche intorno agli “Ultimi giorni dell’umanità”, a cura di Oliviero Ponte di Pino, Il Patalogo 14, pp. 273-283)
L’elenco delle incursioni ronconiane nel “non-teatro” si potrebbe facilmente ampliare, magari sconfinando nel teatro musicale, dove da decenni lavora con continuità (e dove naturalmente si è misurato con una intelligente rivisitazione del ciclo del Ring wagneriano, tra Milano e Firenze, dal 1974 e il 1981). Tra tutte le invenzioni di Ronconi nel teatro lirico, basti un delizioso esempio che può dare l’idea del suo impatto eversivo su una tradizione piuttosto ingessata, Il viaggio a Reims di Rossini (1984), che narra l’attesa dell’incoronazione di Carlo X di Francia. Mentre sul palcoscenico si svolge lo spettacolo, con i diversi personaggi rossiniani che si ritrovano in un albergo dell’antica capitale francese per prepararsi alla cerimonia, all’esterno – nelle strade e nelle piazze intorno al teatro – inizia a muoversi il corteo reale, che gli spettatori possono seguire attraverso un collegamento video. Finché, dopo un breve percorso attraverso la città, il re e il suo seguito non fanno il loro ingresso dal fondo della platea, in carne e ossa.
Di fronte a questa autentica Wunderkammer registica, parlare di “natura semplice” può sembrare quanto meno azzardato. Ronconi pare piuttosto un artista in grado di creare e di governare la complessità, nell’approccio ai testi come nell’uso sapiente e anticonvenzionale dello spazio e del tempo; e di conseguenza nella gestione di macchine sceniche articolate e spesso in costante movimento, destinate – tra gli effetti collaterali – a creare nello spettatore una barocca meraviglia. Ma di fronte alle perplessità suscitate da certe sue scelte – perché sceglie testi dimenticati o eccentrici, perché ama invadere spazi non teatrali, perché raccoglie cast bizzarri, perché i suoi spettacoli sono spesso lunghissimi – la riposta è, appunto, di disarmante chiarezza.
Mi si chiederà perché non scelgo di fare dei testi diversi. Ma rispondo: perché la durata dev’essere il criterio determinante di uno spettacolo? Vogliamo vietarci di fare il secondo Faust o l’Orestea perché durano troppo? (…) Anche l’idea dello “spettatore medio” è una generalizzazione impropria: esso si forma sullo spettacolo medio. Personalmente non sono interessato a questo tipo di spettacolo.
(intervista di Renzo Tian, “Il Messaggero”, 5 marzo 1985)
Tramontata definitivamente l’epoca del teatro come rito culturale borghese così come quella dell’acculturazione nazional-popolare, c’è in Ronconi la consapevolezza che assistere a uno spettacolo teatrale debba essere in qualche mondo un evento, uno scarto rispetto alla quotidianità, ma anche e soprattutto un’esperienza diversa rispetto alla comunicazione dei mass media (di cui in ogni caso chi fa teatro deve tener conto). Che queste provocazioni vengano poi riprese e amplificate dalla stampa, è una conseguenza inevitabile. Ma l’importante è che l’esperienza dello spettacolo incida nella sensibilità e nella consapevolezza dello spettatore.
Al teatro che esiste oggi manca il carattere di avvenimento. Andando a teatro vediamo solo ciò che sta avvenendo sul palcoscenico. A me non basta.
(“Tuttolibri”, 1° dicembre 1990)
Insomma, l’eccezionalità ronconiana nasce da una insoddisfazione assai diffusa e immediata.
L’osservazione sfuggita a Garboli, finissimo critico letterario ma soprattutto straordinario rabdomante della personalità degli artisti, diventa ancor meno incongrua per chi ha avuto la fortuna di incontrare Luca Ronconi. Appena incrinato il muro della sua proverbiale timidezza (un po’ meno granitica, per la verità, negli ultimi anni) si viene subito contagiati dal suo entusiasmo per il lavoro teatrale, dalla gioia quasi infantile di poter inventare nello spazio scenico. E magari si scopre che le invenzioni più azzardate possono avere motivazioni semplicissime, o nascere da curiosità elementari, da quelle domande che non abbiamo più il coraggio di farci. Domande sul teatro, sulle parole che diciamo, sullo spazio in cui ci muoviamo, sulla nostra identità di persone e di personaggi, sulla realtà in cui viviamo, sulla nostra tradizione culturale… Domande che mettono in questione il nostro modo di essere e comunicare, le forme del linguaggio e quelle della rappresentazione.
Allora val forse la pena di scalare la “complicata semplicità” di Ronconi da un altro sentiero, più personale e meno legato ad aspetti esteriori, quasi esibizionistici. Per cominciare c’è la tranquilla naturalezza del suo rapporto con il palcoscenico, che affonda le radici nell’infanzia. Nato a Susa, in Tunisia, l’8 marzo 1933, torna quasi subito a Roma con la madre, che fa l’insegnante. Vanno molto spesso a teatro e la prima esperienza - volendo – è già rivelatrice.
Come spettatore sono stato precocissimo. La prima volta che sono stato a teatro avevo quattro anni, quattro anni e mezzo, l’ho già raccontato un sacco di volte. Mia madre mi ha detto “Andiamo a teatro” e mi ha portato a vedere una commedia. Me lo ricordo ancora perfettamente, anche se poi ovviamente non so se me lo ricordo davvero o perché me l’hanno raccontato, come accade nei ricordi infantili. Ritengo che la testimonianza sia un po’ romanzata, ma fondamentalmente attendibile. Non mi ricordo il titolo dello spettacolo, credo fosse una commedia di Gilberto Govi, però sono sicuro che ci fosse una gallina, che parlassero di una gallina. Mi hanno portato via prima della fine perché strepitavo: mia madre mi aveva promesso che la scena sarebbe cambiata, io invece durante l’intervallo avevo capito che non sarebbe cambiata perché c’era un pezzo di tappeto che sbucava là sotto il sipario e non si muoveva. Così ho detto: “Vedi, non la cambiano, la scena, perché il tappeto resta lì”. E ho iniziato a strepitare, finché non mi hanno portato via perché facevo troppo chiasso.
Quella è stata la prima volta che sono andato a teatro, poi ci sono tornato spessissimo, e ho continuato. E da sempre, anche da ragazzino, sapevo che sarei andato a finire in teatro. Non sapevo come avrei potuto farlo, se come attore o come regista, anche se all’epoca il regista non era una figura così definita. Avrei potuto fare lo scenografo, il costumista, il macchinista, non so, ma sapevo che quella era la mia calamita. Non ho mai avuto il minimo dubbio. La stessa cosa mi è successa per tutte le scelte fondamentali. Non ho mai avuto problemi di scelta, non mi sono mai chiesto: “Che cosa faccio?”. Sulle due o tre decisioni fondamentali – che rapporti avrò con la gente, quale sarà il mio lavoro, quale sarà la mia vita affettiva – non ho mai avuto dubbi. Certo, in questo modo perdi tantissimo, perché perdi tutto quello che escludi, però eviti tanti conflitti con te stesso. Non ho trovato la mia identità attraverso la difficoltà della scelta, ma attraverso una determinazione: “Andiamo lì, e poi vediamo”.
Insomma, la vocazione è ineludibile, favorita oltretutto dall’ambiente familiare.
Avevo tantissimi amici e parenti. Mia madre aveva sette tra fratelli e sorelle, e tantissimi avevano interessi letterari o teatrali. Quella di cui proprio ero pazzo era una mia cugina, Maria Teresa, più grande di me di una quindicina d’anni, che faceva l’attrice. Mi piaceva moltissimo perché subito dopo la guerra si era iscritta a questa cosa nuova, l’Accademia d’Arte Drammatica. Ci volevamo bene, e attraverso di lei, quando ancora facevo il liceo, ho cominciato a conoscere i suoi compagni di corso, per esempio Nino Manfredi l’ho conosciuto quand’ero ragazzino. In quell’ambiente mi sono subito trovato a mio agio. Non sono entrato nel mondo del teatro grazie ai miei genitori – mia madre era professoressa di liceo – ma non l’ho mai visto come un mondo estraneo, mitico: era una cosa che si poteva fare, invece di fare l’università avrei potuto fare l’Accademia. Così appena finito il liceo Maria Teresa mi ha fatto la spalla all’esame d’ammissione e sono entrato in Accademia.
Fino al mese prima ero un adolescente musone, buio. Non mi ricordo quasi niente di quel periodo, ma tutto sommato non sono stato un adolescente sereno, avevo grossi problemi che non conoscevo. Quasi da un giorno all’altro, entrando in Accademia sono diventato allegro, mi sono sentito veramente bene e ho cominciato ad avere memoria. In genere ho pochissima memoria, se devo ricordare qualunque cosa faccio sempre confusione, non mi ricordo niente esattamente. All’improvviso era come se avessi trovato il mio posto.
Il giovane allievo attore non ha ancora finito l’Accademia (si diplomerà qualche mese dopo), quando nel 1953 Luigi Squarzina lo lancia come protagonista della sua commedia Tre quarti di luna (una versione dell’incontro tra l’attor giovane e il regista si può trovare in Luigi Squarzina, Il romanzo della regia. Duecento anni di trionfi e sconfitte, Pacini, Ospedaletto (Pisa), 2005, ma diverge in alcuni particolari dalla memoria dell’altro protagonista). Malgrado il successo in quello spettacolo e nei successivi, quella d’attore non è la sua vera vocazione: quando si tratta di andare in scena avverte un crescente disagio.
Come attore ho cominciato molto bene, e poi ho via via perso quota, sia professionalmente sia personalmente. Sentivo che molte delle caratteristiche necessarie a un attore, a me proprio mancavano. Per esempio a un certo punto mi è cascato un dente, e tutti mi dicevano: “Ma guarda, Luca, che così non puoi fare l’attore!” La rappresentazione del sé che è indispensabile per un attore, io non l’ho mai avuta. Probabilmente avrei potuto fare l’attore in un altro tipo di teatro, diverso da quello in cui sono venuto fuori, un teatro in cui il rapporto con il pubblico che è lo stesso che ho adesso, un rapporto di disponibilità reciproca e di libertà. Quando facevo l’attore, ho sempre pensato che l’interferenza della mia identità con il personaggio fosse un problema. Al contrario, una delle cose che mi piace nel lavoro del regista è che posso distribuire la mia identità in tante figure.
Questa conoscenza profonda, anche pratica, dall’interno, del lavoro dell’attore è uno dei suoi atout di regista. Ma anche qui curiosamente emerge una frattura, una discrasia, il conflitto tra due prospettive.
In Accademia la figura di riferimento era Orazio Costa Giovangigli, che mi ha seguito fin dall’inizio con molta attenzione. E’ stato anche un grandissimo maestro di recitazione, ma più di tecnica che di procedimenti interpretativi. Ecco, questa è una cosa che mi è rimasta, non perché Orazio Costa la insegnasse, ma la si ricavava dal suo modo di procedere: riuscire a distinguere tra l’iter interpretativo e la restituzione nell’esecuzione. Sia da parte dell’attore sia da parte del regista, c’è un’invenzione che può essere legittima o arbitraria, innovativa o convenzionale, e questo è un processo interpretativo. E’ un momento che accomuna la figura dell’attore e quella del regista, anche se poi quest’ultimo deve estenderlo a tutta una rete di rapporti e di sguardi, mentre l’attore si limita a definire il proprio percorso.
Ma una perfetta esecuzione – nel senso di prestazione – può anche mascherare una pessima interpretazione, e viceversa. E’ possibile mascherare gli errori di interpretazione con un maquillage anche perfetto, attraverso il virtuosismo oppure la personalità dell’interprete, insomma, qualcosa che appartiene esclusivamente all’attore. Ma può accadere il contrario: una mirabile lucidità interpretativa può essere danneggiata dall’esecuzione, da una tecnica inadeguata. Di questo mi sono reso conto più avanti, quando ho cominciato a dover fare i conti anch’io con questi problemi. Ma se tu sai questo, ti aiuta nel lavoro perché sai che si tratta di mettere in equilibrio due cose di cui una tende a divorare l’altra. Come regista puoi barare, come attore un po’ meno. Persino come spettatore puoi barare, ossia puoi decidere di farti piacere una cosa, mettiamo l’interpretazione, ed essere meno esigente sull’altra, l’esecuzione, o viceversa. Insomma, si apre una rete di possibilità in cui è divertente muoversi.
Ecco, il divertimento: quella di Luca Ronconi sul palcoscenico è autentica felicità creativa. E’ curiosità, è scoperta, è anche gioco – ma un gioco da prendere drammaticamente sul serio, come testimoniano la sua ossessione per il lavoro, la sua dedizione totale, quasi maniacale, e anche le sue memorabili sfuriate durante le prove.
Allora è opportuno accantonare l’elenco delle “eroiche e teatrali imprese” ronconiane. Anche perché nel corso della sua carriera ha firmato numerosi spettacoli meno avventurosi, più ancorati alle abituali forme teatrali – insomma più “normali”. Ha inventato persino allestimenti di ascetica essenzialità: esemplare La serva amorosa di Carlo Goldoni (1986), protagonista Annamaria Guarnieri, dove la scenografia è ridotta a un cumulo di vecchi mobili che, mossi virtuosisticamente sul palcoscenico, forniscono la cornice a una recitazione crudamente realistica.
Va anche notato che quella di Ronconi è una carriera straordinariamente produttiva, condotta a ritmo incalzante, con allestimenti di grande impegno e sempre ad altissimo livello, che conta dal 1963 al 2005 una novantina di regie teatrali, e dal 1967 al 2005 circa settanta regie liriche. E’ anche a causa di questa prolificità che diventa arduo esplorare, storicizzare e studiare un percorso fin troppo ricco e complesso. Senza dimenticare che, per rendere più difficile l’impresa, Ronconi non ama parlare di sé e dei propri spettacoli.
Onestamente non ricordo niente dei lavori già fatti. Ciò che succede dopo la prova generale non mi appartiene più, non è più roba mia. Posso solo raccontare ciò che è venuto fuori durante le prove.
Tuttavia, proprio a partire da questa super-produzione, è possibile tracciare una mappa dei territori prediletti da Ronconi, e individuare così alcuni dei filoni su cui esercita la sua “semplicità”. La ricognizione più immediata riguarda le scelte di repertorio. Anche in una teatrografia così vasta e variegata, è possibile cogliere affinità e idiosincrasie.
La seconda parte di questo testo in ateatro95.
Otellooooooooo!
Otello il nivuru di Mazzaria di Francesco Randazzo
di Anna Maria Monteverdi
OTELLO IL NIVURU DI MAZZARIA di Francesco Randazzo è il vincitore della XIV edizione del Premio Ugo Betti (Comune di Camerino) per la Drammaturgia. L'opera è stata scelta dopo un'accurata selezione che la giuria ha fatto sui 249 copioni pervenuti.

"Otello è un pescatore extracomunitario, un nero che si è perfettamente integrato a Mazara del Vallo, anzi "del Valium", diventando un'autorità cittadina incaricata di occuparsi degli emigrati clandestini che sbarcano a Lampedusa, da lui in segreto cucinati e inscatolati a puntino. La gelosia che scatena il tragicomico finale questa volta non ha per pomo della discordia Cassio ma Emilia, la moglie di Iago, accusata di rapporti omosessuali con Desdemona, mentre è proprio Iago, travestito spesso da donna, a fare frequenti e insistenti avances a Otello (motivo del resto già implicito in Shakespeare).Tra gambe tagliate e teste mozze in un crescendo volutamente inverosimile, il finale è in due tempi: nel primo, Otello e Iago la fanno franca, addossando i delitti ai soliti extracomunitari (nonostante la testimonianza della testa mozzata ma parlante di Desdemona); nel secondo finale, raccontato epicamente da Emilia, i due delinquenti hanno quello che si meritano: Otello è ucciso in carcere e Iago viene fatto fuori dalla stessa Emilia che getta l'asciugacapelli nella vasca da bagno".

Questa la sintesi dell'opera - permeata di "sicilitudine" e di oscenità - tratta dalla motivazione del premio al testo - già messo in scena dalla compagnia degli Ostinati - di Francesco Randazzo, giovane drammaturgo siciliano particolarmente talentuoso, che ha già saccheggiato vari altri premi nazionali; Otello è dunque un extracomunitario immigrato in Italia che ora nella zona del porto di Mazzara del “Valium” fa il pescivendolo, anzi, un vero commercio di carni umane pescate: nella sua pescheria macella, tritura, e inscatola corpi tirati su dal mare di poveracci come lui, e per tirare avanti seduce pure con toni più che espliciti, la figlia di un mafioso.

Come non ricordare che sono anni che nel canale di Sicilia - nella zona del 'mammellone' tra la Libia e la Sicilia - finiscono nelle reti dei pescatori non solo pesci ma cadaveri e resti di uomini e donne morti mentre tentavano di arrivare sulle coste dell'isola..... Mazzara del Vallo è effettivamente il comune italiano che registra la maggior densità di immigrati residenti, in particolare tunisini e maghrebini; ha una delle più grandi comunità islamiche in Italia e la questione dei CPT e dei nuovi centri di identificazione (“galere etniche”, le definisce il settimanale “Carta”) è ancora calda e mette in luce la debolezza della legge Bossi-Fini. Un'umanità alla deriva che nella geniale finzione drammaturgica in siciliano di Randazzo genera addirittura una nuova economia, magari "sommersa" e un bel po' di indotto!
Sfrontata, sboccata, kitsch, addirittura oscena: l'opera è così, trama, linguaggio e personaggi sono così, eccessivi nella loro carnalità, nella loro ignoranza, nella loro nefandezza, nella loro irriverenza. In modo molto poco anglosassone le donne s'accapigliano per gli uomini, gli uomini pensano solo a fottere persone dell'altro sesso o del loro, nel magna magna generale, tra mafiosi, travestiti, fuorilegge e poliziotti accomodanti, ne esce un ritratto non così lontano dalla realtà, tutto sommato, di un mondo che s'arrangia come può, che sfrutta i deboli, che si inebetisce di reality per non pensare alle tasse, all'economia in crisi, al lavoro che non c'è. E' l'Italia “sdemocratica” e del “confritto d’interesse” del nano milanese che garantisce Internet e inglese per tutti, ancor più marcia e ancor più prigione della Danimarca, dove chissà se davvero prima o poi, la giustizia “alla fini, ma proprio alla fini, forsi doppo della fini, attrionfa” .
Stravolgendo Shakespeare
Una intervista a Francesco Randazzo
di Anna Maria Monteverdi
La tua formazione è legata all'Accademia d'Arte Drammatica dello Stabile di Catania: nelle tue interviste parli spesso del debito nei confronti del tuo maestro, Giuseppe Di Martino. Quando hai cominciato a "metterci le mani" nel teatro, a scriverlo e poi a praticarlo come attore e regista per la compagnia degli Ostinati e quali sono i tuoi lavori più recenti?
Ho cominciato a 18 anni, dopo qualche frequentazione teatrale al liceo, al momento d’ iscrivermi all’università a Catania, ho fatto anche il provino alla Scuola d’Arte Drammatica del Teatro Stabile e sono entrato. Di Martino, che era allora il direttore, è stato il mio primo fondamentale maestro, tutto della mia successiva formazione ed esperienza viene dal grande magistero che da lui ho assorbito e, naturalmente, sviluppato, affinato, trasformato e fatto mio, Lo considero un padre, mi ha fatto nascere a Teatro e mi ha insegnato a cercare la mia strada. Dopo la Scuola sono stato suo assistente per tre anni, poi ho provato ad entrare all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, per il corso di Regia e sono stato ammesso. Anche questa è stata un’esperienza formativa formidabile, non soltanto dal punto di vista artistico ma anche umano. Tutto sommato, a ventiquattro anni (allora questa era l’età minima per gli allievi registi) ero un giovane provinciale che approdava a Roma, già soltanto l’impatto con la città era fortissimo. In Accademia c’era un gran movimento di idee, di artisti, intellettuali, attori, registi, scrittori, da Giorgio Pressburger a Luca Ronconi, da Paolo Terni a Elena Povoledo, Massimo Foschi, Andrea Camilleri, Marisa Fabbri, Enzo Siciliano e molti altri, sarebbe impossibile citarli tutti. Sono stati anni molto belli, anche molto duri, naturalmente.
Avevo già quest’esigenza di scrittura, che in Accademia trovò appoggio e sostegno, soprattutto da parte del direttore Musati e di Camilleri che era allora il docente di Regia. Così mi sono diplomato con uno spettacolo su un mio testo, un caso allora abbastanza raro. Ho continuato a scrivere, per il teatro prevalentemente, ma ho pubblicato anche un romanzo, poesie e racconti. Ultimamente ho anche scritto una sceneggiatura per un film, che ha vinto il Premio Sonar Script ed è stata presentata al Torino Film Fest con un reading curato da Affabula/Plot.
Finita l’Accademia ho lavorato, praticamente da subito, soprattutto all’estero e nel corso degli anni ho fatto esperienze, prevalentemente di regia o di drammaturgia, qualche volta anche come attore, in vari paesi: Olanda, Croazia, Stati Uniti, Canada, Venezuela. Ho potuto realizzare molte cose che qui sarebbe stato forse impossibile fare, sicuramente anzi. Però sono tornato sempre, e, nei periodi di mezzo, ho fondato gli Ostinati, con un gruppo di attori. Ho realizzato spettacoli, rassegne, eventi letterari, poetici, teatrali, partecipato a Festival, soprattutto in Sicilia e a Roma. Parallelamente ho tenuto seminari, stages, conferenze e attualmente insegno Storia dello Spettacolo e Recitazione all’International Acting School di Roma. É stato, e continua ad essere, un percorso lungo e travagliato, ricco anche di soddisfazioni, ma devo ammettere che forse avrei fatto meglio a non tornare in Italia… la situazione di questo Paese è pazzesca, tragica, grottesca, non bastano gli aggettivi… Mi ostino ad esserci, come molti d’altronde, a questo punto è un praticamente un dovere.
L'Otello nivuru, vincitore del premio Ugo Betti, è una specie di dark comedy a finale splatter, con un'ambientazione così folle da sembrare addirittura reale in una Sicilia contemporaneamente terra di speranza e di d'espulsione, di approdo o di transito per gli immigrati, e in un'Italia che accoglie gli extracomunitari e poi li maltratta nei CPT. Tu dici che nell'Otello ci sono “situazioni oscene ma oscene per la disperazione, la disperazione della stupidità al potere" ma che in fondo "non c'è murali, inutili circarla". Il nucleo della tua riflessione allora qual è? Quanto il teatro può arrivare a mettere in ridicolo un sistema politico che genera ingiustizia?
È una specie di visione, quest’Otello… avevo la necessità di urlare che stiamo precipitando, ma non volevo essere didascalico, pedante. Da qui l’uso di mezzi espressivi alti e bassi, spinti al limite. La scelta di codici da Commedia dell’Arte trasposti in chiave contemporanea. É tutto sconcio, come questa realtà avvilente, questo degrado, di cui siamo parte. La morale non c’è perché non dev’essere espressa pregiudizialmente, adopero una trappola retorica, la “praeteritio”, dico di non giudicare, per spiattellare tutto come è, al peggio e nel modo più crudele e ridicolo allo stesso tempo, la morale sta già dentro l’enunciazione. Non è uno sberleffo soltanto, è un’azione che spinge al limite il grottesco che viviamo ogni giorno. Il sistema politico è biologicamente ridicolo, le ideologie possono anche aver prodotto disastri, ma avevano anche creato diritti, democrazia, libertà, a carissimo prezzo. Sta crollando tutto. Adesso, senza ideologie dovrebbe esserci qualche idealità quantomeno, etica, sociale, culturale: purtroppo invece, questa è diventata una repubblica fondata sul cabaret, sull’intrattenimento da crociera, finché non ci scontreremo con l’iceberg, quelli in terza classe moriranno prima, quelli in prima, affonderanno ballando.
Il Teatro, sono convinto, deve avere un esigenza di altezza che lo stacchi dalla mediocrità del reale, ma deve anche sapersi sporcare le mani, usando il reale. La realtà non cambia, o perlomeno non lo vedi chiaramente mentre vivi, puoi avere presagi, trasformarli in visioni, tentare di modificare rendendo evidente quello che la collettività, anestetizzata, non riesce a vedere, spostare lo sguardo dei tuoi interlocutori nel complesso della Storia. Provarci almeno. Questo Otello l’ho scritto con questo intento, demistificante e paradossale, e arriva al pubblico come speravo arrivasse: si divertono moltissimo e sul finale restano spiazzati, scioccati forse dalla piega seria, che attraverso lo snodarsi di situazioni grottesche, freddamente e cinicamente, alla fine si afferma.
E se l'autore dell'Otello fosse davvero quel siciliano Messer Florio come sostiene lo studioso Martino Juvara, costretto a riparare in Inghilterra dopo aver scritto un libello eretico, che come si legge "fuggì prima a Venezia, ospite di tale Otello, un tipo irascibile che durante una discussione strangolò la moglie, la signora Desdemona, e quindi riparò in Inghilterra"?
Tutto è possibile… ma perché nessuno dubita mai che Einstein fosse veramente l’autore della Teoria della Relatività, o che Galileo fosse in realtà il cardinale Bellarmino che era schizofrenico? La scienza è esatta anche negli uomini che la praticano, l’Arte è ineffabile, dunque anche l’artista… quindi si può “giocare” a sostituirlo con chiunque si voglia, intriga, diverte, rassicura. In un mio breve racconto parlando di questo, proprio a proposito di Shakespeare, gioco con tutta una serie di paradossi e alla fine mi chiedo: Who is who? Adesso che ci penso, anche mia madre sosteneva di avermi trovato in un bidone della spazzatura, il che mi pone dei seri problemi d’identità. Spero che qualcuno trovi delle prove e me li risolva. Sennò potrei arrivare a convincermi di essere il figlio intelligente di Sofia Loren.
La questione della lingua: come definiresti il tuo testo? Un pastiche? Un colorito siciliano? Un ardito ibrido linguistico?
La terza che hai detto.
Troppu trafficu ppi nenti è il titolo del testo con cui l'agrigentino Camilleri e Dipasquale hanno messo in scena in siciliano Molto rumore per nulla ambientandolo a Messina. Ti sei ispirato in qualche modo a questa operazione di risciaquatura in acque siciliane dei testi shakesperiani? E che valore ha per te ha oggi il ricorrere da parte di una nuova drammaturgia al dialetto? Diceva Camilleri: "E’ la forza dei grandi testi che non solo reggono ad altre incursioni, ma ne traggono nuova linfa. Il dialetto, patrimonio inestimabile di una civiltà, arricchisce, non riduce. Il problema è semmai che oggi, anche da noi, lo si usa poco. Quanto capiranno i siciliani?"
Non ho visto lo spettacolo di Camilleri. Credo fosse una traduzione, più tradizionale, dell’opera di Shakespeare. L’uso del dialetto è per me una valenza poetica in più, di differenziazione anti-omologante, nell’Otello in particolare assume anche un valore d’invenzione d’una lingua che non esiste, un ibrido linguistico, che mescola italiano antico del 400, latinismi, ispanismi e dialetto: come una nuova lingua. Pur essendo stato allievo di Camilleri, credo che in questo caso l’ispirazione sia più vicina al lavoro che Testori fece sul lombardo, naturalmente con le dovute differenze linguistiche, visto che sono siciliano.
La canadese MacDonald ripensa in Buonanotte Desdemona (Buon giorno Giulietta) alle donne dell'Otello e del Romeo e Giulietta come anime orgogliose, lesbiche e intraprendenti: qualcosa di questo filone omosessuale che stravolge oggi Shakespeare ti ha influenzato?
L’omosessualità è un tema che con l’affermazione di tutta una serie di progressive acquisizioni di diritti, sta diventando giustamente e semplicemente un terzo genere di sessualità, la cui ambiguità è da sempre drammaturgicamente potente. Aumentano le dinamiche possibili d’innamoramento ma anche quelle del tradimento. In generale le relazioni e le implicazioni emotive si moltiplicano (non che non fosse così anche prima, ma dovevano essere nascoste, al massimo alluse). Nel testo ho esplicitato le latenze che alcuni critici shakesperiani avevano segnalato ed ho aggiunto il presunto lesbismo di Disdemina e Iemilia. Persino Otello, quando bacia Iaco barcolla un po’ dal suo trucido machismo e confessa a mezza voce: “Non mi ci fece tanto schifio como ci penzava”. Fa ridere, ma è anche questo il disvelamento di una residua ipocrisia.
Cosa hai consapevolmente "saccheggiato" per i tuoi personaggi da Ciprì e Maresco, i "modesti, cinici cantori della fine" come si sono autodefiniti?
Consapevolmente niente. Ma si sa l’inconscio lavora nell’oscurità…
Scaldati diceva che "Napoli respira la commedia, la Sicilia la tragedia". Ti senti un "tragediatore"?
In Sicilia siamo tutti tragediatori, persino ai bambini si dice: “Nun fari traggedie e camina!” o “Mii chi traggedia ca sta facennu pi na minchiata!”. C’ abbiamo dentro la tragedia greca classica e l’opera dei pupi, si sono fissate sull’elica del dna! Battute a parte, sono d’accordo con Scaldati, aggiungerei che da noi si respira tragedia e si espira poesia. Nei casi migliori, naturalmente, e Scaldati, per esempio, ne è un bell’esempio, anche Emma Dante…
La sicilianità come valore aggiunto a teatro: Emma Dante, Davide Enia. Cosa apprezzi del loro teatro?
Emma la conosco dai tempi dell’Accademia e sin da allora ne apprezzo il rigore, la pervicace ostinazione, l’idea pura di teatro che ha creato una personale poetica trasudata sulla scena. Enia non lo conosco personalmente, ma è portatore sano di “valore aggiunto”, indubbiamente! Bisogna anche dire però che questo valore aggiunto in Sicilia è più un ostacolo che un vantaggio…
Sito web: Francesco Randazzo
Blog:
Altri link:
Libri su InternetBookshop
Biblioteca Teatrale Dramma.it:
Ostinati Officina di beni immateriali:
Mirkal delle arti e delle lettere:
Gli Artefatti tornano a Martin Crimp
Attempts on her life- Attentati alla vita di lei – 17 soggetti per il teatro
di Elena Lamberti
Dopo il successo di Tre pezzi facili, l’Accademia degli Artefatti prosegue la sua indagine sulla drammaturgia europea contemporanea con la seconda tappa del progetto su Martin Crimp Attentati alla vita di lei.

L’opera di Martin Crimp, uno dei più interessanti drammaturghi inglesi contemporanei, è caratterizzata dalla visione critica della società attuale come un luogo di decadimento morale, un mondo fatto di paure nascoste, di violenze tanto atroci quanto improvvise, di moti maligni dell’anima. Un quadro di sconfortante desolazione spirituale nascosto sotto l’apparente quotidianità dell’uomo comune, svelato impietosamente dalla grande maestria drammaturgica di Crimp che ricorre ad una scrittura ardita, evasiva ed evocativa, e ad una lucida, tagliente ironia per denunciare la vacuità morale della società contemporanea. Una scrittura caratterizzata da un assoluto rigore geometrico, da dialoghi intessuti di silenzi, di non detti, di negazioni, ripetizioni, specificazioni e che, non di rado, lascia spazio al fiorire di descrizioni particolareggiate, quasi barocche, uno stile che riesce a rendere ancora più inquietante la rivelazione finale di ciò di cui si sta veramente discutendo.
Attentati alla vita di lei, presentato al Royal Court Theatre Upstairs nel marzo 1997, e messo in scena adesso dall’Accademia degli Artefatti, è certamente il testo di Crimp più sperimentale e maturo, un testo difficilissimo, che non presenta alcun tipo di indicazione per la messa in scena, per i ruoli, i personaggi, e in cui l’inizio di ogni battuta è contraddistinta da un trattino. Non esistono, quindi, indicazioni per una realtà individuabile o riconoscibile, né una trama, ma “diciassette soggetti per il teatro”, altrettante micro-storie che ruotano attorno a un personaggio assente, Anne, (ma potrebbe anche chiamarsi Annie, Anya, Anouska), di cui si cerca, invano, di rintracciare l’identità attraverso una pluralità di indizi, indagini, rimandi. Ogni soggetto, diciassette brevi pezzi sull’identità, la guerra, il terrorismo, la televisione, può essere considerato uno spettacolo a sé stante, con un suo titolo e un numero, oppure un tassello di informazione per tentare di costruire il quadro completo dell’identità di Anne, quadro che sarà inevitabilmente smontato all'indizio successivo.

Un mescolarsi di voci e situazioni, racconti e ipotesi per indagare e raccontare diciassette identità possibili oppure diciassette sfaccettature dell’identità di una persona che non compare mai. Chi è Anne, dunque? Crimp non lo dice e il regista dell’Accademia degli Artefatti, Fabrizio Arcuri, si guarda bene dal darci soluzioni, anzi ci lascia un finale aperto, spiazzante, l’unica soluzione per un testo straordinario che riesce a offrirci una decostruzione del modello contemporaneo di dramma, un lavoro senza trama, personaggi o dialoghi convenzionali, che esprime allo stesso tempo un forte impegno morale, un grido di dolore e di indignazione raggelato in un humour glaciale.
Con assoluta coerenza progettuale, Arcuri ripete per Attentati alla vita di lei lo stile scenografico di Tre pezzi facili: un allestimento essenziale, uno spazio vuoto composto da quattro praticabili bianchi collegati fra loro da rampe di scale e illuminati a giorno, una scena - installazione che rispetta il rigore linguistico di Crimp ma che, come nello stile dell’autore, lascia spazio al fiorire di immagini evocative di rara potenza e suggestione. Uno spazio vuoto che si trasforma, quindi, nel palco di un concerto rock per la megastar Anne, nella pedana per lezioni di ginnastica in costume da bagno, mentre su una televisione scorrono scritte pubblicitarie per la nuova automobile Anny, nell’interno per un dramma borghese o per una soap opera sulla famiglia di Annie, in uno spazio museale/set fotografico, adatto per la grande artista d’avanguardia Ann. Spazio espositivo, scena - istallazione non a caso, per un’altra possibile chiave lettura dello spettacolo: non diciassette soggetti per il teatro ma diciassette oggetti museali con il loro numero di esposizione, che possono essere ammirati dal pubblico, libero di osservarli tutti o di sceglierne solo alcuni, da individuare sul programma di sala/guida museale.
Arcuri ci presenta uno spettacolo dalle molteplici sfaccettature, un lavoro destrutturato ma retto da una grande sapienza registica, in cui tutti i frammenti rimangono aperti e costituiscono altrettanti spettacoli godibilissimi, assolutamente diversi uno dall’altro, affrontati da undici attori perfettamente all’altezza di un compito difficile, come può essere solo quello di dover interpretare dei non – ruoli e che ha nel loro grande affiatamento uno dei suo maggiori punti di forza. Come in Tre pezzi facili Arcuri ha deciso, infatti, di rispettare fedelmente sia la “non necessaria identificazione di ruoli e personaggi”, come richiesto dal drammaturgo stesso, sia la versione integrale del testo. Un testo improntato ad un humour nero, che inevitabilmente suscita le risate del pubblico, riuscendo a provocare nello stesso tempo un profondissimo senso di disagio: si ride, ma si ride di cose atroci, e la soave leggerezza con la quale gli attori conversano amabilmente, descrivendo scene di violenza feroce aumenta, nostro malgrado, il divertimento, e l’angoscia che ne consegue.
Uno spettacolo spiazzante, intelligente, graffiante, da non perdere assolutamente nella prossima stagione invernale.
Attempts on her life- Attentati alla vita di lei – 17 soggetti per il teatro
di Martin Crimp
trad. Margherita D’Amico
cons.drammaturgica Luca Scarlini
regia:Fabrizio Arcuri
Con: Miriam Abutori, Matteo Angius, Gabriele Benedetti, Paola Cannizzaro, Fabrizio Croci, Daria Deflorian, Pieraldo Girotto, Sandro Mabellini, Simona Senzacqua, Antonio Tagliarini, Annapaola Vellaccio
Scene e costumi: Rita Bucchi
Disegno luci: Diego Labonia
Sonoro: d.j.ras noiz
Contributi video: Pietro Alessandro
Le recensioni di ateatro: La Romanina di e con Anna Meacci
Drammaturgia di Luca Scarlini, regia di Giovanni Guerrieri
di Andrea Lanini
Romano Cecconi nacque nel 1941 in un piccolo paese della Garfagnana: vi rimase poco, dopo qualche anno era già a Firenze. La sua storia anagrafica si interruppe nel luglio del 1972 per fare spazio a una “rinascita”: quella di Romina Cecconi, la Romanina.
Quell’anno il tribunale di Lucca dette validità legale a un desiderio che per decenni aveva dovuto lottare contro un’Italia bigotta e impreparata, contro un corpo che non corrispondeva a come la mente avrebbe voluto vederlo, contro l’incomprensione e l’indifferenza di chi rideva e sbeffeggiava senza voler leggere la sofferenza che si nascondeva sotto a parrucche e vestiti attillati: travestimenti che Romina indossava, passeggiando lungo via Tornabuoni, per rendere plateale (e di conseguenza, attraverso la trasformazione del timore in vitalità, più sopportabile) l’urgenza di gridare il proprio disagio, per esorcizzare i fantasmi di una contesa privata che durava praticamente da sempre; da quando le persone del suo paese le dicevano “altro che Romano, te sei una Romanina”, da quando a scuola i compagni la chiamavano “la donnicciola”.
Romina ha detto che un tempo chi nasceva con il corpo sbagliato aveva solo due scelte: il palcoscenico o il marciapiede. Se oggi non è più così, gran parte del merito spetta proprio a lei: alle sue battaglie, al coraggio e alla speranza che il suo attivismo e il suo esempio hanno dato a tante persone alle prese con gli stessi problemi, al suo non nascondersi. Ma a quel tempo l’Italia era un’altra Italia: Romina provò a calcare il palcoscenico, ma la cosa non poteva funzionare. Le sue imitazioni di Milva e i suoi spogliarelli mandavano in delirio le folle, ma la buoncostume non era disposta a tollerare le prestazioni della “donna-uomo” (così era presentata la sua performance nel cartellone della compagnia di girovaghi per cui lavorava), dell’emulo di Coccinelle. Arrivavano di continuo i carabinieri e i preti, allarmati da tanto nuova e tanto peccaminosa attrazione, gridavano allo scandalo.
Cominciò un calvario fatto di notti in prigione e processi, di soprusi e multe salate elargite in nome del pubblico pudore. Fu così che non potendo affidarsi alla prima scelta, il palcoscenico, per pagare la pila di contravvenzioni che pendevano sul suo conto dovette adattarsi alla seconda, il marciapiede. Ma anche quello, con lei, divenne a suo modo un palcoscenico.
Romina ha continuato per anni a elaborare il proprio lutto immaginando una dimensione parallela fatta di femminile splendore e dimostrazioni di stile, creando nella propria mente un’esistenza virtuale senza attriti né errori: la trasgressiva esteriorità della lucciola che passeggiava provocante per le strade di una Firenze scandalizzata – ma al contempo attratta e ipnotizzata dal fascino misterioso di tale scandalo - era il segnale più visibile e immediato di una transustanziazione sessuale realizzata per il momento solo in parte, di una metamorfosi che ricercava nello stupore e nella disapprovazione degli altri l’energia e lo stimolo necessari a far proseguire i suoi stessi nascosti meccanismi. La Romanina ha trovato nella teatralizzazione della propria vicenda e nella messa in scena della propria intima scissione il coraggio e la forza necessari a non soccombere: l’eccesso e l’esibizione chiassosa sono diventati nella sua sfida un modo per cercare il confronto alla pari con quella vita che con lei, da sempre, aveva giocato sporco; una testimonianza che, fondandosi sul coraggio e su un carattere abituato ad ingannare la realtà con i riflessi di un’ironia spesso amara ma sempre salvifica, ha insegnato al nostro Paese a guardare con occhi un po’ più aperti la diversità, a fare i conti con la vacuità di certi tabù, a fare qualcosa per evitare che chi non si riconosce nel proprio corpo possa non vergognarsi dei propri sogni.

Romanina: la nascita di un cigno, lo spettacolo di e con Anna Meacci (drammaturgia di Luca Scarlini, regia di Giovanni Guerrieri), prodotto dal Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino, ricostruisce con poetica leggerezza le trame della reiterazione di quell’esorcismo della sopravvivenza che ha portato Romina a diventare, da scandaloso “en travesti”, un vessillo dei diritti civili: un cammino lungo, doloroso sia dal punto di vista morale che fisico; una salita incominciata in un paesino di provincia e percorsa attraversando amori mercenari, il carcere, l’ospedale (Romina è stata una delle prime persone in Italia a sottoporsi a operazione per cambiare sesso), l’umiliazione del confino – ritenuta socialmente pericolosa, Romina fu costretta a lasciare Firenze per “recludersi” in un paese del foggiano; e alla fine conclusa con le lacrime di gioia versate al momento di ritirare un nuovo documento (importantissimo, per le implicazioni sociali che ha avuto): una carta di identità con una “f” scritta accanto alla voce “sesso”.
La drammaturgia di Luca Scarlini (basata sul libro Io, la Romanina: perché sono diventata donna, l’autobiografia che Romina pubblicò negli anni ‘70) e l’interpretazione di Anna Meacci si snodano lungo i contorni di quella bipolarità esistenziale e di quel grande chiaroscuro che costituiscono il ritratto della Romanina. Le tappe fondamentali di quel percorso unico ci sono tutte, e il pubblico le percorre guidato dalla voce e dai gesti di un’interprete che, per calarsi nelle vesti scintillanti e nel complesso universo di Romina, ha recuperato dal suo bagaglio d’attrice tonalità e caratteristiche espressive che da tempo non venivano usate, e che erano momentaneamente da parte in attesa della giusta occasione: per lei questa avventura è un viaggio interiore che ha il sapore della riscoperta e che rappresenta una tappa importante nel suo percorso artistico. Anna-Romanina ricompone il puzzle di un’esperienza frammentata e sospesa, continuamente oscillante tra dolore e sospensione del dolore, tra sconforto ed entusiasmo, tra sconfitte e rivincite. La verve comica che siamo abituati a trovare nei suoi personaggi televisivi, la sua capacità di ridere con lo sguardo e di creare contrappunti di ironia attraverso le evoluzioni timbriche della voce sono presenti e si fanno sentire: sono elementi che affiorano tra le parole, confusi e sparpagliati come i resti di un naufragio, regalando il loro accento frizzante e spontaneo ai molti aneddoti che compongono la “leggenda” Romanina: i tanti piccoli momenti in cui la sua abilità di equilibrista del carattere ha saputo cristallizzare l’amarezza in momenti di comicità.
Attraverso gli strumenti offerti da una regia attentissima a calibrare ogni più piccolo gioco di equilibri, preziose parentesi di distensione si affiancano allo spessore tragico della biografia di Romina creando un’osmosi cangiante, una trina attraverso cui lo spettatore è invitato a osservare il primo piano di un dolore scorgendo sul fondo la possibilità di un sorriso, e a sorridere prendendo prima consapevolezza dei contorni veri di un’esperienza di dolore. Anna Meacci ricostruisce con grazia leggera quel galleggiare da illusionista sui propri eccessi a cui la vera Romanina ha affidato se stessa, e accosta abilmente le ombre dell’umiliazione alla luminosa ebbrezza di una vita immaginata con tanta forza da divenire quasi reale: e le luci e le ombre che sul palco scandiscono il racconto, orchestrando la dimensione della finzione e quella della realtà, assecondano il fluire della narrazione ricreando il sapore di un’esistenza che non ha mai abdicato di fronte al diritto di credere alle proprie bugie. I luoghi dell’infanzia e dell’adolescenza, i tentativi frustrati di entrare in contatto con l’universo dell’amore, i ricordi legati agli uomini più importanti si alternano al vagheggiamento di un’esistenza da diva e di uno charme degno di Eleonora Rossi Drago, al desiderio della luce dei riflettori e al lussuoso sfolgorio di una pelliccia che appare in scena per sottolineare le tentazioni conturbanti di una benefica e ingenua rêverie. Anche il pubblico viene catturato dalla dualità su cui vive la recitazione di Anna: lo spettatore partecipa ad entrambi i versanti della natura ossimorica del pathos che scorre tra le sue battute, costretto a specchiarsi in entrambe le facce di una medaglia che alla fine può brillare di una propria, ritrovata armonia. Ci si commuove, ma con un sorriso che rende giustizia a quella parte divertente, leggera e necessaria da cui la storia della Romanina pretende di essere osservata.

Andrea Lanini Parliamo del tuo incontro con la storia di Romina Cecconi: tutto nasce da un libro…
Anna Meacci Sì, l’incontro decisivo è avvenuto attraverso il suo libro, lo lessi 8 anni fa. Prima conoscevo alcuni aneddoti della sua vita, storie inevitabilmente avvolte nel folklore che da sempre circonda la leggenda della Romanina. Poi 8 anni fa andai a Roma per lavorare a Le notti della Mucca Assassina con Vladimir Luxuria, e per 9 giorni divisi il mio camerino con un gruppo di “en travesti”. Giocando con loro, con il loro modo di fare e con le loro voci, mi venne l’idea di scrivere uno spettacolo su un personaggio che potesse racchiudere le loro caratteristiche. Il fatto poi di aver avuto l’occasione di conoscere due transessuali e il loro universo non fece che far aumentare il mio interesse nei confronti di quel progetto. Ne parlai con Luca Scarlini, e lui mi disse: “Guarda Anna che la storia già esiste, è quella di Romina Cecconi. Leggi il suo libro”. Era vero, tra quelle pagine il dramma teatrale c’è tutto, la storia scenica è tra le righe della biografia.
Hai capito subito che era quella la strada giusta, lo spettacolo giusto?
All’inizio non riesco mai a capire se il percorso che mi sembra di vedere è quello giusto o no, o perché all’improvviso sento una molla che scatta dentro e che mi spinge a cominciare. Riesco a capirlo davvero solo attraverso il confronto con il pubblico, cercando di cogliere le sue reazioni. Solo dalla lettura delle emozioni di chi mi guarda posso davvero rendermi conto dello spettacolo che ho fatto. La storia di Romina mi ha conquistata da subito: è la battaglia di un individuo per i propri diritti. Questa battaglia è il nucleo vero dello spettacolo. In un primo tempo ho continuato a portare avanti l’idea che avevo avuto a Roma pensando contemporaneamente a come mettere in scena la vicenda di Romina: le due cose procedevano insieme senza sovrapporsi. Solo dopo un po’ ho capito che in realtà le due strade non solo potevano coesistere, ma che era necessario che si incontrassero: i due personaggi dovevano unirsi per dare vita alla Romanina.
La vicenda di Romina ha molti lati dolorosi e sicuramente difficili da raccontare: dallo spettacolo emerge una grande attenzione nei confronti di questo aspetto, una delicatezza che non poteva non esserci…
Si potevano scegliere diverse strade per parlare della Romanina, ma alcune di queste non potevano spettare a me. A Luca Scarlini, a Giovanni Guerrieri e a me sembrava che alcuni momenti – per esempio quello dell’ospedale e dell’operazione – fossero quanto di più lontano potesse esserci dalle nostre possibilità. Parlarne non sarebbe stato giusto, e proprio per questo lo abbiamo solo accennato, e con la maggior leggerezza e attenzione possibili. E’lo spettatore che, volendo, può arrivare a immaginare il dolore che sta dietro a quei cenni. Ma nello spettacolo anche la risata e i momenti leggeri trovano spazio, e questa necessità risponde a una cosa che Romina dice ancora oggi: “Se non avessi avuto il carattere che ho, l’ironia che ho, probabilmente sarei finita davvero male”. Raccontarla solo dal punto di vista del dolore avrebbe dato vita a un ritratto falso, perché lei non è così.
Quali sono le reazioni del pubblico che ti hanno colpito di più?
Spesso, parlando con gli spettatori dopo ogni replica, ho sentito dire: “A volte si giudica con troppa leggerezza”. La cifra più vera che sintetizza le reazioni delle persone che hanno visto lo spettacolo è questa: il rischio di cedere alla tentazione di giudicare con troppa facilità. Il pubblico femminile è sicuramente quello che riesce a d immedesimarsi di più: le donne sentono sulla loro pelle i segni di una battaglia che una persona come Romina ha dovuto combattere per potersi finalmente considerare una di loro. E le donne di battaglie ne hanno dovute fare tante: anche per questo secondo me c’è un’intesa speciale tra loro e questa storia. E anche per questo la vicenda della Romanina mi commuove ogni volta così tanto. Arrivare a definire i contorni entro cui inscrivere il ritratto della Romanina non è stato semplice: questo spettacolo ha richiesto 7 anni di lavoro. Una maturazione assolutamente necessaria, anche per il mio modo di vivere questo mestiere.
E l’incontro con la vera Romanina?
Ti confesso che fino all’ultimo – e cioè fino al debutto dello spettacolo – ho preferito non incontrarla: tutti mi chiedevano se l’avevo già conosciuta e quando dicevo di no mi spingevano a farlo, ma io mi inventavo ogni scusa possibile per evitare. Volevo vedere ciò che riuscivo a tirare fuori da questo personaggio, come potevo rappresentarlo: l’essenza di Romina dovevo cercarla dentro di me, e avevo paura che l’avvicinare la vera Romina potesse in qualche modo rendere più incerta la mia direzione. Prima della conferenza stampa per la presentazione dello spettacolo ci siamo sentite solo per telefono. Solo dopo è stato stupendo conoscerla, parlarle, farsi raccontare aneddoti e curiosità che lei può sfoderare per ore, a non finire. Ti assicuro che passare una serata in compagnia di Romina è un’esperienza mistica!
Anche perché le memorie di Romina sono un archivio storico su cui si potrebbe scrivere un saggio di Costume e Società…
Ma certo. Lei ha segnato davvero un’epoca, ha contribuito a cambiare il costume del nostro Paese, dando tanto coraggio a quelle persone che nella sua rinascita hanno visto una speranza. La cosa che più adoro di questa persona è proprio il fatto che non si sia mai nascosta. Romina ha sempre avuto il coraggio di dire “Io sono così, e su questo non ho dubbi: se la cosa vi crea problemi, il problema siete voi”.
Lo spettacolo Romanina: la nascita di un cigno sarà il 27 gennaio al Teatro Rossini di Pontasserchio (Pisa).

Mataro da Vergato, La Romanina (digital portrait).
La voce dell’attore
Una riflessione
di Nevio Gàmbula
“Il cammino a ritroso della vita nel capitalismo, o nel coesistervi su un pianeta con fossa comune (perdita in su-perficie, crescita della morte nelle fosse), strappa il legame dell’attore con la (sua) proprietà privata: non recita più alcun ruolo. L’espropriazione=liberazione dell’attore come condizione della sopravvivenza del teatro”.
H. Müller
Ma che accade all’attore, alla voce dell’attore quando recita un testo? Secondo il senso comune, all’attore spetta il compito di svolgere il suo “ruolo” e seguire le indicazioni del regista. Il ruolo è fissato, in termini di indicazioni (didascalie più o meno generiche, a seconda dei casi), nel testo drammaturgico. Il regista ne propone una “lettura” e all’attore spetta realizzarla sul palcoscenico attraverso l’uso della voce, del gesto, dei movimenti nello spazio. È il rito dell’interpretazione. Ciò che ha pregnanza è la coerenza di ogni elemento con il testo. L’attore è – di fatto – un essere “pensato” dal testo; la sua costruzione della “parte” soggiace ad un particolare rapporto di dipendenza con esso. E pertanto la sua voce deve equilibrare il movimento dei suoni a quello del significato. Qual che accade alla voce, alla voce dell’attore nello spettacolo della parola, è ciò che potremmo chiamare l’esperienza del medium: essa è il mediatore tra l’autore e lo spettatore. Ma la mediazione presuppone l’esistenza di uno spazio condiviso, di una esperienza comune ad attore e spettatore: ed ecco che la voce dell’attore si concede alla luce dell’esperienza verbale quotidiana, così che risulti agevole individuare i significati della lingua. Nell’ambito del teatro con-temporaneo, dunque, il problema della esecuzione fonetica della parola è risol-to così: privilegiando la prosodia, in particolare le caratteristiche ritmiche ed intonative connesse ad informazioni di carattere “paralinguistico” tipiche della lingua comune. È il rito della voce come rappresentazione del testo.
Nell’ambito di questa concezione, la voce non viene vista come segno dotato di un proprio «potere di senso», ma come semplice veicolo di significati che hanno sede fuori dalla voce stessa, dentro il linguaggio: la voce è intesa come «gesto articolatorio» conforme al sentire del personaggio, ad essa spetta nient’altro che “tradurre” le situazioni previste dal testo facendo coincidere, nella dizione, ogni articolazione sonora con una «intenzione di senso». Questa tendenza si afferma a partire dagli insegnamenti di Stanislavskij e dal suo concetto di riviviscenza. La recitazione è intesa come «creazione organica di un essere umano vivente», mentre la qualità dell’attore si misura sulla sua capacità di identificarsi con il personaggio: è direttamente propor-zionale alla capacità di rendere la recitazione congrua ai parametri psicologici, esistenziali e intellettuali del personaggio, sviluppando il dire in perfetta aderenza al detto. Essere attore significa essere un altro. A onor del vero, la strada indicata da Stanislavskij era ben più complessa di quanto si sarebbe poi affermato nel teatro del Novecento, e la sua linea di ricerca è stata sicuramente tra le più importanti di tutta la storia del teatro. Resta però evidente che il suo sacralizzare il testo drammaturgico, cui l’attore deve sottomettersi, abbia di fatto contribuito ad affermare l’idea della “messa in scena” come fondamento del teatro, che in realtà è qualcosa di diverso: non solo trasposizione di un testo pre-esistente sulle assi di un palcoscenico, ma “linguaggio” vero e proprio, con una propria sintassi e una propria capacità ar-ticolatoria che esula il testo scritto. Se invece il testo è l’elemento prioritario, all’attore spetta il compito di farlo «rivivere»; per conseguire lo scopo deve fare della recitazione una semplice «azione verbalizzata» del testo stesso, rendendo la voce alienata in altro da sé. Con ciò – dice giustamente Maurizio Grande – l’attore «è schiacciato contro la fisionomia (verbale e mimica) della dramatis personae» e la sua voce si fa «megafono di una identità imposta dall’esterno», altra da quella dell’attore stesso. Esercitarsi ad essere un altro – parlare con la voce di un altro – di-pendere da questo altro – riprenderne il linguaggio, simularlo: essere attore significa la-sciarsi fare da un altro – da un altro che è così palesemente inumano, così assolutamente freddo, di “carta”. Essere attore è amare al posto di un altro – fingersi d’accordo con un altro dimenticando se stessi. È l’opera che immagina l’attore.
Eppure, eppure non è sempre stato così. La storia del teatro non è avara di spunti di con-trotendenza. Ci sono esperienze, importanti pur se minoritarie, che hanno dato dignità inventiva all’attore come essere dotato di vita propria: un attore che produce il suo spa-zio, lo istituisce, lo ricerca e lo rende visibile. La recitazione non è più una cerimonia di ripetizione di un carattere altrui, ma un «evento essenziale», che scatena l’attore in quanto creatore di forme. Ed è qui che la voce acquista una valenza decisiva: acquista una sua capacità di produrre senso, anche presa separatamente dal codice linguistico cui fa riferimento; è pronta ad esaltare, pur nella relazione coi significati (ma non più sotto-messa ad essi), il corpo fonico della parola. L’attore naufrago, in balia del testo, comincia a costruirsi una zattera tutta sua; diventa il maestro di cerimonia, e il teatro torna ad essere il regno dell’attore. Lo stesso teatro greco delle origini, per non dire poi della poesia epica, agiva la parola facendo vacillare il limite tra parlata e canto, riconoscendo alla voce un valore autonomo, indipendentemente dalle norme del discorso. Anche la Commedia dell’Arte, in evidente rottura con i postulati del tempo, frantuma la catena del linguaggio naturale, in particolare con l’introduzione di interruzioni del discorso lineare (i cosiddetti lazzi), allontanando la voce da quel «portare all’orecchio del popolo il concetto che la parola esprime» (Tasso), per fare invece risaltare la ricchezza delle sue tonalità in senso completamente gratuito. La stessa cosa potrebbe essere fatta rilevare con il sorgere del recitar cantando, in cui la struttura del parlato assume connotazioni fortemente musicali, facendo esplodere la parola non già in imitazione del livello semantico, quanto piuttosto articolando il significante come «una sorta di accompagnamento al significato» (Pagnini). Fino ad arrivare ad un contemporaneo di Stanislavskij, ossia a quel Mejerchol’d che per primo ha, per lo meno nel Novecento, contestato il fatto che l’attore dovesse immedesimarsi nel personaggio: incamminarsi tra le pieghe del personaggio facendo apparire la propria distanza da esso, e fare ciò mediante il ricorso ad una struttura gestuale e vocale modulata al di là delle convenzioni linguistiche. Secondo il grande regista sovietico, l’attore deve abbandonare tutto ciò che odora di psicologia per rivolgersi invece alla musica; soltanto con questo atteggiamento potrà far risaltare i personaggi non come «tipi unici», ma come maschere sociali. Importante, in questo senso, la sua indicazione di trasformare la dizione dell’attore in «melodia che provoca negli spettatori delle associazioni» con il ricorso a “staccati” non naturali, a interruzioni del ritmo declamatorio, a variazioni tonali giustificate non “psicologicamente”. Comincia da qui una proficua sperimentazione sulla musicalità del linguaggio; comincia da qui: slegando la declamazione dal discorso quotidiano, in favore della «creazione di una trama verbale organizzata musicalmente». Non più, dunque, l’atto di porgere la voce privilegiando i «referenti concettuali» della lingua, ma la parola intesa come corpo sonoro; è lo stesso Mejerchol’d a dirlo: «il mio sogno è uno spettacolo provato con un sottofondo musicale, ma poi recitato senza musica. Senza musica, ma con la musica, giacché i ritmi dello spettacolo saranno organizzati secondo le leggi musicali e ogni interprete porterà la musica dentro di sé». Da questo punto in avanti si srotola un’altra storia.
Diciamo che nel corso dell’ultimo secolo sono stati sostanzialmente due gli atteggiamenti che l’attore ha assunto di fronte al testo: 1) fondare un’altra idea di recitazione, tale almeno da permettergli di affermare se stesso e la propria vocalità, usando il testo come un tramite per allargare i propri confini; 2) assumere la recitazione dell’epoca e quindi penetrare il testo, legarsi “amorevolmente” alla parola data e tradurla vocalmente. Nel primo caso, ad avere rilevanza è l’autorialità; l’attore è elevato al rango di compositore della partitura vocale, ne è il diretto responsabile, e ciò al di là (e spesso contro) il testo; nel secondo, prevale l’approccio “ermeneutico”, per cui all’attore spetta chiarire il testo, trovare una sintesi interpretativa e svolgerlo in voce cercando il più possibile l’aderenza tra la propria recitazione e il dettato dell’autore. Il primo è l’attore poeta; non sparisce tra le righe del testo: è il testo, ovvero, come dice Carmelo Bene, nella scrittura vocale poesia è la voce (e il testo è la sua eco, dice). Il secondo è l’attore interprete; riferisce altro: «la voce assume il ritmo della scrittura e lo traduce nell’universo corporeo e tattile della sonorità, presta cioè ad esso la propria individualità» (F. Frasnedi).
Con l’avvento dell’attore-poeta comincia ad affermarsi un attore non più costretto a su-bire il personaggio, ma capace di farlo diventare strumento del proprio sguardo sul mondo; un attore che, slegandosi definitivamente dal linguaggio parlato tutti i giorni e dal testo scritto, tende al canto: «nello spettacolo – scrive magistralmente Antonio Attisani – l’attore non dice, ma significa e canta». In questa prospettiva, le dinamiche della voce vengono organizzate metricamente, secondo un «procedimento di frammentazione e ricomposizione ritmica». Scansione del respiro, cesure, accenti, dissociazione di ritmo e sintassi, ripetersi di blocchi sonori (rime?), accordi ripetuti, contrasti, sillabe spezzate, parole tronche: la recitazione assomiglia sempre di più ad una composizione poetica. L’attore diviene «un essere integrale di poesia»: gioca con la voce nel momento in cui la libera dalla dipendenza dal significato. Non placa il grido nascosto che alberga nella voce; lo esalta, a briglie sciolte. Senza uccidere il significato; tutt’altro. Lo rende fluido, lo rende aperto, ne amplifica l’efficacia. La voce libera il significato da se stesso, per lo meno quando riesce a trasformarsi in «appello al godimento e all’inquietudine». Non gioco gratuito, quindi. Nell’inquietudine è annunciata la critica, si esprime una lacerazione. E allora, quel «piacere agoni-stico della voce» che mira a piegare il linguaggio alle esigenze dell’attore ha un unico scopo, uno scopo che è eminemente politico: «realizzare il desiderio represso di fare del corpo un oggetto di gioco», e non oggetto di una routine che lo vede sistematicamente messo al lavoro sino all’usura. Questo è un punto centrale. Senza uccidere il significato, appunto: perché riscattare la voce sottraendola alla dipendenza dal semantico non significa eludere quel «andare verso qualcuno» che Wittgenstein indicava come dimensione specifica del significato. Nella voce, il significato «non va in vacanza»: esplode, per rinascere nello stupore dell’ascolto (pur degenerando, traccia il suo “messaggio” – perché la voce pura non esiste).
Ora, qui è fondamentale liberarsi di un malinteso. L’avanguardia teatrale italiana ha puntato a tenere «distinti e distinguibili» significato e significante e non, come erroneamente è stato detto in piena bagarre decostruzionista, attivare un dire che sia assenza di senso. Quest’ultimo è stato l’approccio di quanti, contrapponendosi «al sistema logocentrico della parola», sono giunti a soffermarsi sulla voce in quanto «assenza di significato». Tale atteggiamento, per così dire, comincia «proprio là dove il pensiero finisce», e rinvia a quella diffidenza rispetto al logos (alla razionalità che si esplica in linguaggio) che porta ad esaltare la valenza del dire (l’unicità del parlante) rispetto al detto (i concetti e tutto l’ambito del semantico); in sintesi, abolendo ogni legame della voce con la verità (il senso è la verità, scrisse Henri Lefebvre). Sospendendo, il parlante, ogni «rapporto con il fuori», la voce è emancipata «dall’urgenza di significare», liberandola da ogni complicità col mondo. Si resta fermi ad uno stadio pre-comunicativo; alla preistoria dell’espressione. Pratica insidiosa: è in agguato la torre d’avorio; il rifiuto della significazione è sempre in bilico di trasformarsi in rapporto di non curanza – e quindi di accettazione – dello stato delle cose. Il caso di John Cage è esplicativo. Indubbiamente, il suo esaltare una vocalità scaricata di ogni legame con la parola-pensiero, ha portato a risultati artisticamente rilevanti (esemplari le esecuzioni di Joan La Barbara in Singing Through del 1990); è però anche vero che le sue composizioni sfociano in una aleatorietà che è «rinuncia a intervenire sulle cose, sulla e nella storia»; una «esaltazione del si-gnificante» che per di più non è «intimidatoria nei confronti del fruitore comune» (A. Gentilucci). La valorizzazione della «funzione destabilizzatrice del godimento vocalico nei confronti dell’effetto disciplinante del linguaggio» (Cavarero), in questo caso, sfocia in un «esotismo gratuito» che non riesce affatto ad incrinare, come vorrebbe ad esempio la Kristeva, «la Legge e il Discorso del Potere».
L’analisi dei fenomeni spettacolari dimostra invece come, anche nei casi più radicali, esiste una speciale significazione nella voce, una sua capacità particolare di farsi «fenomeno di senso»; ma soprattutto dimostra che, alla prova pratica dell’ascolto, il significato non scompare affatto, anzi, viene esaltato, come raddoppiato dalla phoné dell’attore. Il modo di impostare la dizione nel suo Per farla finita con il giudizio di Dio, non porta assolutamente Artaud a liberarsi del significato o, come dice ancora la Kristeva, «ad attaccare il senso», tutt’altro; l’instabilità ritmica, le tonalità alte, la fonazione strozzata, se è vero che portano a puntare l’attenzione su quel suo dire esagerato e disorganico, è altrettanto vero che non nascondono il senso di ciò che voleva comunicare; altrimenti non si capisce perché Artaud abbia scritto proprio quelle cose, in particolare nel momento iniziale («J’ai appris hier …»), nel brano La question se pose de… (recitato da Paule Thevenin) e nella conclusione, dove traspare un forte significato polemico nei confronti della cultura occidentale, e non un semplice accavallarsi di frasi o sillabe non significanti. Ha ragione piuttosto Carlo Pasi, in particolare quando fa notare come la rottura degli schemi e la sperimentazione dell’eccesso propri della dizione di Artaud fossero condotti con l’intenzione non di annullare la comunicazione tout court, ma di aprire un nuovo spazio comunicativo, dove l’incontro con l’Altro, nel totale allentamento delle inibizioni, si potesse trasformare «in una comunicazione attiva, intensa». La dizione imperfetta di Artaud apre nuove possibilità di senso, e dunque di libertà («di amore e di rivolta», dice lo stesso Artaud). Anche l’ascolto delle opere di Carmelo Bene potrebbe fugare dubbi in proposito. Si prenda ad esempio il poemetto Lamento per la morte di Ignazio Sanches, scritto da Garcia Lorca. Certamente Bene, come in ogni altra sua opera, soppianta una volta per tutte la «voce impostata» dell’attore teatrale e, per così dire, elude «il messaggio esplicito»; però è innegabile che la sua musicalità del dire produce senso. Nel caso citato, il senso di morte e di memoria trafitta dalla mancanza presente nel testo di Lorca è fatto vibrare, oltre che dal ricorso ad un timbro particolarmente scuro, da una scansione regolare delle strofe, quasi a “rappresentare” un funerale, ma è fatto poi esplodere (di “dolore”) in micro variazioni tonali e timbriche all’interno dei singoli versi, e in particolare nello slittamento verso l’afasia in alcuni accenti e nel ripetere le sonorità delle sillabe finali, là dove Bene, per realizzare la sua idea di modo – grumi di frasi che si ripetono fonicamente simili nella struttura, somiglianti alle strofe musicali ma eludenti ogni melodia – ricorre al tipico ingoiare il fiato o all’improvviso salire d’ottava. Anche il ritmo fonatorio concitato usato da Bene per recitare i versi di Majakovkij (in Quattro diversi modi di morire in versi) permette all’ascoltatore di cogliere in tutta la sua portata la valenza eversiva del dettato poetico del poeta russo («io odio tutto questo / tutto ciò che ha inculcato in noi / l’antica schiavitù»); permette insomma non già di eludere il significato, piuttosto di realizzare quella messa in scena totale della parola che era la sua principale ricerca. La costruzione della partitura si compie, in Bene, nel predisporre ogni elemento in «apparente disordine» (o stonatura) rispetto ad un andamento “normale”. L’atto di spostare le toniche o di spezzare le parole, isolando nel silenzio alcune sillabe, è in fondo un rompere la prosodia quotidiana per andare in direzione di una «sonora costruzione dei periodi». La voce di Bene – dice giustamente Giacché – è della musica. Il processo della parola si esplicita in qualità sonore modulate non già “psicologicamente”, ma, appunto, secondo parametri assimilabili alla musica, senza però diventare canto vero e proprio. La voce è finta; la sua estensione trascende la voce parlata nel quotidiano, i passaggi di registro o i cambiamenti di timbro avvengono proiettando la voce in sintonia a un’idea estetica, anche privilegiando l’uso dei tipici “difetti”, dal gutturale alla voce ingolata, dal nasale al rauco, persino all’afonia vera e propria. In ciò è evidente un distacco, addirittura una critica esplicita alla tipica voce “impostata” dell’attore di prosa. Il respiro, in Bene, non segue più il “messaggio” del discorso, viene articolato secondo parametri essenzialmente ritmici, riuscendo «a penetrare nell’intimo del linguaggio», con evidenti parentele con lo Sprechgesang («un canto generato dalla parola») ripreso e praticato da Schönberg. In effetti, proprio il funzionamento dello Sprechgesang agevola la comprensione del modo di procedere di Carmelo Bene nei riguardi della relazione tra voce e parola. L’attore imposta i ritmi e gli altri valori fonici (altezze, timbri, etc.) nella piena consapevolezza della differenza tra parlata quotidiana e reci-tazione, e imposta l’emissione avvicinandosi e allontanandosi dalla prosodia, disattendendola con spostamenti di accento e modulando la voce in un modo che è, allo stesso tempo, «prossimo al canto e distante dalla dizione naturalistica» (Schönberg). Il senso delle parole è agito secondo parametri musicali. Ed ecco che è in questo modo che l’attore si fa poeta.
Nella poesia della voce ciò che ha pregnanza è il controllo del processo creativo, a partire prima di tutto dalla regolazione del fiato. Le tecniche vocali variano a seconda dello “stile” o del senso critico (l’emissione, scriveva Cathy Berberian, «è anche una scelta culturale»), per cui, ad esempio, l’uso dei risuonatori è radicalmente diverso tra un attore grotowskijano e un attore di tradizione. Insomma, è un insieme di criteri etici od estetici (o un incrocio tra questi) che domina il controllo del ciclo parola-ritmo-suono da parte dell’attore-poeta, testimoniando che il pro-blema della costruzione del significante è già il problema del senso. Questo è un punto centrale. In questa consapevolezza l’attore grida la sua emancipazione totale. Qui la voce lievita e, intravisto l’abisso, s’incammina come lanterna: una «illuminazione nel fango». Perché qui si gioca la tensione ad unificare compositore e interprete, in modo che l’attore, diventando padrone delle proprie intenzioni espressive, celebri la propria liberazione. Fusione, nella stessa persona, del compositore e dell’interprete: questa è stata la strada percorsa da molta vocalità non convenzionale, che è nata e si è sviluppata al di fuori delle accademie, dall’avanguardismo spinto dell’opera The big bubble dei Residents al minimalismo di Meredith Monk, dal radicalismo vocale di Diamanda Galàs al cabaret-rock di Dagmar Krause, dalle vocine distorte e irridenti di Frank Zappa al canto popolare di Giovanna Marini. Ed è stato il percorso intentato da certo teatro di ricerca, in particolare italiano, dove la conformità ai riti propri di una tradizione incapace di “emozionare” veniva fatta deragliare a favore del gratuito (e della critica), esaltando la qualità personale dell’attore: «la sua stessa voce, il dispiegamento delle sue tonalità, la ricchezza fonica». La scissione tra il ruolo dell’autore e quello dell’esecutore, allora, è superata dalla pratica senza scopo – e perciò scan-dalosa e rivoltante – dell’attore. In questa deriva, piuttosto che “bardo stipendiato” al servizio di un apparato istituzionale, l’attore agisce in totale indipendenza e diviene, appunto, poeta. E tutta la ricerca di Carmelo Bene è lì a dimostrarlo.
BIBLIOGRAFIA
Antonin Artaud, Per farla finita col giudizio di Dio, libro + CD, Stampa Alternativa, Roma 2000.
Antonio Attisani, L’invenzione del teatro. Fenomenologia e attori della ricerca, Bulzoni Editore, Roma 2003.
Carmelo Bene, La voce di Narciso, Il Saggiatore, Milano 1982.
Carmelo Bene, Majakovskij, Musiche di G.G. Leporini, Fonit Cetra, 1981.
Carmelo Bene, Lamento per la morte di Ignazio Sanches, scaricabile in mp3 dal sito http://www.vicoacitillo.it/sonora/indice.html
Ernst Bloch, Spirito dell’utopia, La nuova Italia, Scandicci 1992.
Adriana Caravero, A più voci. Filosofia dell’espressione vocale, Feltrinelli, Milano 2003.
Fabrizio Frasnedi, La voce e il senso, Il Verri, maggio-giugno 1993.
Armando Gentilucci, Oltre l’avanguardia. Un invito al molteplice, Unicopli, Milano 1991.
Piergiorgio Giacché, Carmelo Bene. Antropologia di una macchina attoriale, Bompiani, Milano 1997.
Maurizio Grande, La riscossa di Lucifero, Bulzoni editore, Roma 1985.
Jerzy Grotowski, Per un teatro povero, Bulzoni Editore, Roma 1968.
Julia Kristeva, L’abietto: voce e grido, in Foné. La voce e la traccia, La Casa Usher, Firenze 1985.
Marcello Pagnini, Lingua e musica, Il Mulino, Bologna 1974
Anna Panicali, La voce, il gesto, la maschera, in Foné. La voce e la traccia, La Casa Usher, Firenze 1985.
Carlo Pasi, Artaud attore, La Casa Usher, Firenze 1984.
Konstantin S. Stanislavskij, Il lavoro dell’attore, Universale Laterza, Roma-Bari 1975.
Paul Zumthor, La presenza della voce, Il Mulino, Bologna 1984.
Dedicato a Julian Beck
Due testi per Anna Maria Monteverdi
di Judith Malina e Hanon Reznikov
Quello che Julian Beck vide e fece con la sua arte e con la sua vita continua a mostrarci la strada. I suoi dipinti sono astratti perchè vide nello splendore delle forme e nei colori della vernice la liberazione dalla necessità di imitare e l'affermazione della loro propria realtà. La sua poesia canta il suo tormento e la sua estasi personale e ci esorta a osare sperimentare gli estremi della passione. Il suo teatro è politico perchè venne come Avilokitesvara alle Porte di Nirvana dove udì le grida della sofferenza umana e sentì il desiderio di rendere utile la sua arte per diminuire quella sofferenza. Ora non ha bisogno delle nostre lodi. Vuole che prendiamo il prossimo passo verso quel mondo più libero, meno penoso, più sexy, più tenero che lui ideò. Sì! Ma che conduca all'azione.
Judith Malina
Julian camminava per le strade gesticolando come se fosse in scena. Decise che l'arte doveva rompere con il passato e con i suoi quadri successe così. Con Judith progettava un teatro che presentasse la realtà in modo assoluto e con The Connection and The Brig, venne fatto. Immaginava un teatro che inventasse un nuovo linguaggio e con Mysteries and smaller pieces fu compiuto. Cercava di creare spettacoli che facessero un uso rivoluzionario dei testi classici e con Antigone vi arrivò. Voleva che il teatro diventasse un luogo dove tutto è possibile e con Paradise Now, ci riuscì. Secondo lui, il teatro doveva essere capace di portare notizie delle lotte operaie al grande pubblico nelle strade e con The Legacy of Cain, lo fece. Credeva che gli atteggiamenti politici delle persone rispecchiassero la loro vita sessuale e pensava che la libera espressione della diversità sessuale avrebbe aperto le porte del nuovo mondo. Era un uomo dolce e feroce, che sapeva ridere e urlare. They don't make them like that anymore.
Hanon Reznikov
October 2005
That Time di Samuel Beckett interpretato da Julian Beck
Con la regia di Gerald Thomas
di Anna Maria Monteverdi
Abbiamo solo pochi minuti per trovare la risposta. Sappiamo già che non c’è abbastanza tempo, non c’è abbastanza tempo per considerare attentamente tutti i fatti e verificare tutti i calcoli, per meditare e rimediare. C’è dunque solo la speranza che, puntando un riflettore sulla mente, vi getteremo luce.
Julian Beck

Julian Beck e Gerald Thomas
Julian Beck, fondatore con Judith Malina nel 1947 del più straordinario esempio di teatro di ricerca, il rivoluzionario e anarchico Living Theatre, viene colpito dal cancro nel 1983; nei due anni che precedettero la morte (14 settembre 1985) accettò alcuni ruoli secondari nel cinema (il gangster Sol in Cotton club di Coppola; il reverendo Kane in Poltergeist II di Gibson). In teatro recitò fuori dal Living Theatre una sola volta diretto da Gerald Thomas, giovane allievo di Ellen Stewart.. All’indomani dell’ultima regia di Julian Beck, L’archeologia del sonno (1984), Thomas lo diresse infatti il 6 aprile 1985 in That Time, monodramma inserito nello spettacolo Beckett che comprendeva anche altre due piéces di Beckett, Theatre 1, Theatre 2 (interpretate da George Bartenieff e Frederick Neumann) al La Mama Experimental Theatre Club. A Francoforte, Theater-am-Turm, fu un successo senza eguali e il pubblico si espresse con un’ovazione definita sconcertante dallo stesso Julian Beck. Che non fece in tempo a rappresentarlo nella prevista data alla Biennale di Venezia.
“Questo pezzo di Beckett è un esempio di minimalismo; dura circa mezz’ora e l’intero testo è registrato su nastro. Io resto tutto il tempo fermo, in piedi su una piattaforma rialzata, nel buio, solo il volto illuminato, un volto che fluttua nello spazio e riflette il testo”.
Julian Beck
Gerald Thomas, che ha diretto per il Workcenter di Grotowski a Pontedera The said eyes of Karlheinz Ohl nel 1991, fa di Beck, icona dell’Utopia rivoluzionaria, una stilizzazione marmorea, un’apparizione irreale; lui, così vicino al limite da non temere di rappresentare la morte o l’enigma dell’essere, il divino e l’umano allo stesso tempo.
“Il palcoscenico è la mente di ogni spettatore dove i nostri corpi trasmigranti assumono la forma di attorici per rappresentare per noi il significato nascosto della nostra esistenza e sopravvivenza”. Julian Beck
Nelle pagine de La vita del teatro e in Theandric, due dei libri scritti da Beck, sono citati molti amati autori, filosofi, poeti, pittori, letterati: Stein, Cocteau, Martin Buber, Artaud, Kandinskij.
Beckett viene ricordato e incidentalmente una sola volta, nella poesia Teatro-Forma (1982, in Theandric), come artista capofila del monodramma e della modificazione della forma esteriore del dramma teatrale.
Così Judith Malina misura la distanza del Living Theatre da Samuel Beckett:
“Il pubblico dei teatri adora Beckett, in quanto ama farsi raccontare che la vita è priva di senso e il futuro non riserva alcuna speranza. Il pubblico vuol vedere rappresentata la disperazione del vivere, proprio al contrario di quello che intende fare il Living Theatre. Noi ci presentiamo come gli alfieri dell’ottimismo, vogliamo trasmettere spirito positivo e fiducia nella possibilità del cambiamento. E questo è il motivo per cui siamo accusati di ingenuità e anacronismo. Julian rifletteva su questo, quando faceva That Time, sul fatto che l’ottimismo negli anni Sessanta era perduto e che era necessario che la cultura trovasse nuove prospettive e nuove forme di illuminazione. Questo era per lui il ruolo dell’artista e stava ancora ricercando in questa direzione”.
Un volto bianco esce dal buio pieno e denso della scena, le parole registrate su nastro attraversano e colpiscono il volto senza corpo, luminescente e provato dalla malattia terminale, di Julian Beck. Parole cadenzate, ripetute ad intervalli come una nenia che dicono di creature impigliate nei ricordi, nel tempo passato, nell’ossessione della solitudine, nella paura del vuoto, dell’ora, nell’incapacità del ricreare “quella volta” ancora. Nessun dialogo, nessuna storia. Un’attesa, un andare e venire della mente a quei luoghi da bambino, rincorrendoli a brandelli senza afferrarli. Un uomo dentro la caverna buia del teatro. A tratti le mani afferrano il volto in una disperazione afona. Torcendosi l’uomo si fa tagliare dalla lama di luce. La voce di Beck/Beckett tripartita, risuona da lontano.
A. Quella volta che tornasti quell’ultima volta a vedere se la rovina c’era ancora dove ti nascondevi da bambino quando fu quel giorno grigio che prendesti l’undici fino al capolinea e avanti di lì no nessun tram allora tutti andati spariti da un pezzo quella volta che tornasti a vedere se la rovina c’era ancora dove ti nascondevi da bambino quell’ultima volta nessun tram non uno rimasto soltanto i vecchi binari quando fu
Un monologo interiore, un labirinto della mente senza via di uscita. “Creature in un labirinto. Per quanto ancora possiamo continuare a vagare”.
Julian Beck
Parole che si negano. “Le parole muoiono, muoiono di abuso, abusate dal cattivo uso, dal troppo uso, avvizziscono e il loro significato si perde nella nostra lingua, esse tiranneggiano e ingannano e sono il più importante veicolo di menzogna, le parole distorte contro i loro stessi desideri.”
Julian Beck
Un gorgo ininterrotto di niente.
C: mai più lo stesso dopo quel fatto mai più del tutto lo stesso ma quale fatto cosa ci fu di nuovo se non fu una cosa fu un’altra un fatto ordinario qualcosa per cui dopo non potesti più essere lo stesso a trascinarti in giro anno dopo anno affondato nel tuo pasticcio di tutta la vita borbottando a te stesso a chi sennò che non saresti più stato lo stesso dopo questo che non eri più stato lo stesso dopo quello
Beck in scena: fermo come pietra. Una statua antica, alessandrina, un Galata morente. La testa di San Giovanni Battista appena decollata. Un uomo in stato di sonno.
“Voi che dormite, svegliatevi!” è stato a lungo il grido. Ma io grido: “Dormite, dormite! Tuffatevi nella notte, percorrete a grandi passi il labirinto della mente, trovate il minotauro e procuratevi la risposta, confondete la sfinge, liberate la città dall’angelo sterminatore e confondete la morte”(J.Beck)
That time fu incluso nella raccolta di piéces Rima, scritta da Beckett negli anni Settanta. Fu allestito per la prima volta a Londra nel 1976. Dal 1970 al 1978 il Living stava abbracciando la causa dell’azione diretta nella strada con il ciclo The Legacy of Cain (che includerà tra l’altro Seven Meditation on Political Sado-Masochism, Six Public Acts, The Destruction of the Money Tower), con interventi teatrali nelle piazze, davanti alle carceri e alle fabbriche, nelle favelas. Beck e Malina furono incarcerati nel 1971 a Belo Horizonte in Brasile, celle di detenzione del Dipartimento di Ordine Politico e Sociale.
La verità è nella strada e non sempre in teatro.
Julian Beck
Le opere di Samuel Beckett su Internet Bookshop
Ricordando Julian
Note inedite raccolte da Anna Maria Monteverdi
di Gerald Thomas
Quando Julian Beck mi invitò a dirigerlo, quasi svenni. La ragione? Era uno degli uomini di teatro che avevo maggiormente ammirato (e seguito) durante la mia giovinezza a Londra, a New York e in Brasile, e improvvisamente, questa Icona, uscita per un momento dal suo Living Theatre mi invitava a dirigerlo.

Samuel Beckett e Gerald Thomas
Ero già conosciuto a New York per il mio legame diretto con Samuel Beckett e avevo già allestito in anteprima mondiale alcuni dei suoi testi al teatro La MaMa e in altri luoghi, con grandi risultati, non solo a New York ma anche oltre oceano.
Ci presentarono. Era già molto malato e io ero senza parole.
Julian mi lasciò libero di scegliere quale testo di Beckett rappresentare, e io decisi per That Time, una premiére assoluta per l'America. Inoltre avrebbe richiesto molto poco sforzo fisico per Julian. Il brano consisteva di un personaggio che ascoltava la sua stessa voce divisa in tre parti, raccontare del suo passato. Era immobile, o almeno io l'ho reso così, con un piccolo tocco della mano sul volto ogni tanto, quando veniva pronunciata la frase “when was that?”
Poiché Julian non poteva parlare con chiarezza per lungo tempo all'epoca (il cancro gli aveva colpito le corde vocali) andammo in studio e registrammo parola tutto, parola per parola. Prevedendo che il risultato finale sarebbe potuto essere noioso per il pubblico, decisi di usare partiture musicali. Una di John Cage, l'altra di un mio ex compagno di lavoro artistico Luciano Berio (in Zaide a Firenze, 1995, Maggio Musicale). E così il testo divenne, in qualche modo, musica. Julian sembrava sorpreso e felice dell'idea. Ricordo che che quando ascoltò per la prima volta il registratore chiese: “Sono io o avete trovato un altro attore con una voce simile a me che può cantare così meravigliosamente?” Tutti in teatro risero.
E la conclusione non fu altro che un enorme successo. Andavo a prendere Julian a casa sua (nel West End Avenue, 98th Street, a Manhattan) ogni giorno per lo spettacolo. Facemmo tutto esaurito in teatro un mese prima. Lo spettacolo si spinse fino al Theater Am Turm di Francoforte e progettammo altri viaggi, ma Julian si ammalò sempre di più durante la trasferta e dovemmo cancellare la data di Belgrado e altre ancora. Ritornammo tutti a New York.
Lo spettacolo fece a un gran successo in Germania, e sullo spettacolo il critico Peter Iden scrisse un articolo molto lungo che entrava nel merito soprattutto del mio metodo del metalinguaggio teatrale: un vero uomo che stava realmente morendo, recitava sulla scena un uomo che stava morendo.

Pochi mesi dopo Julian morì. Ero a Rio e tornai subito a New York in tempo per i funerali, Allen Ginsberg fece una registrazione video della sepoltura nel New Jersey.
Questa fu una tra le più onorevoli e incredibili esperienze della mia vita. Julian mi disse: “Se vuoi fare una cosa falla grande, e più grande ancora, vattene da New York. Vai in Brasile”. L'ho fatto. Ho seguito ogni singolo consiglio che lui mi diede. Julian non era di questo mondo. Devo gran parte della mia posizione artistica oggi (71 testi e opere liriche rappresentate in 12 Paesi) al consiglio di Julian.
Dio ti benedica Julian. E' duro credere di essere stati su questo pianeta per vent'anni senza di te. Ricordo ogni ruga sul tuo volto, tutte le volte che hai sorriso, nonostante il tuo dolore, il tuo enorme dolore metafisico di non essere stato in grado di cambiare il mondo come avevi sognato. Ma, d'altra parte, ti sei salvato dalle atrocità di George W Bush e dalla militarizzazione ed egemonia degli Stati Uniti nel mondo, dall'invasione dell'Iraq, dalla morte di 200.000 civili che non c'entravano niente, tutto in nome del Petrolio, dell'avidità e oggi c'è ancora più discriminazione di quando eri tra noi. Il mondo è tornato indietro. Viviamo in una società orribile, Julian. Tu ci hai lasciato appena in tempo, quando la corruzione si poteva appena vedere o sospettare. Ora infetta tutti i media, tutte le istituzioni, governi e società. In qualche modo sono felice che tu non sia testimone di questa globalizzazione.
D'altra parte però sono infelice che il mondo abbia perso uno dei suoi più valorosi guerrieri. Forse se tu fossi qui, tutto questo orrore sarebbe stato colpito allo stomaco e al cuore, non avrebbe resistito al tuo carisma. Il tuo incredibile carisma. Mi spiace, sto piangendo e non riesco più a scrivere. Mi manchi troppo.
LOVE
Gerald Thomas
October 2005
Teatro & storia è online
Una mail a ateatro
di Nicola Savarese
Caro Oliviero,
intanto buon anno, buon ateatro e buone pratiche! Come ti avevo annunciato qualche tempo fa, abbiamo varato www.teatroestoria.it
Si tratta del sito della rivista che ben conosci, nata vent'anni fa e oggi diventata un annale edito da Bulzoni. Cogliendo l'occasione dell'anniversario, vent'anni per un periodico sono tanti, noi della redazione avevamo pensato di pubblicare in rete gli indici dei numeri passati e anche qualche saggio: un salto nella rete leggero e, come si dice, di puro servizio. Se non che, mentre si discuteva del più e del meno sul da farsi, abbiamo incontrato Francesco Petroni e Aldo Azzari, due informatici non solo esperti ma anche pazienti che hanno subito rilanciato la sfida e hanno pensato bene di trasformare i nostri archivi - saggi, ricerche, preprint e polverose cartelle - in un database che potesse interessare ricercatori, studenti e curiosi del teatro. Non sto qui a raccontarti la transizione da analogico a digitale, che del resto è appena cominciata: immagino che ne conosci qualche esperienza in dettaglio. Così, dall'oggi al domani, abbiamo trovato un nuovo lavoro da fare. Non che stessimo proprio con le mani in mano, ma insomma rendersi ben conto che il virtuale richiede una pratica che virtuale proprio non è, era l'ultima delle nostre aspirazioni. Ad ogni modo siamo in mare e navigabili oltre che un po' navigati: e questo ci rallegra. Non ti traccio una mappa del sito che non è ancora fatta, tuttavia ti renderai conto dai vari menù agibili, e da qualche prova di assaggio, che si può trovare un certo interesse. Abbiamo dato attenzione alle nostre p-ossessioni (storia del teatro, teatri laboratorio, teatri asiatici e orientali, arte dell'attore...) con una particolare riverenza al mondo dei database e delle immagini teatrali. Nelle pagina dei superklink, le nostre affinità elettive, abbiamo messo anche ateatro che ci conforta e ci ispira per regolarità, prestanza e ardimento. Tenendo conto che oggi la fratellanza non può che essere multietnica e reciproca, daresti notizia dell'ammaraggio?
Un caro abbraccio
Nicola Savarese
Benvenuto nel magico mondo degli smanettoni, caro Nicola.
E intanto, per i visitatori di ateatro ecco il banner con il link del sito di "Teatro e storia":

Virtual Ubu
Note di regia & foto
di Fortebraccio Teatro
All’interno del progetto RADIOVISIONI, già articolatosi nella riscrittura del mito di Edipo (BUIO RE_da Edipo a Edipo in radiovisione _ 2003) e su una precisa sezione dell’Amleto shakespeariano (PER ECUBA _Amleto, neutro plurale _ 2004), proponiamo i personaggi “Ubu”, in una delle loro declinazioni più attuali.
Il testo di Jarry, datato 1899, a settant’anni dalla prima rappresentazione italiana, completa un percorso che dall’umanotroppoumano ha tratto il campo d’azione e di pensiero.
"ai molti padroni
che consolidarono la sua corona,
quand’egli era re,
UBU INCATENATO
offre l’omaggio dei suoi ceppi”
.
Con questa dedica Alfred Jarry, ci presenta uno degli episodi successivi all’Ubu Re.
UBU INCATENATO è un inno alla libertà attraverso la mitizzazione della schiavitù.
Sembra essere il manifesto filosofico-politico delle marionette di Jarry, capaci, dentro a un mondo artificiale, parallelo, altro, doppio, terzo, diverso, patafisico (ossia attinente alla “scienza delle soluzioni immaginarie”), di riflettere, tra estremismi e paradossi, sulla natura dello spirito, delle cose e delle relazioni.
.
Dopo essere stato re di Polonia e d'Aragona, Padre Ubu aspira a diventare il più schiavo tra gli uomini.
In una sorta di carriera, comincia come lustrascarpe per diventare poi maggiordomo tuttofare, servo frustato, arrestato, processato, incatenato, esiliato e infine schiavo rematore imbarcato su una galera turca.
Ma più egli cerca di servire gli altri, più gli altri lo riconoscono, proprio per questo, come il più libero degli uomini. Talmente libero, da prendersi la libertà di essere schiavo.
Padre Ubu diventa un esempio per molti, che da liberi cercano di ferrarsi a una qualche catena acclamandolo di nuovo re e vanificandone il proposito iniziale.
.
Libertà e Schiavitù sono dentro un solo concetto e contemporaneamente.
È un paradosso che ha determinato le modalità di ricerca.
Forse per la cara riflessione sull’attore, sullo stare in scena, sull’essere autori di sé, e forse anche per Jarry rispetto a Ubu, per il loro grado di relazione, appartenenza e dipendenza, la questione più interessante ci è sembrata quella dell’identità, del punto di vista, dei ruoli.
Abbiamo cercato un modo per essere allo stesso tempo Ubu e Jarry, quindi non solo la marionetta, e la mano che la anima, non solo il burattino e colui che tira i fili, ma anche l’autore di fronte a quelle forme di se stesso che diventano le proprie opere.
Ma se la ricerca è il fine e non il mezzo, quello che ci interessa è il processo creativo, non l’opera creata.
.
Su questa strada abbiamo incontrato la realtà virtuale.
Grazie a un esoscheletro in grado di inviare informazioni ad un computer, possiamo tradurre le azioni fisiche di un attore in scena e dal vivo in immagini digitali, ritrattarle o ricollocarle in ambienti altri rispetto a quelli reali.
Con la "motion capture" che ci è possibile praticare grazie alla collaborazione con Andrea Brogi, docente di Realtà Virtuali all’Università di Milano, l'incatenamento anche tecnologico, ci dà la possibilità di moltiplicarci e di sviluppare lo spettacolo dentro una riflessione fondamentale: più la tecnologia incatena l'attore sul palco, più si libera il personaggio virtuale che gli corrisponde.
In quello che immaginiamo come un “concerto scenico”, procediamo, come Ubu, per gradi.
Il primo livello è quello dell’amplificazione.
Un microfono per la voce è la prima tappa dell’incatenamento.
Corrisponde alla dichiarazione iniziale di Padre Ubu sull’intenzione di diventare schiavo. Ma anche l’esoscheletro è immaginabile come un microfono del corpo che lo amplifica e lo rende altrimenti visibile e mutabile, lo moltiplica, lo reinventa anche graficamente.
Aggiungiamo controlli e tecnicismi, strumenti collegati alle conquiste degli Ubu, vincolati, appesi, incatenati a macchine e computer.
.
La libertà è la schiavitù!, dice un personaggio.
Come se il teatro fosse veramente un appuntamento in una terra di confine.
Ci andiamo insieme a Ubu, come fosse un Dummy, un manichino da crash-test, uno di quelli usati per gli esperimenti sulla sicurezza, per scoprire quale effetto faccia essere legati ad un sedile e mandati contro un muro. Stiamo dentro e fuori, in bilico, raddoppiati da chi ci corrisponde in scena mentre siamo in scena. E in attesa dell’air-bag.
Lo spettacolo sarà a Cecina, 28 gennaio, ore 21, Teatro Eduardo (Armunia).




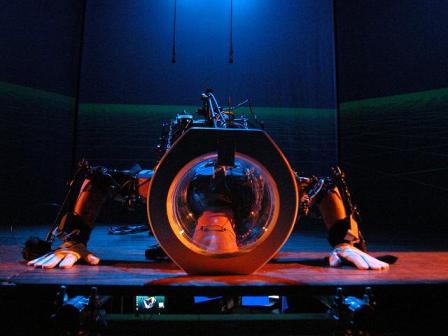



Le catene virtuali di Ubu
Ubu incatenato di Jarry secondo Roberto Latini e Gianluca Misiti - Fortebraccioteatro
di Andrea Balzola
Sistemi digitali interattivi di Andrea Brogi e video in croma key di Pierpaolo Magnani - Xlab Digital Factory

Il Teatro Vascello di Roma ha ospitato uno dei rari debutti italiani di drammaturgia tecno-teatrale, protagonista unico e molteplice (come un burattinaio dell’era virtuale, anima e dà voce a tutti i personaggi) Roberto Latini, che porta in scena un meno noto, ma non meno geniale, Ubu, quello incatenato, scritto da Jarry nel 1899. Nella didascalia iniziale del testo (breve, ma in 5 atti), giustamente riproposta all’inizio dello spettacolo, c’è già il fulcro dell’idea patafisica: “Ai tanti PADRONI che rafforzarono la sua corona quando era re, UBU INCATENATO offre l’omaggio delle sue catene”; dopo aver usurpato con l’inganno e la ferocia il trono di Polonia e d’Aragona e aver atrocemente vessato e sterminato i suoi sudditi (Ubu re), ora l’anarchico tiranno rovescia la libertà del potere assoluto nel desiderio di una altrettanto assoluta schiavitù. Scendendo gioiosamente tutti i gradini della sottomissione, da soldato semplice a lustrascarpe, da servo a carcerato e infine rematore su una galera turca, Ubu ambisce e ottiene di essere umiliato, frustato e incatenato. La sua volontaria e perfetta sottomissione ne fa un modello, tanto che il caporale degli uomini liberi gli dice: “Vi prendete la libertà di fare persino quello che è stato ordinato. Siete un più grande uomo libero...”. Fino al punto che il popolo vuole imitarlo cercando nuove catene e lo acclama, questa volta contro la sua volontà, re. Ubu incatenato non è un personaggio masochista, è il più forte e il più libero di tutti perché è colui che ha raggiunto il potere di sottomettersi deliberatamente e che quindi toglie – da schiavo – il potere al suo padrone, poiché il potere si gratifica davvero solo laddove la sua volontà è imposta, è questo infatti l’”eros” del potere: la sopraffazione. Dal testo di Jarry, Latini ricava abilmente un adattamento con spunti di attualità (niente di più naturale in tempi dove si fanno case e regni abusivi delle “libertà”), una sintesi che soprattutto negli ultimi atti diventa drastica riduzione, selezionando le situazioni e i personaggi più emblematici, alcuni dei quali rappresentati mediante immagini di computer grafica bidimensionali o tridimensionali e animate con l’armatura motion capture. Gli ambienti digitali interattivi (collegati ai movimenti dell’attore attraverso il motion capture) sono stati realizzati da Andrea Brogi e il video in croma key (con i diversi travestimenti-svestimenti di Ubu) da Pierpaolo Magnani, entrambi del gruppo Xlab che in quest’occasione ha integrato la propria ricerca tecnologica con la ricerca teatrale di Latini, una simbiosi riuscita perché qui l’uso della tecnologia non ha né una finalità puramente spettacolare né riproduce precedenti esperienze italiane (come quelle di Krypton, Studio Azzurro, Castello, Verde) o straniere (La Fura e Marcelì Antunez soprattutto), ma fa evolvere nel contemporaneo l’idea originaria dell’Ubu di Jarry, che doveva essere uno spettacolo di burattini per adulti e riprende l’astrazione recitativa della marionetta invocata da Kleist e da Craig. Qui la Super-Marionetta Latini, dotato di una modulazione, un’espressività e un controllo vocali notevoli, duella esplicitamente col fantasma di Carmelo Bene (evocando soprattutto il Pinocchio), ed è nello stesso tempo burattino e burattinaio, in una rigorosa e stilizzata partitura gestuale, la cui coreografia è pilotata in parte dalle esigenze del software e in parte dall’efficace trama musicale di Gianluca Misiti. La scena diventa congegno (ottimamente gestito da tutti i collaboratori tecnici), teatrino tecnologico dove il meccanismo è rivelato, ostentato, macchina che incrocia luci, amplificazioni, microtelecamere che riprendono in diretta, videoproiezioni e alcuni oggetti simbolici come una sorta di metronomo meccanico, una lavatrice-rigeneratrice, una sirena luminosa, un asse da wc che diventa botola e un “sedile” da rematore-automobilista. La vocalità è sempre opportunamente artefatta, non cade mai se non per caricatura nel recitato che tanto ancora imperversa nel teatro italiano vecchio e nuovo, è affollata di voci e pulsioni diverse che diventano la schizofrenia di un solo personaggio, così tirannicamente egocentrico da aver azzerato il mondo intero fagocitandolo nella sua enorme ventraglia divoratutto. Anche l’uso delle immagini di computer grafica incrociano i generi del cartone animato con quello della rappresentazione architettonica virtuale, sempre però in chiave d’ironia, di contaminazione o di astrazione, evitando la mimesi della realtà come quella del genere. Lo spettacolo ha poi un rallentamento conclusivo e una moltiplicazioni di finali, è il momento in cui Ubu si spoglia della sua armatura-catena tecnologica, riflette e ritorna “re”, tornando a usare l’ombrello, strumento di potere “troppo difficile da maneggiare”. Forse qui il personaggio si riumanizza un po’ troppo, ma dopotutto è sempre il paradosso di un personaggio che gioca a far l’attore, in una finzione che si raddoppia all’infinito e mette in cortocircuito le convenzioni, a partire da quelle teatrali.
UBU INCATENATO di Alfred Jarry
Adattamento e regia di Roberto Latini, con Roberto Latini, e con Paolo Pasteris; musiche e aiuto regia di Gianluca Misiti; ambienti digitali interattivi di Andrea Brogi; assistenza al motion capture di Paolo Pasteris; luci e direzione tecnica di Max Mugnai; direzione di scena di Dario Palumbo; video in cromakey di Pierpaolo Magnani.
Produzione Fortebraccioteatro con il sostegno di Armunia, teatri stabili d’innovazione CSS e Florian, in collaborazione con Art Mama Factory, Blue Cheese Project, Ass.Cult Dn@, Xlabi Digital Factory.
Teatro Il Vascello di Roma, dicembre 2005
 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
Le nuove frontiere dell’arte digitale
Christiane Paul, Digital art, Thames & Hudson
di Silvana Vassallo
E’ a partire dagli anni Novanta che musei e gallerie hanno iniziato in maniera sistematica ad organizzare mostre e commissionare opere di arte digitale, conferendo una nuova visibilità ad un movimento artistico relegato per decenni ai margini del mondo dell’arte istituzionale. Sotto questa spinta è emersa con maggior forza la necessità di contestualizzare, storicizzare e fornire analisi critiche di quello che si presenta come un fenomeno complesso e multiforme, che per svariati motivi tende a sfidare facili categorizzazioni. L’arte digitale occupa infatti un territorio di frontiera tra arte, scienza e tecnologia, e un suo assetto critico richiede competenze multiple, ancora in parte da formare. Le sue coordinate sono instabili e fluttuanti, poiché l’incessante sviluppo tecnologico pone sfide sempre nuove alla sperimentazione artistica. Inoltre, a partire dagli anni Ottanta, l’enorme diffusione del computer come strumento per la realizzazione e la manipolazione di immagini ha esteso enormemente l’ambito delle sue applicazioni in una miriade di esperienze artistiche diversificate, problematizzando l’intercettazione di una specificità dell’arte digitale.
Il libro di Christiane Paul, Digital Art, è un utile strumento per orientarsi tra le opere che utilizzano i nuovi media. Curatrice di New Media Arts per il Whitney Museum of American Art, direttrice di Intelligent Agent , magazine on line dedicato all’arte digitale, e docente di Computer Arts presso la School of Visual Arts di New York, l’autrice affronta l’argomento da diverse prospettive, allo scopo di fornire “un resoconto delle molteplici forme di arte digitale, del loro linguaggio estetico e della loro evoluzione storica e tecnologica”. Nel volume la storia dell’arte digitale viene contestualizzata sia in relazione all’evolversi delle innovazioni tecnologiche sia in relazione agli influssi derivanti da movimenti storico-artistici quali Dada, Fluxus e Arte Concettuale, tra i primi ad aver concepito opere di “arte programmata”, basate cioè sulla coesistenza di casualità ed istruzioni formali, e ad aver privilegiato forme d’arte processuali e performative incentrate su un forte coinvolgimento del pubblico, anticipando molte delle caratteristiche sviluppate dalle arti tecnologiche.
La Paul stabilisce una fondamentale differenza tra tipologie di opere che utilizzano le tecnologie digitali come tools, vale a dire come strumenti di ausilio per realizzare forme d’arte tradizionali (fotografie, films, quadri e sculture), e tipologie di opere che le utilizzano come medium, ossia come linguaggio comunicativo da investigare nelle sue caratteristiche specifiche, al fine di sperimentare nuove forme di espressività artistica ( net art, web art, installazioni virtuali e interattive eccc). All’analisi di queste due tipologie, che non vanno tuttavia intese rigidamente ma come parametri orientativi, sono dedicati rispettivamente i primi due capitoli del libro, mentre il terzo investiga in maniera trasversale, indipendentemente dalle caratteristiche formali, le principali tematiche messe in gioco dall’arte digitale.
Un tema importante affrontato nell’introduzione, riguarda le precarie modalità di esposizione e conservazione di queste nuove forme d’arte, in quanto musei e gallerie spesso non sono attrezzati ad ospitarle, sia per l’assenza di spazi espositivi flessibili, sia per la mancanza di attrezzature tecnologiche adeguate, tutti fattori che compromettono una corretta fruizione e un adeguato apprezzamento. Nell’introduzione l’autrice traccia anche un quadro sintetico della fase pionieristica dell’arte digitale: dalle prime visualizzazioni di immagini al computer risalenti alla metà degli anni Sessanta - realizzate da scienziati come Michael Noll, Georg Nees e Frieder Nake in ambienti universitari e centri di ricerca, con l’ausilio di macchine ingombranti e costosissime -, alle sperimentazioni effettuate nel corso degli anni Settanta e Ottanta in vari ambiti - dall’animazione all’installazione, alla telepresenza – ad opera di artisti come John Whitney, Charles Csuri ,Vera Molnar e Robert Adrian, spesso in stretta collaborazione con tecnici e programmatori.
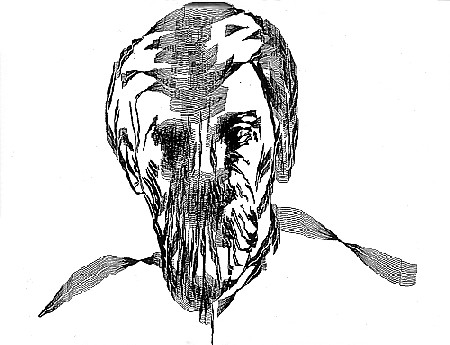
Charles Csuri, Sine-curve man, 1966

John Withney, Digital Armony
Forse questa prima fase pionieristica avrebbe meritato un maggiore approfondimento in un libro interamente dedicato all’arte digitale, ma l’autrice si sofferma maggiormente sulla produzione più recente, dalla fine degli anni Ottanta in poi, quando cioè il computer diventa una macchina multimediale universale, analizzando, attraverso un nutrito numero di opere, le molteplici poetiche ed estetiche sorte a seguito di quella che si è configurata come una vera e propria rivoluzione digitale. Molti dei lavori presi in esame sono stati realizzati e esibiti in manifestazioni tenutesi in importanti centri di produzione e ricerca sui nuovi media, come lo ZKM (Germania), l’ICC (Giappone), Ars Electronica (Austria), il Banff New Media Center (Canada) e il V2 (Olanda). Dispiace constatare la totale assenza di riferimento alla produzione italiana, che pur vanta artisti significativi come Studio Azzurro, Giacomo Verde, Piero Gilardi, da attribuire non tanto ad una carenza dell’autrice quanto piuttosto alla quasi totale mancanza in Italia di startegie istituzionali volte a valorizzare e promuovere nuove forme di arte tecnologica.
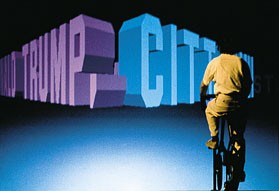
Jeffrey Shaw, The Legible City, 1989-91
Una prima classificazione effettuata dalla Paul, come è stato detto, riguarda l’uso di tecnologie digitali come strumento di ausilio in forme artistiche preesistenti. Attraverso una serie di opere grafiche, fotografiche, pittoriche e scultoree che utilizzano il computer in determinate fasi delle loro procedure compositive, la Paul illustra alcuni dei principali indirizzi di ricerca: dalla produzione di immagini astratte basate su variazioni di algoritmi ad assemblaggi effettuati con le tecniche del morphing o del collage digitale; dalla combinazione di immagini reali e digitali per creare universi ibridi, alla realizzazione di sculture virtuali, che traducendo la nozione di spazio tridimensionale nel territorio del virtuale aprono nuove dimensioni alla relazione tra forma, volume e spazio. Al di là delle differenze, ciò che contraddistingue tutte queste forme di sperimentazione è l’accresciuta possibilità di manipolazione delle immagini consentita dalle tecnologie digitali, che attiva nuovi modi di mescolarle e montarle, tendenti ad eliminare qualsiasi forma evidente di sutura:
“Le tecnologie digitali aggiungono una dimensione addizionale agli assemblaggi e ai collage, poiché elementi disparati possono essere fusi più omogeneamente, focalizzandosi su una “nuova” forma di realtà simulata piuttosto che sulla giustapposizione di componenti con una distinta storia spaziale o temporale. I collages e le composizioni digitali spesso comportano uno spostamento dall’evidenziazione dei confini alla loro cancellazione”

Lilliam Schwartz, Mona/Leo, 1987.

Oliver Wasow, Untitled, 1996.
Nel secondo capitolo vengono prese in esame le opere che utilizzano le tecnologie digitali come medium artistico. Analogamente a quanto sostiene lo studioso Lev Manovich nel suo libro Il Linguaggio dei Nuovi Media, la Paul sottolinea come le caratteristiche peculiari dei nuovi media offrano specifiche “opportunità estetiche”: essi sono interattivi, partecipativi, modulari, programmabili, personalizzabili e queste proprietà possono essere investigate artisticamente in molteplici modi, combinando diversi elementi. La Paul delinea diverse tipologie di arti digitali suddividendole, in base alle loro caratteristiche formali, in: installazioni; internet art e reti nomadiche; software art; realtà virtuale e realtà aumentata; suono e musica.

Toshio Iwai, Piano – as image media, 1995.

Monica Fleischmann, Wolfgang Strauss, Christian-A. Bohn, Liquid Views, 1993
Nel terzo capitolo vengono individuati alcuni dei temi principali che ricorrono nelle opere digitali, operando una distinzione tra lavori che trattano tematiche legate specificatamente alle tecnologie digitali – telepresenza, telerobotica, database, visualizzazione di dati, ipertesti, videogichi e azionismo mediatico – ed opere che affrontano tematiche più generali, riguardanti il corpo e l’identità, riconfigurate però in una prospettiva che tiene conto degli sviluppi tecnologici e scientifici. Emerge un panorama variegato e affascinante di sperimentazioni: realizzazioni di browser alternativi; visualizzazioni di ogni sorta di processi e flussi dinamici di comunicazione; progetti che esplorano varie forme di vita artificiale e di telepresenza; sguardi problematici su questioni riguardanti la privacy, il voyeurismo, la sorveglianza e le identità multiple e fluttuanti disseminate nelle reti.
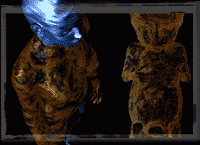
Victoria Vesna, Bodies Inc., 1996
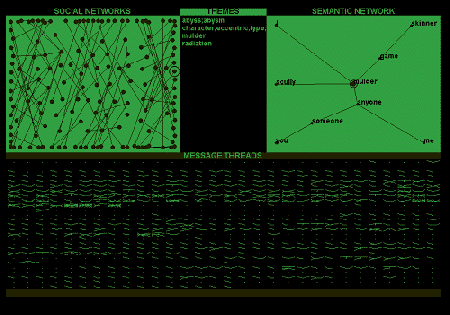
Warren Sack, Conversation Map, 2001
Il tentativo di sistematizzare e fornire chiavi di lettura di una materia in costante trasformazione facendo ricorso a una vasta documentazione e ad un ricco apparato iconografico (245 illustrazioni di cui 176 a colori) è senza dubbio uno dei meriti di Digital Art. Tuttavia l’approccio descrittivo-classificatorio finisce per prevalere su quello valutativo-critico. Talvolta risulta difficile considerare come “arte” molte delle opere menzionate, questione forse ineludibile, se si considera che ci si muove comunque in un terreno altamente sperimentale, e che molte di esse non sono altro che tentativi di investigare cosa si può fare con i nuovi media, per far fare loro delle cose che i progettisti non avevano mai pensato, per spingerli al di là dei loro limiti, per riflettere sui loro effetti e significati. Ai posteri l’ardua sentenza …
Christiane Paul, Digital Art, Thames&Hudson, London 2003.
Un carro carico di... storia del teatro
Il progetto di formazione del pubblico di Alessio Pizzech
di Anna Maria Monteverdi
Ideazione e regia di Alessio Pizzech.
Con Barbara Esposito, Ilaria Di Luca, Andrea Gambuzza
Alessio Pizzech regista, operatore teatrale e collaboratore di vari festival e strutture teatrali in Toscana (Armunia, La Città del Teatro), ha ideato per la Fondazione Toscana Spettacolo un progetto di formazione per le scuole: si tratta di lezioni tra la storia e la pratica scenica, itineranti come il Carro di Tespi che qualche secolo fa portava gli attori girovaghi a rappresentare spettacoli nelle piazze.
Protagonista è il teatro, il suo cambiare volto dalla Grecia all'Italia dell'epoca della Commedia dell'Arte, dalla Venezia di Goldoni e la Parigi di Moliere fino alla stagione del grande attore ottocentesco. All'introduzione storica segue una rappresentazione ad opera di Ilaria De Luca, Andrea Gambuzza e Barbara Esposito. Tutto per appassionare un pubblico giovane a una prima formazione teatrale - parlando di spazio teatrale, della costruzione del personaggio, di rappresentazione, attore, e testo drammaturgico - e instillargli la voglia di varcare la soglia del teatro come spettatori.
Si tratta di un ciclo di lezioni che permettono agli studenti partecipanti di impadronirsi di strumenti di elaborazione dei linguaggi del teatro e di critica nei confronti dello spettacolo in quanto forma d'arte, divulgando concetti e problemi, ipotesi di lavoro e nuove teorie a chi per età non partecipa ancora a tali orizzonti. Tra i Comuni della Toscana che hanno aderito al progetto: Barberino del Mugello, Bagnone, Volterra.
23/25/26 GENNAI0
Il teatro antico:
L’uomo ed il suo destino. Dal Teatro Greco alla Sacra Rappresentazione medioevale
30 GENNAIO, 1/3 FEBBRAIO
La commedia dell’arte e la riforma goldoniana
Il palcoscenico della vita: il genio di Goldoni , Shakespeare e Molière
6/8/10 FEBBRAIO
La nascita del grande attore a cavallo tra ‘800 e ‘900 e lo sviluppo delle grandi drammaturgie borghesi nazionali. Tra Eleonora Duse e Cechov: i Grandi artisti della scena tra ‘800 e ‘900
Fernando Mastropasqua aveva elaborato alcuni anni fa per Livorno un progetto legato alla formazione dello spettatore teatrale e tra le note di presentazione (significativamente intitolate Le scuole per la Scuola) affermava la necessità dell'attivazione di laboratori teorici e pratici di riconosciuto valore dentro gli enti preposti all'educazione affinché “le scuole che insegnano il mestiere teatrale concorrano a rendere più aperta, più vivace, più libera la Scuola che ha un compito più alto: non insegna un mestiere, ma il mestiere di vivere”. E' in fondo, un po' anche questo uno degli obiettivi delle lezioni del Carro di Tespi?
Certamente anche il Carro di Tespi concorre al raggiungimento di una osmosi più forte tra gli ambiti del “far teatro” e il mondo della scuola. Essa è certo l’Ente preposto alla formazione dell’individuo, in essa possiamo trovare risorse culturali ed umane per l’arricchimento delle nuove generazioni ma al tempo stesso la scuola ha bisogno della formazione artistica, del teatro come strumento privilegiato per riflettere sul “vivere” per strutturare un ampio percorso pedagogico rivolto a una nuova cultura della trasformazione, del cambiamento intesi nella loro accezione biologica e psicologica e quindi sociale.
In un mondo, come quello contemporaneo che vive da una parte la totale necessità dell’appiattimento e dall’altra la spinta irrefrenabile verso il nuovo, il teatro ripropone alle nuove generazioni la vita come trasformazione individuale e collettiva.
Il teatro racconta pienamente, testimonia con i suoi testi con le sue caratteristiche di linguaggio, il tempo che gli è proprio. Il teatro vive il proprio tempo e può aiutare la scuola a non divenire un museo della cultura ma un luogo di trasmissione .
Il Carro di Tespi per la sua conformazione ibrida per un suo non essere spettacolo ed esserlo al tempo stesso si propone, così l’ho concepito, come un agile strumento didattico fatto di persone capaci di costruire relazioni di scambio e conoscenza.
Il Carro si pone come una dimensione spazio/tempo educativa che apre a nuovi orizzonti, che vuole parlare della vita, del mutare della vita degli uomini attraverso un mezzo così efficace.
Il Carro di Tespi è questo entrare nella scuola per uscirne, per non sentirla come un ghetto; ad essa mi rivolgo come parte di un complesso sistema sociale, come catalizzatore di sensibilità: una scuola fatta di persone.
Scuola come istituzione ma al tempo stesso nuova Agorà che nel teatro, nello spazio teatrale a confronto con i teatranti trova una sua realizzazione piena. Il carro vuole frantumare i confini ridisegnare nuovi possibili modelli del sapere.
Come sono strutturate le lezioni e come le rappresentazioni si relazionano con la sezione storica/teorica?
Le lezioni sono strutturate in quattro parti.
La prima si sta svolgendo in questi giorni ed è rappresentata sia dalle prove degli attori che si preparano all’incontro con il pubblico e dall’altra dal lavoro di progettazione teorico e pratica, di programmazione che sto svolgendo con i docenti di Barberino, Volterra e Bagnone. Un lavoro di ricerca di senso, di necessità di comprensione degli obiettivi comuni che legano me teatrante all’insegnante e anche le specificità che sono caratteristiche dei due mondi che si incontrano e dei territori dove il carro di Tespi arriverà. Un fase di costruzione ma anche di ascolto.
Scuola e Teatro si domandano: come esserci utili vicendevolmente? Utili nel senso di sollecitare un interesse nelle nuove generazioni, come avvicinarle allo specifico teatrale senza operare forzature ma utilizzando tutto il portato fantastico, mitico che sta dietro alla rappresentazione.
Poi l’incontro - o meglio gli incontri - con i ragazzi partendo dalla consapevolezza di avere adulti educatori che già conoscono il progetto. La lezione ha una prima parte da me condotta che è una e vera presentazione del luogo: il teatro come luogo del silenzio, dell’ascolto, il luogo dove spazio e tempo si sospendono, il teatro come luogo del buio. Capire quindi dove siamo quale può essere la sacralità del luogo teatro poi la lezione vera e propria nel senso della rappresentazione a opera dei tre attori e la parte più importante: il dialogo con i ragazzi per cercare di capire le loro idee sul teatro, le loro impressioni su quanto visto il dialogo con i tre giovani attori (Ilaria Di Luca , Barbara Esposito e Andrea Gambizza ) ed infine un approfondimento a ruota libera “sul teatro in generale e niente in particolare”, come diceva Shaw!
L’obiettivo è certamente prendere più o meno a pretesto la storia del teatro per parlare di noi per capirci per suscitare domande, per incuriosire.
Dalla tua esperienza di formatore e operatore culturale e teatrale: gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori che tipo di teatro conoscono o frequentano? E perché è necessario secondo te oggi fare una "formazione dello spettatore"?
Dalla mia esperienza di formatore i ragazzi non conoscono il teatro, anzi lo detestano. Spesso hanno visto del brutto teatro, sono stati deportati in massa a vederlo non ne comprendono la necessità. Ecco perché per il Carro tanto lavoro pedagogico alle spalle con gli insegnanti e piccoli numeri di ragazzi su cui lavorare.
Il teatro deve diventare un’esperienza umana spesso per loro è un’uscita fuggevole un mordi e fuggi, qualcosa di assolutamente lontano dai loro tempi dai loro ritmi di ascolto ma ne sentono la voglia di farlo, di conoscerlo. I ragazzi sono segretamente attratti dal teatro, affascinati dalla forza di questo mezzo, da come esso possa segnare la loro interiorità. Si tratta di portare a coscienza questo interesse: lo incontrano e se ne innamorano perché sentono che lì sta la possibilità di raccontarsi di mettersi in gioco di conoscersi. Come spettatori oramai passivi non si riconoscono in una dimensione attiva dell’essere spettatore. Abituati a consumare immagini, parole, non possono avvicinarsi al teatro senza domandarsi quanto veramente gli appartenga.
Ma la capacità di abbandonarsi al mezzo è forte…ecco perché è importante formare spettatori per non ritrovarsi solo attori, per aiutare ragazzi a sentirsi pubblico attivo a partecipare all’evento pensando di determinarne la riuscita sentirsi spettatori attivi capaci da cogliere le domande.
La fruizione del teatro non può quindi andar separata da una serie di iniziative che diano ai cittadini la possibilità di vivere quasi quotidianamente lo spazio teatrale. Parlo di cittadini che siano così capaci di vivere il mezzo totalemente capaci di sentirne la possibile trasformazione interiore che in loro produce. Cittadini attenti quindi a fare comunità, spettatori che sono una comunità che si sentono uniti nel riconoscersi nello spazio teatrale per riconoscere la propria singola entità all’interno di un cerchio sociale.
Un progetto è uno spazio/tempo in cui il pubblico dialoghi con il teatro, con chi lo fa. I teatranti quindi che ritornano a una contiguità tra il teatro e il suo pubblico.
Che i teatranti smettano di sentirsi isolati dal mondo come collocati in un altro mondo, giudicanti il resto del mondo. Dialogare con esso con le persone semplici che non possono vivere la preziosità del dedicare la vita al pensiero, alla sensibilità, al fiore dell’anima .
Il Carro quindi per dialogare: porsi il problema di formare o meglio di avvicinare. Lasciamoci avvicinare, tendiamo il nostro spirito e le nostre parole al pubblico, aiutiamolo a sentirci alleati della sua quotidianità..necessario questo se non vogliamo l’estinzione… Se vogliamo essere riconosciuti dobbiamo riconoscere che c’è una parte di mondo che non mette il teatro al primo posto della vita (ciò ci pare strano!) ma che comunque in esso può trovare linfa e vita per il proprio futuro… A questi dobbiamo rivolgerci per avere alleati nella lotta contro l’effimero, contro il vuoto.
Progetti come il tuo possono contribuire a favorire questo tipo di espressione artistica, a saper leggere certe sperimentazioni teatrali e magari anche a far tornare il pubblico giovane a frequentare i teatri in maniera massiccia?
Credo che progetti come il mio contribuiscano a questo, non dico che siano la panacea, ciò che risolve ma ritengo che ogni sforzo che facciamo non solo esteticamente ma anche metodologicamente per creare nuove relazioni fra teatro e società siano stimoli utili. Il plus valore di questo progetto è anche il carattere regionale, il tentativo di creare un modello di intervento sul territorio.
E' necessario costruire modelli di lavoro applicabili e disegnabili secondo le necessità più o meno esplicite di ogni territorio. Creare progetti che attraversino il tessuto sociale ma che partano dalla scelta etica di porre il destinatario al centro di tali progetti formativi e non come un mezzo attraverso cui realizzarli.
Il destinatario ha la sua importanza: il suo valore etico, il rispetto che dobbiamo allo spettatore sono valori che abbiamo perso che i teatranti presi dalle loro smanie di realizzazione hanno abbandonato.
Il pubblico in realtà è lì, ci attende dobbiamo sollecitarlo in modo intelligente ed umile.
Per il Carro di Tespi ho scelto tre attori giovani provenienti da Scuole importanti nazionali ed internazionali ma che potranno lavorare nell’interesse del progetto e quindi del pubblico anzi del potenziale pubblico che andremo ad incontrare.
Quale è a tuo avviso il pubblico del teatro di ricerca e perché si sta sempre più assottigliando? Andrea Cosentino in un'intervista diceva che in fondo il pubblico del teatro tradizionale, quello degli abbonati, vive l'andare a teatro come un rituale ma che il cosiddeto teatro di ricerca non ha mai elaborato una ritualità alternativa della stessa efficacia che quindi rimane una faccenda generazionale di rapidissimo consumo. Sei d'accordo?
Sono assolutamente d’accordo con Cosentino anzi nel chiedere agli Istituti di portare gli stessi ragazzi a veder in tre settimane le tre lezioni c’è la chiave di lettura della costruzione di un rito. Andare a teatro non è solo vedere un’artista, un lavoro specifico, una ricerca estetica; si è spettatori per il piacere di uscire di casa, di incontrare altre persone,di salutarsi toccarsi baciarsi magari scambiarsi occhiate. Andare a teatro come il costruire per una sera una microsocietà nel foyer prima e poi nella sala.
Il teatro anche in questo ha senso. Le generazioni vicine alla mia hanno ripudiato tale senso rituale, talora lo hanno ritenuto proprio per una spocchia elitaria, atteggiamento borghese ma non hanno saputo costruire alternative a quel vecchio rito. Ora abbiamo un vuoto da colmare tentando di ricucire, di ridare gusto ed entusiasmo agli spettatori sottraendo il teatro alla condanna di essere solo e soltanto noia ed accettando che si possa entrare in una sala pensando che ciò che vedremo magari non ci appagherà ma che quel rito ha ragione di esistenza a prescindere questo.
Per fare questo le istituzioni politiche debbono impegnarsi, garantire continuità, operare per un lento radicamento di tali contenuti nei territori, la politica si assuma la responsabilità di una scelta di cambiamento e i teatranti, sottraendosi alla demagogia, ritrovino una “giovinezza” emotiva che li spinga in un vero “oltre”. La Fondazione Toscana Spettacolo da due anni ha fatto suo questo progetto lo ha stimolato e portato nei territori; io mi sento utile e questo credo,oggi, sia molto.
Info: Fondazione Toscana Spettacolo
http://www.toscanaspettacolo.it
Tel. 055 219851
I Premi Ubu per il teatro 2005
I vincitori e i link alla ate@tropedia
di Redazione ateatro
Sono stati assegnati ieri sera, 19 dicembre 2005, al Piccolo Teatro di Milano, i Premi Ubu per il teatro. Ecco l'elenco dei vincitori, con i link alla ate@tropedia.
1. Spettacolo dell’anno:
Professor Bernhardi di Arthur Schnitzler (Luca Ronconi, Piccolo Teatro di Milano) 23; Urlo di Pippo Delbono (Pippo Delbono, Ert-Emilia Romagna Teatro, Teatro di Roma, Festival d’Avignon) 14; Scemo di guerra di e con Ascanio Celestini (Ascanio Celestini) 7.
2. Regia:
Luca Ronconi (Professor Bernhardi) 21; Antonio Latella (Edoardo II) 12; Pippo Delbono (Urlo) 11.
3. Scenografia:
Margherita Palli (Professor Bernhardi e La Centaura) 26; Fanny & Alexander (Ada, cronaca familiare) 18.
4. Attore:
Massimo De Francovich (Professor Bernhardi e Paolo Borsellino Essendo Stato) 28; Luigi Lo Cascio (Nella tana) 7; Marco Foschi (Bestia da stile) 6; Danilo Nigrelli (Edoardo II) 5.
5. Attrice:
Maria Paiato (La Maria Zanella) 18; Mariangela Melato (La Centaura e Chi ha paura di Virginia Woolf?) 14; Lucilla Morlacchi (La monaca di Monza) 10.
6. Attore non protagonista:
Massimo Popolizio (Professor Bernhardi) 19; Luca Lazzareschi (Re Lear) 14; Luciano Virgilio (Spettri) 8.
7. Attrice non protagonista:
Francesca Mazza (Ada, cronaca familiare - Aqua marina) 14; Cinzia Spanò (Bestia da stile) 13; Maria Pilar Perez Aspa (Troiane) 13.
8. Nuovo attore o attrice (under 30):
Nessun attore ha raggiunto il quorum.
9. Nuovo testo italiano:
Scemo di guerra di Ascanio Celestini 22; Salmagundi di Marco Martinelli 13; Il lavoro rende liberi di Vitaliano Trevisan 9.
10. Bingo di Edward Bond 17; Tre pezzi facili di Martin Crimp 17; Io mi chiamo Isbjörg, io sono un leone di Vigdís Grímsdóttir (ad. Hávar Sigurjónsson) 5.
11. Spettacolo di teatro-danza:
Nessuno spettacolo ha raggiunto il quorum.
12. Premi speciali:
– Giuliano Scabia, instancabile reinventore di un immaginario teatrale contemporaneo attraverso l’opera di drammaturgo, raccontatore, compagno di giochi, maestro, non solo ex cathedra, di molte generazioni 21.
– Marco Baliani per il lavoro con i ragazzi di Nairobi in Pinocchio nero, un progetto che esalta un lungo percorso di narratore in perenne confronto con i temi della ribellione e dell’ingiustizia 16.
– Fanny & Alexander per il viaggio pluriennale alla ricerca della grande letteratura compiuto in Ada, cronaca familiare, misurandosi con una realtà scenica che trascende la necessità di rappresentazione, attraverso una molteplicità di media e di chiavi espressive 16.
– Hubert Westkemper per una vita dedicata a creare una sonorità teatrale, culminante nell’altissimo risultato raggiunto dall’Elettra diretta da Andrea De Rosa per il Teatro Mercadante, con l’uso degli olofoni in funzione di linguaggio 15.
13. Migliore spettacolo straniero presentato in Italia:
The Busker’s Opera di Robert Lepage 20; I La Galigo di Robert Wilson 11; Il sogno di Andersen di Eugenio Barba 9.
NOTA
Al ballottaggio non sono pervenute le votazioni di Luca Doninelli e Goffredo Fofi.
Le votazioni dei critici che hanno partecipato al ballottaggio sono pubblicate on line sul sito della Ubulibri.
Il bando di Concorso Italia di Riccione TTV Festival
Con una nota di Fabio Bruschi sul Concorso Italia
di Riccione TTV
Riccione TTV Festival
18a edizione
Bologna, 3 – 13 maggio 2006
Riccione, 16 luglio 2006
BANDO DI CONCORSO ITALIA_2006
Riccione Teatro organizza dal 1985 Riccione TTV Festival, rassegna internazionale dedicata al rapporto delle arti sceniche con il video, la televisione e in generale le tecnologie e i media della visione e della comunicazione. Al fine di promuovere e portare allo scoperto un’area che, pur rappresentando anche in Italia un segmento vitale della produzione artistica connessa al teatro, stenta a trovare una visibilità appropriata, TTV riserva dal 1995 un concorso video aperto agli autori italiani, il Concorso Italia, che giunge con il 2006 alla 9a edizione.
Regolamento
Art. 1
Il concorso è riservato alle opere riguardanti le arti sceniche (teatro, danza, opera lirica, teatro musicale ecc.) realizzate da autori italiani o prodotte in Italia. Tutte le opere in concorso dovranno essere realizzate non prima del gennaio 2004 e non oltre il 18 febbraio 2006.
L’unico requisito richiesto è che il soggetto dell’opera presentata riguardi il teatro e in generale le arti sceniche. Le opere di semplice registrazione di spettacoli dal vivo non sono ammesse al concorso, ma possono partecipare comunque al festival nel settore della documentazione; non ci sono limiti di durata.
Non sono ammesse opere prodotte o co-prodotte per la televisione.
Art. 2
Le opere partecipanti dovranno essere inviate in 2 copie su supporto DVD, accompagnate da:
scheda di partecipazione interamente compilata e firmata;
curriculum;
2 fotografie e / o diapositive;
breve sinossi di 5 righe dattiloscritte;
eventuali materiali critici e informativi.
Su ogni opera deve essere indicato il titolo.
Le opere devono essere spedite entro sabato 18 febbraio 2006 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:
Riccione TTV Festival
Viale Vittorio Emanuele II, 2 – 47838 Riccione (Rn)
Tel: 0541/694425 – 695746 fax: 0541 475816
e-mail: ttv@riccioneteatro.it
www.riccioneteatro.it
E’ possibile consegnare direttamente in ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 presso Villa Lodi Fè, Parco Centrale, Viale delle Magnolie, 2 – Riccione (di fronte alla stazione ferroviaria).
Non è prevista alcuna tassa d’iscrizione. Si consiglia vivamente l’utilizzo del postacelere o di un corriere.
Art.3
Un’apposita commissione di selezione selezionerà le opere finaliste che verranno esaminate dalla Giuria.
Le opere finaliste saranno proiettate nel corso della 18a edizione di Riccione TTV Festival (Bologna / Riccione, 3 – 13 maggio 2006 presso la Cineteca del Comune di Bologna).
I finalisti dovranno inviare una copia Betacam Sp per la proiezione.
I premi saranno attribuiti secondo l’insindacabile giudizio della Giuria, che assegnerà i premi a Bologna in data e luogo da definirsi. I concorrenti non hanno il diritto legale di appellarsi contro le decisioni della Giuria.
Tutte le opere ammesse al concorso saranno pubblicate sul catalogo del festival e saranno a disposizione del pubblico nella videoteca del festival.
Art. 4
Alle opere premiate dalla Giuria saranno assegnati:
Il Premio Riccione TTV – Concorso Italia alla migliore opera video – 1.500 euro;
Il Premio Speciale della Giuria;
La Giuria deciderà inoltre sull’attribuzione del Premio di Produzione quale riconoscimento e incentivo all’opera di un autore che si sia segnalato per talento e sia ascrivibile all’area degli autori indipendenti – 5000 euro;
Il Premio di Produzione è da considerarsi quale contributo per la realizzazione e produzione di un nuovo video da presentarsi in anteprima alla successiva edizione di Riccione TTV Festival.
Art. 5
Hanno diritto di partecipare al concorso tanto singoli autori quanto gruppi, collettivi ecc. In questo ultimo caso viene comunque richiesta l’indicazione di una persona responsabile che sottoscriva il modulo di adesione.
Art. 6
Inviando la cassetta, i partecipanti certificano che essi detengono tutti i diritti relativi ai lavori inviati e esonerano gli organizzatori da reclami da parte di terzi. Gli autori sono responsabili del contenuto delle proprie opere, anche nei confronti delle persone e dei soggetti rappresentati.
Art. 7
Gli organizzatori declinano ogni onere derivante da eventuali danni, smarrimenti e incidenti che le opere dovessero subire durante le proiezioni e il trasporto.
Art. 8
I partecipanti al concorso saranno avvisati degli esiti finali della commissione di selezione con comunicazione scritta.
Art. 9
I partecipanti al concorso autorizzano l’utilizzo dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 per tutti gli usi connessi alla manifestazione (invio regolamento, materiale informativo ecc.) e per scambi di indirizzi. I partecipanti, ai sensi dell’art. 7, possono ottenere la rettifica dei dati o opporsi al loro utilizzo, scrivendo una raccomandata A/R a Fabio Bruschi, c/o Riccione Teatro, Viale Vittorio Emanuele II; 2 – 47838 Riccione (Rn).
Art. 10
Riccione TTV Festival è autorizzato a:
Riprodurre e diffondere immagini tratte dalle opere presentate in concorso nelle pubblicazioni e nel materiale pubblicitario del festival;
Produrre e diffondere un Cd-Rom /DVD professionale contenente un massimo di tre minuti di ciascuna opera presentata in concorso;
Utilizzare le opere presentate in concorso, per un massimo di tre minuti ciascuno, all’interno di un programma televisivo, prodotto e curato dal festival stesso e trasmesso dalle reti locali o nazionali a scopo informativo e promozionale;
Proiettare le opere durante le giornate del festival;
Utilizzare in Internet, sul sito www.riccioneteatro.it , a scopo promozionale, un massimo di trenta secondi di ciascuna opera presentata in concorso;
Depositare nell’archivio di Act! Archivi del Teatro Contemporaneo di Riccione Teatro le opere partecipanti al concorso, a fine esclusivamente conservativo, didattico, divulgativo (consultazione e prestito). Le opere pervenute non saranno restituite.
Gli autori e i detentori dei diritti d’autore consentono l’utilizzo delle loro opere per propositi culturali, informativi, educativi e comunque non commerciali in altri festival, rassegne, workshop ecc. Riccione TTV si impegna comunque ad informare preventivamente gli autori e gli aventi diritto delle richieste di circuitazione pervenute e a dare seguito a dette richieste solo su autorizzazione di chi detiene i diritti.
Art. 12
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento. Per i casi controversi e per quanto non espressamente previsto il giudizio finale spetta agli organizzatori.
A proposito di TTV Concorso Italia
La novità di questa edizione di Concorso Italia è che il bando è riservato alle opere di autori indipendenti. Sono esclusi dal presente bando le opere prodotte e co-prodotte per la televisione, per le quali è riservato un altro concorso riferito ai programmi televisivi a base di spettacolo delle stagioni 2004/2005 e 2005/2006.
Il Premio Riccione TTV – Concorso Italia avrà luogo a Bologna dal 3 al 13 maggio, mentre il Premio Riccione TTV dedicato al miglior programma televisivo a base di spettacolo si svolgerà a Riccione il 16 luglio 2006.
Uno dei punti tradizionalmente controversi del Concorso Italia, prima nella fase della selezione, poi nella fase della competizione, è quello che il bando segnala all’articolo 1 come punto centrale del concorso: “l’unico requisito richiesto è che il soggetto del video presentato riguardi il teatro e/o più in generale le arti sceniche”! Ci è stato segnalato in più di una occasione che questa terminologia un po’ vaga (riguardi ecc…) non chiarisca bene quali lavori possono partecipare al concorso e quali no.
Ci si può orientare esaminando la tradizione del festival, ideato nel 1985 da Franco Quadri come un territorio di convergenza (e scontro) tra il teatro e le arti sceniche, i nuovi media e le arti visuali, tradizione che è venuta maturando ben prima del numero zero del Concorso (1995).
Mi pare indubbio che molto spesso la pertinenza ‘teatrale’ di un video o di una installazione derivi dalla biografia teatrale dell’artista o degli artisti che avevano prodotto quell’ opera piuttosto che dall’adesione dell’opera stessa a un genere o a un contenuto ‘teatrale’ più o meno ben definito: non di rado sono stati presentati lavori ‘impertinenti’, che presentavano dimensioni pre o post teatrali, espansioni del teatro in qualcosa d’altro ecc., in continuità con la presenza - nella tradizione del teatro italiano contemporaneo d’arte e ricerca - di un legame forte tra la scena, il mondo delle ‘immagini in movimento’ e le arti visive.
E’ indubbio che questa tradizione produca, nelle opere che arrivano al Concorso Italia, dei margini di ambiguità; tuttavia credo che questa ambiguità sia preferibile a un rigido incasellamento in generi e sottogeneri che dovremmo – dato che fortunatamente questa realtà è in continuo movimento – continuamente inseguire in affanno.
Buon 2006 e buon lavoro !
Fabio Bruschi
Direttore di Riccione TTV Festival
Riccione, 23 dicembre 2005
Progetto Domani: il teatro alle Olimpiadi
Con la locandina dei cinque spettacoli per le Olimpiadi di Torino
di Luca Ronconi
Fin dal titolo, “Domani”, questo progetto sembra aprire un interrogativo tra la speranza e il timore. Fermo restando che io mi schiero dalla parte della speranza, le domande che cerchiamo se non altro di formulare in modo corretto – non pretendiamo di trovare risposte – sono complesse e mettono in causa il futuro stesso del teatro. Infatti, se e come il teatro sarà in grado di sopravvivere dipende in buona parte dalla capacità di allargare il suo orizzonte superando in primo luogo schemi drammaturgici che sento ormai logori. Partendo dal presupposto che ciò è possibile, oltre che auspicabile, stiamo lavorando alla messa in scena di forme drammaturgiche assai diverse tra loro: da un classico come Shakespeare al contemporaneo Edward Bond, passando per tre scritture – non teatrali e nate appositamente per questo progetto – che affrontano altrettanti nodi centrali della contemporaneità.
Il progetto si articola in un insieme di cinque episodi teatrali collegati tra loro così come lo sono gli anelli olimpici. Si tratta del Troilo e Cressida di Shakespeare, la Trilogia della guerra di Edward Bond, Lo specchio del diavolo di Giorgio Ruffolo, Il silenzio dei comunisti di Vittorio Foa Miriam Mafai e Alfredo Reichlin, e Biblioetica a cura di un comitato scientifico coordinato da Gilberto Corbellini Pino Donghi e Armando Massarenti. Al centro di questi lavori ci sono i temi della guerra e delle sue conseguenze per i primi due titoli, e negli altri rispettivamente dell’economia, della politica e della bioetica.
Pure sviluppato secondo traiettorie molto diverse tra loro, il tema della guerra e quello conseguente della violenza sono centrali sia nel Troilo e Cressida di Shakespeare sia nella Trilogia della guerra di Edward Bond. Il primo nasce evidentemente da un’elaborazione elisabettiana dell’Iliade, che però in Shakespeare diventa espressione di un mondo in crisi che finisce per somigliarci molto. Possiamo infatti immaginare che greci e troiani appartengono non solo a due culture e società diverse ma anche a due epoche diverse, e fatalmente rivolte una contro l’altra. E’ questo tipo di scontro che cerchiamo di privilegiare nella nostra lettura. Per altro verso, l’affresco apocalittico e post-atomico di Bond ci pone di fronte ad un’umanità azzerata, in cui la guerra – portata alle estreme conseguenze e in qualche modo finale – è già avvenuta, e singoli individui sono lasciati soli di fronte a scelte morali radicali; il recupero della loro umanità sembra dipendere dalla loro capacità di farsene carico.
Il testo scritto da Giorgio Ruffolo è invece una sorta di storia universale dell’economia, suddiviso in tre nuclei principali: lo sfruttamento delle risorse naturali e la loro trasformazione in merce, l’invenzione della moneta, i rapporti tra economia e politica. Attraverso una scrittura vivace e ironica, l’autore traccia con formidabile spirito polemico una mappa dei meccanismi economici – e più recentemente finanziari – che guidano di fatto buona parte delle nostre scelte e del nostro vivere collettivo.
Sotto il nome de Il silenzio dei comunisti presenteremo un lavoro che nasce da uno scambio epistolare tra Vittorio Foa, Miriam Mafai e Alfredo Reichlin. Si tratta di una riflessione pacata, per molti versi appassionata, e sempre lucida di tre intellettuali che hanno segnato profondamente la vita politica “a sinistra” e il discorso pubblico nazionale, e che si interrogano – ciascuno a suo modo e usando toni assai personali – su ciò che è stato, o non è stato, sul proprio e sull’altrui impegno, sui mutati modi della politica, sul paese in generale dal secondo dopoguerra ad oggi.
Infine per quanto riguarda il lavoro sulla bioetica posso anticipare che si tratterà di un dizionario scritto da un folto numero di specialisti, ognuno dei quali è autore di uno o più lemmi. Il tema è importante tanto più se legato al titolo del progetto nel suo complesso, “Domani”. Non c’è dubbio che si tratti infatti di un territorio dove più acuta è avvertita la frizione tra l’entusiasmo dovuto al passo accelerato della ricerca e il bisogno di rinegoziare di conseguenza i termini morali sociali e politici che regolano ciò che è lecito all’uomo e ciò che non lo è.
Questa serie di riflessioni naturalmente non pretende di essere una trattazione sistematica dei temi che ho indicato. Tuttavia mi piace immaginare che i cinque spettacoli possano liberamente parlarsi tra loro senza che ci sia necessariamente un artefice di questo dialogo. I legami tra politica economia e bioetica sono evidenti, così come sappiamo quanto conflitti passati presenti e probabilmente futuri siano legati a questioni ideologiche ed economiche. Le connessioni quindi stanno all’interno dei temi in sé più che all’interno dei singoli spettacoli, che invece sono in sé autonomi.
Più in generale, riflettere sul futuro impone necessariamente la comprensione del passato. Se ciò è vero in linea generale, lo è ancora di più per il teatro dato che una delle sue prerogative è l’elaborazione del lutto e della perdita, quindi di ciò che è stato. Anzi arrivo a dire che per potersi occupare del “domani” a teatro è necessario compiere un doppio passo in avanti, sufficiente a superare l’orizzonte degli eventi che vogliamo considerare, e necessario per potersi voltare indietro a considerarli. Se così non fosse, faremmo solo della fantascienza.
Luca Ronconi
(testo raccolto da Giovanni Papotto, il 5 settembre 2005)
DOMANI
Produzione della Fondazione Teatro Stabile di Torino
Ideazione LUCA RONCONI E WALTER LE MOLI
Regia
LUCA RONCONI
Scenografie e responsabile degli allestimenti scenici TIZIANO SANTI
Costumi SILVIA AYMONINO, SIMONE VALSECCHI, GIANLUCA SBICCA
Luci GUIDO LEVI
Suono HUBERT WESTKEMPER
Training e Movimento MARIA CONSAGRA
Responsabili di regia CLAUDIO LONGHI, GIOVANNI PAPOTTO, MARCO RAMPOLDI,
CARMELO RIFICI, PAOLA ROTA, DANIELE SALVO
Coordinamento generale MAURO AVOGADRO
con
MASSIMO POPOLIZIO, LUIGI LO CASCIO
RICCARDO BINI, GIOVANNI CRIPPA, IAIA FORTE, MARIA PAIATO, TOMMASO RAGNO,
FAUSTO RUSSO ALESI, ELIA SCHILTON
e con
STEFANO ALESSANDRONI, ALICE BACHI, VALENTINA BARTOLO, GIOVANNI BATTAGLIA, ANTONIO BERTUSI, RAFFAELLA BOSCOLO, FIORENZA BROGI, ANDREA CAPALDI, FRANCESCA CIOCCHETTI, ENZO CURCURÙ, PAOLA D’ARIENZO, PAOLA DE CRESCENZO, PASQUALE DI FILIPPO, RAFFAELE ESPOSITO, ANGELO FERRO, GIANLUCA GAMBINO, CRISTIAN MARIA GIAMMARINI, MELANIA GIGLIO, GIORGIO GINEX, LINO GUANCIALE, DIANA HÖBEL, LORENZO IACONA, SILVIA IANNAZZO, EDOARDO LA SCALA, PIA LANCIOTTI, ROBERTO LAURERI, ALESSANDRO LOI, MARCO MACCIERI, BOB MARCHESE, MONICA MIGNOLLI, LAURA NARDI, GIACINTO PALMARINI, PAOLO PAOLINI, FRANCO PASSATORE, FRANCA PENONE, UMBERTO PETRANCA, IRENE PETRIS, CLAUDIO PUGLISI, FRANCESCO ROSSINI, MASSIMILIANO SBARSI, FRANCESCO SCIANNA, DAVID SEF, ANDREA SIMONETTI, MASSIMILIANO SOZZI, MARCO TOLONI, SIMONE TONI, NANNI TORMEN, ALFONSO VENEROSO, MARCO VERGANI,
FRANCESCO VITALE, DEBORA ZUIN.
GLI SPETTACOLI
TROILO E CRESSIDA
di William Shakespeare
2 febbraio – 10 marzo 2006 – PRIMA NAZIONALE
Lumiq Studios
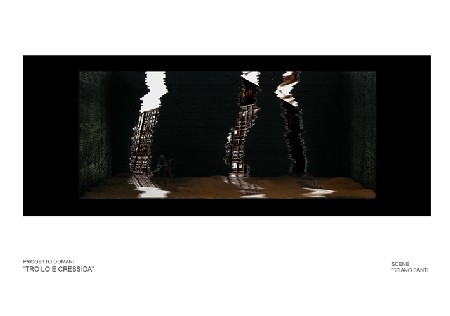
Il bozzetto della scena di Troilo e Cressida.
Regia
Luca Ronconi
con
Riccardo Bini, Giovanni Crippa, Iaia Forte, Giacinto Palmarini, Tommaso Ragno

Riccardo Bini e Irene Petris durante le prove di Troilo e Cressida (foto Edoardo Sismondi).
e con
Stefano Alessandroni, Antonio Bertusi, Andrea Capaldi, Francesca Ciocchetti, Enzo Curcurù,
Paola De Crescenzo, Raffaele Esposito, Angelo Ferro, Gianluca Gambino, Edoardo La Scala, Roberto Laureri, Marco Maccieri, Paolo Paolini, Umberto Petranca, Irene Petris, Claudio Puglisi, Francesco Scianna, David Sef, Andrea Simonetti, Massimiliano Sozzi, Simone Toni, Marco Vergani
…
ATTI DI GUERRA: UNA TRILOGIA
di Edward Bond
3 febbraio – 12 marzo 2006 – PRIMA NAZIONALE
Teatro Astra
Regia
Luca Ronconi
con
Massimo Popolizio
e
Raffaella Boscolo, Melania Giglio, Pia Lanciotti, Laura Nardi, Franca Penone, Elia Schilton, Debora Zuin
e con
Giovanni Battaglia, Paola D’Arienzo, Cristian Maria Giammarini, Giorgio Ginex, Lino Guanciale, Diana Höbel, Lorenzo Iacona, Alessandro Loi, Monica Mignolli, Umberto Petranca, Francesco Rossini, Marco Toloni, Nanni Tormen, Alfonso Veneroso, Francesco Vitale
…
IL SILENZIO DEI COMUNISTI
di Vittorio Foa, Miriam Mafai, Alfredo Reichlin
5 febbraio – 12 marzo 2006 – PRIMA ASSOLUTA
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri

Il bozzetto della scena del Silenzio dei comunisti.
Regia
Luca Ronconi
con
Luigi Lo Cascio, Maria Paiato, Fausto Russo Alesi
…
LO SPECCHIO DEL DIAVOLO
di Giorgio Ruffolo
6 febbraio – 11 marzo 2006 – PRIMA ASSOLUTA
Lumiq Studios
Consulenza scientifica Fondazione Sigma Tau

Il bozzetto della scena dello Specchio del diavolo.
Regia
Luca Ronconi
con
Giovanni Crippa, Iaia Forte,Tommaso Ragno, Elia Schilton

Le prove dello Specchio del diavolo (foto Edoardo Sismondi).
e con
Stefano Alessandroni, Alice Bachi, Valentina Bartolo, Fiorenza Brogi, Andrea Capaldi,
Francesca Ciocchetti, Enzo Curcurù, Paola D’Arienzo, Paola De Crescenzo, Pasquale Di Filippo,
Raffaele Esposito, Gianluca Gambino, Melania Giglio, Lorenzo Iacona, Silvia Iannazzo,
Edoardo La Scala, Roberto Laureri, Marco Maccieri, Bob Marchese, Monica Mignolli,
Giacinto Palmarini, Paolo Paolini, Franco Passatore, Franca Penone, Irene Petris, Claudio Puglisi, Massimiliano Sbarsi, Francesco Scianna, David Sef, Andrea Simonetti, Massimiliano Sozzi, Simone Toni, Nanni Tormen, Marco Vergani, Debora Zuin
…
BIBLIOETICA. DIZIONARIO PER L’USO
di Gilberto Corbellini, Pino Donghi, Armando Massarenti
14 febbraio – 10 marzo 2006 – PRIMA ASSOLUTA
Teatro Vittoria
Consulenza scientifica Fondazione Sigma Tau
Regia
Luca Ronconi, Claudio Longhi
con
Fiorenza Brogi, Bob Marchese, Franco Passatore
e con
Alice Bachi, Valentina Bartolo, Giovanni Battaglia, Pasquale Di Filippo,
Cristian Maria Giammarini, Giorgio Ginex, Lino Guanciale, Diana Höbel, Silvia Iannazzo, Alessandro Loi, Francesco Rossini, Massimiliano Sbarsi,
Marco Toloni, Alfonso Veneroso, Francesco Vitale
Buon compleanno, Samuel Beckett
1906BECKETT2006 & le manifestazioni per il centenario della nascita di Samuel Beckett
di Redazione ateatro
In occasione del centenario della nascita del drammaturgo irlandese Samuel Beckett (e mentre è ancora calda la querelle legale suscitata dalla rappresentazione "al femminile" di Aspettando Godot per la regia di Roberto Bacci-Pontedera Teatro), moltissime sono le iniziative editoriali e gli eventi pubblici. Segnaliamo in primis il primo e unico sito italiano dedicato interamente a Samuel Beckett, ideato e curato con grande perizia da Federico Platania, che accoglie oltre a un preziosissimo data base con numerosi saggi, bibliografia internazionale, biografia, una sezione dedicata alle segnalazioni per il centenario.
Tra gli eventi teatrali, 1906Beckettcentoanni2006, il primo Festival beckettiano italiano per il centenario organizzato da Giancarlo Cauteruccio per la Compagnia Kripton al Teatro-Studio di Scandicci (Firenze). La ricchissima manifestazione (che vedrà alternarsi in scena fino ad aprile le maggiori compagnie del teatro di ricerca italiano: Egumteatro, Motus, Roberto Paci Dalò e Gabriele Frasca, Virgilio Sieni, Enzo Moscato, Remondi e Caporossi, Carlo Cecchi) si è aperta il 13 gennaio con la prima nazionale del Trittico beckettiano per la regia di Giancarlo Cauteruccio (che si è più volte confrontato con i testi beckettiani): Atto senza parole I, Non io, L'ultimo nastro di Krapp", con Fulvio Cauteruccio, Monica Benvenuti, Giancarlo Cauteruccio.
La manifestazione prosegue con una rassegna di video/film beckettiani dal titolo La belva dello sguardo a cura di Riccione TTV e un convegno di studi presieduto da Siro Ferrone dell'Università di Firenze. Tra le compagnie che propongono nuovi studi teatrali in omaggio a Beckett, assolutamente da non perdere la video performance di Motus A play, that again liberamente ispirata a All strange away. Le celebrazioni termineranno il 13 aprile con Buon compleanno Beckett a cura del critico teatrale Franco Quadri.
.

L'evento editoriale che accompagna il centenario è invece il volume che la Halley Editrice pubblica in questi giorni (ma già da tempo è promosso on line) PlayBeckett - visioni multimediali nell'opera di Samuel Beckett, curato da Massimo Puliani e Alessandro Forlani, il primo Professore Ordinario di Istituzioni di Regia all'Accademia di Macerata (dove dirige il Dipartimento di Comunicazione Multimediale e Spettacolo) e il secondo docente a contratto di Metodologia della Sceneggiatura all'Accademia di Macerata e autore teatrale. Si tratta di una raccolta di importanti saggi sulla produzione filmica, video-televisiva e radiofonica "beckettiana" (scritti da studiosi di cinema e teatro: oltre ai curatori, Valentino Bellucci, Gualtiero De Santi, Danilo Caravà, Federico Platania) e sulle storiche regie teatrali beckettiane italiane (con interventi tra gli altri, di Federico Tiezzi, Gualtiero De Santi, Giancarlo Cauteruccio e Fabrizio Bartolucci). Massimo Puliani e Alessandro Forlani hanno anche aperto un proprio blog per promuovere il volume.

A Roma una festa per Pinter
In occasione dell'uscita di Harold Pinter. Scena e potere di Roberto Canziani e Gianfranco Capitta
di Garzanti Libri
Garzanti Libri e Università Roma Tre festeggiano il Premio Nobel per la
Letteratura a Harold Pinter in occasione della pubblicazione di
Harold Pinter. Scena e potere di Roberto Canziani e Gianfranco Capitta
Ne parlano gli autori con Maria Vittoria Tessitore (Università Roma Tre).
il Centro Europeo Teatro e Carcere (CETEC) rappresenta Victoria Station
con la regia di Donatella Massimilla
Paolo Bonacelli interpreta alcuni brani dall’opera di Harold Pinter
per informazioni tel 06.57067761
lunedì 23 gennaio 2006, ore 19.00
Teatro Palladium Università Roma Tre, piazza Bartolomeo Romano 8, Roma
I libri di Harold Pinter su InternetBookshop

