Mitiche costellazioni tra etica ed estetica
Sul ciclo Il velo nero del Pastore di Romeo Castellucci
Che il mito sia connaturato al teatro è una considerazione che, probabilmente, può essere fatta per qualsiasi forma di espressione scenica, dalle origini ai giorni nostri, indipendentemente dall’appartenenza culturale, dai generi, dagli stili, dagli esiti più o meno riusciti, più o meno efficaci. Il fatto che questo rapporto sia stato spesso misconosciuto, dipende dall’eclissi a cui il mito è stato destinato nella civiltà occidentale, sovrascritto da una logica logocentrica e monoteistica. Allora la presenza del mito a teatro si è voluta rinvenire troppo spesso esclusivamente quando a essere portata in scena era una particolare trama, una fabula, una vicenda fittizia che poteva essere ricondotta, nelle sue innumerevoli varianti, a un’antichità più o meno classica, senza accorgersi invece che quello che era riconosciuto come mito era il più delle volte la sua allegoria, la sua letteralizzazione, la sua rigida cristallizzazione nell’univocità codificata di un segno. Si è dimenticato del mito il portato fantasmatico, la matrice immaginale che fa propriamente dei miti degli ‘universali fantastici’, per usare un’espressione vichiana, di cui l’uomo non dispone ma da cui è disposto, che l’uomo non può abitare con la pretesa di averne il controllo ma da cui piuttosto è abitato.
Nel teatro questi universali fantastici, come ‘modelli di comportamento’ – per usare una delle definizioni con cui Jung ha chiarificato il significato del concetto degli archetipi – o come formule del pathos – per usare un termine coniato da Warburg per indicare il legame complementare tra emozione e immagine – vengono agiti attraverso le dramatis personae. Concretati nella singolarità e particolarità di quanto è portato sulla scena, svelano quel nesso tra particolare e universale, tra individuo e collettività tanto determinante per la definizione di identità. Questione cruciale per la cultura occidentale – per ciascun singolo individuo iscritto nella collettività – e evidentemente più di pertinenza del mythos che del discorso del logos che se ne è appropriato, forse indebitamente, agli albori della nostra civiltà. Ma con la potenza immaginale del mito la cultura contemporanea deve necessariamente fare i conti, ora che l’occidente, questa terra della sera, deve più che mai confrontarsi col suo umbratile destino crepuscolare.
Chi oggi dall’Italia ha la capacità di riportarci all’essenza radicale del rapporto inscindibile tra mito e teatro e svelarla è la Socìetas Raffaello Sanzio, impegnata su questo fronte sin dall’inizio – dagli anni Ottanta del Novecento – della produzione artistica. Di recente, uno dei suoi fondatori, Romeo Castellucci, in un percorso più autonomo rispetto all’attività della compagnia, si è confrontato in special modo con un mito fondante della cultura occidentale, quello cristiano, e, al momento, lo ha fatto in particolare attraverso tre messe in scena: nel 2010 con Sul concetto di volto nel Figlio di Dio, nel 2011 con Il velo nero del Pastore, e infine nel 2012 The Four Seasons Restaurant, di cui lo spettatore italiano ha memoria più recente poiché portato in scena nella edizione dell’autunno 2013 del Roma Europa Festival. Queste tre opere compongono un ciclo e sono interconnesse in modo da sembrare legate in un rapporto genealogico. Come nella filiazione, nella trasmissione genetica da un individuo a un altro, elementi presenti in un’opera si ritrovano in un’altra, incastonati in un contesto differente, ma indicativi nella riproposizione della loro identità. Sono nuclei di senso mediati da immagini che permettono allo spettatore di costruire associazioni, tracciare fili connettivi e costellazioni di significato. Castellucci parla spesso di “nodi”, e di “costellazioni” che si tratta di “comporre” di “disegnare” tra questi “nodi forti”; allora lo spettacolo è proprio “la costellazione tra questi punti/nodi”. E il materiale che viene imbastito per la creazione dello spettacolo sono le immagini, e le immagini sono la materia del mito, la sua matrice, il suo linguaggio: Castellucci dichiara costantemente la sua impotenza di fronte a esse, la sua dimensione di ascolto e accoglienza, e ne riconosce quindi la forza autonoma, la potenza. All’artista ne è concesso l’uso, l’artista ha la grazia di metterle in relazione, di creare associazioni, di operare un montaggio per creare un mosaico da destinare allo spettatore. Il montaggio, dichiara Castellucci, “è un sistema perfettamente retorico: data una serie di elementi, si crea una specie di chimera che deve aggredire o invadere lo spettatore” (Intorno al laboratorio: Prima dopo, dopo e oltre. Intervista a Romeo Castellucci a cura di R. Ferraresi).
La costellazione è una chimera, un mostro che, come insegna Giordano Bruno, ricomposto come astro in cielo guida lo sguardo alla decifrazione, alla ricomposizione del caos d’immagini da cui lo spettatore viene investito. E il montaggio è propriamente il dispositivo compositivo con cui si struttura il mito (vedi Daniela Sacco, Mito e teatro. Il principio drammaturgico del montaggio, Mimesis 2013), che articola le sue particelle elementari – le immagini – secondo una dialettica associativa di giustapposizione, sempre irrisolta in una rete di molteplici legami non univoci, di contro al pensiero logico che opera con i concetti creando astrazioni, ossia sussunzioni del molteplice sensibile in una unità di segno, dove il rapporto tra oggetto e significato è univoco. La potenza dell’espressione mitica su quella logica consiste proprio per la sua prossimità all’emozione e al pathos nella capacità di essere antinomica, di contenere contemporaneamente gli opposti, i contrari, e questo aspetto la lega inscindibilmente alla tragedia; diversamente dall’univocità del segno logico che nega la contraddizione, la polarità per ammettere uno solo dei due poli.
Nella realtà sensibile della scena le connessioni avvengono tra gli elementi portati dalla responsabilità dell’artista e le connessioni che lo spettatore è in grado di recepire nell’osservazione dell’insieme. In questa trasmissione di immagini, di dialogo tra le intenzioni dell’artista e le risposte di chi assiste, si realizza quella congiuntura tra universale e particolare che il mito incarnato nell’arte ha il pregio di veicolare. Sembra quasi che la composizione per immagini abbia raggiunto nel lavoro più maturo di Castellucci l’intento con cui era stata ideata, precedentemente in seno alla Socìetas, la Generalissima, la lingua universale di simboli, e quindi con le immagini, e i simboli che esse veicolano, si arrivi a “una versione figurale della Generalissima” (Oliviero Ponte di Pino, Romeo Castellucci & Socìetas Raffaello Sanzio, Doppiozero/ateatro, 2013, p. 86), capace, come nella funzione del mito, di dire gli universali.
Allora, a partire da questo rimbalzo di associazioni che mettono in dialogo le intenzioni dichiarate dell’artista con l’immaginario dello spettatore, al di là dell’impatto emotivo a cui si è esposti e che in verità potrebbe esaurire la fruizione dell’opera d’arte, si può azzardare una interpretazione, facendo tesoro delle molte recensioni degli spettacoli per ricostruirne i momenti che ne frattempo la memoria ha rielaborato. Si può tentare quindi una lettura per certi versi simbolica di una possibile costellazione collegando alcune delle immagini e dei quadri colti trasversalmente tra queste tre opere che compongono il ciclo proposto da Castellucci.
In scena, a cominciare da Sul concetto di volto nel Figlio di Dio, c’è un mito fondante della cultura occidentale, o meglio il mito che ha avuto la pretesa, storicamente, di essere l’unico e c’è la sua profonda messa in crisi. La questione del valore attuale del Dio della cristianità, in un’epoca post-cristiana, dopo che Nietzsche ne ha da tempo decretato la morte, si pone nella questione della sua permanenza come immagine divina nell’uomo, come rappresentazione antropomorfica della divinità nella psiche umana, e quindi nella figura della sua incarnazione, nella immagine del figlio, di Cristo. La sua immagine infatti domina la scena, nelle fattezze del Cristo benedicente di Antonello da Messina, scelto dal regista per la peculiarità dello sguardo diretto, rivolto dritto negli occhi dello spettatore. Uno sguardo volto quasi a interrogarlo, a pretendere una risposta o a inchiodarlo a una domanda che sembra da subito aleggiare come non detto sulla scena per poi esplicitarsi alla fine dello spettacolo nell’espressione che compare sovrimpressa sulla stessa tela: “I’m (not) your shepherd”, dove la negazione che appare e scompare intende porre l’attrito della contraddizione insanabile. Il dubbio è: “Sei o non sei il mio Pastore?”, con esplicito riferimento al celebre verso del salmo 23, e potrebbe essere allo stesso modo ulteriormente esplicitato: “Sei ancora il mio mito?”. Oppure, prendendo a prestito una domanda che Jung ha posto nel cuore della sua riflessione psicologica sulla religione: “Qual è il mito nel quale gli uomini vivono oggi?”. A provocare la domanda, a istillare il dubbio è un altro quadro che si frappone al dialogo di sguardi tra Cristo e gli spettatori e crea contrasto, turba profondamente la visione incontaminata di un volto così nitido nella sua purezza: un figlio che accudisce amorevolmente un anziano padre umiliato nel tentativo di arginare un problema di incontinenza. L’immagine forte delle feci che aumentano in modo incontrollato e invadono imbrattando letteralmente il candido e asettico interno borghese ricostruito in scena colpisce i sensi, sia la vista che l’olfatto, e ha un impatto intenso sugli spettatori.
Chiamare in causa Jung in merito alla domanda su quale sia il mito nel quale gli uomini vivono oggi non è casuale. Nella sua autobiografia, lo psicoanalista rievoca una sua fantasia. Da ragazzo non era riuscito a trattenere un’immagine che imponendosi con forza un po’ alla volta aveva fatto alla fine irruzione prepotentemente alla sua coscienza facendo cadere ogni resistenza:
“Mi feci coraggio, come se avessi dovuto lanciarmi nelle fiamme dell’inferno, e lasciai che quel pensiero venisse. Vidi innanzi a me la cattedrale e il cielo azzurro, e Dio seduto sul suo trono d’oro, dominante il mondo, e sotto il trono un’enorme massa di sterco cadere sul tetto nuovo e scintillante e abbatterlo, facendo crollare in pezzi i muri della cattedrale.”
(C. G. Jung, Ricordi, sogni, riflessioni, a cura di A. Jaffé, Rizzoli 1998, p. 68)
L’effetto di questa visione, rielaborato poi in età adulta, fu fondamentale per la comprensione della religione, che era il suo pane quotidiano essendo figlio di un Pastore protestante. L’accostamento tra Dio e gli escrementi trasgredisce il dettato della Bibbia, i suoi comandamenti e la sua Chiesa, minando l’immagine di perfezione e di sommo bene che la cultura cristiana ha storicamente voluto attribuire al suo Dio. Espungendo dalla sua immagine ogni forma di negatività, la visione divina cristiana, ha inteso il male esclusivamente come privatio boni rispetto al summum bonum, destituendolo di ogni valore e demonizzandolo al punto da inventare la figura del Diavolo, che in una concezione monoteistica esiste solo per negazione. Ma il valore del male è intrinseco alla vita stessa, è parte integrante di essa; come le feci e il corpo ne sono la quintessenza e la rappresentano simbolicamente. E il teatro – che vive di corpi, di respiro e di sudore – non può che essere una spina al fianco di una concezione religiosa che vive nella sottrazione di tutto ciò, non può che essere letteralmente il suo contraltare. Nel Libro rosso Jung osserva che se Dio fosse assoluta bellezza e bontà non potrebbe racchiudere la pienezza della vita che è allo stesso tempo brutta e bella, cattiva e buona, ridicola e seria, umana e non umana (Il libro rosso, Bollati Boringhieri 2010, p. 244). Perciò, la risposta alla domanda su quale sia il suo mito è che non può essere quello cristiano, o per lo meno non esclusivamente quello. Il mito cristiano, che pecca di unilaterità, deve essere completato da tutto quello che storicamente ha rimosso.
L’immagine divina nell’uomo una volta relativizzata non può che ridimensionare anche quel compito che si è imposto nei secoli all’umanità come ‘modello di comportamento’ da imitare in modo imprescindibile, ossia l’imitatio Christi. Da qui la domanda rivolta al figlio di Dio che è stimolata dalla frase che appare nel finale: sei e non sei il mio Pastore? Castellucci dichiara di aver riflettuto anche sul Libro di Giobbe nella creazione dello spettacolo, e lo fa non perché intende dare delle chiavi di lettura ai suoi spettatori, ma costretto dalle feroci polemiche suscitate dallo spettacolo. Polemiche che, se da un lato fanno temere di tornare indietro nel tempo, direttamente al concilio di Nicea e alla prima condanna iconoclasta dell’immagine di Cristo, dall’altro sono indicative della potenza e complessità che certe immagini hanno ancora a livello conscio e inconscio per una cultura apparentemente votata al laicismo; ma sono anche polemiche che – con buona pace di chi le ha subite – paradossalmente ogni forma di teatro dovrebbe invidiare, a riprova della capacità di toccare al cuore di questioni universali.
Quella sorta di dramma tragico, intessuto di prosa e di poesia, che è Libro di Giobbe e che, parte del Vecchio Testamento, è stato scritto prima della venuta di Cristo, pone in modo cruciale la questione della giustificazione del male inferto all’uomo e quindi della natura benigna o maligna di Dio-Yahwèh. Nulla giustifica la malvagità che il Dio, per quanto stuzzicato da Satana, infligge al giusto Giobbe, e che si confronta con la volontà negativa di chi lo ha creato assumendola fino alla fine senza opporre resistenza ma chiedendo inutilmente la spiegazione di essa. Inutilmente perché la spiegazione non arriverà quando Yahwèh si rivolgerà direttamente a Giobbe mostrando, nell’apoteosi della sua infinita potenza che può decidere anche di far cessare le sofferenze, come il male appartenga al disegno divino. Proprio Jung si cimenta nel tentativo di rispondere alla richiesta di spiegazione di Giobbe (cfr. la Risposta a Giobbe di Jung) in un frangente storico – siamo nel 1952 – che, dopo la tragedia delle guerre mondiali, non può più ammettere un Dio benevolo e onnipotente, e ne deduce che il divino non può essere quello che ci restituisce il cristianesimo strettamente evangelico ma il divino deve implicare l’antinomia, deve contenere la contraddizione del bene e del male. Un’immagine dello spettacolo mostra il ritratto di Cristo di Antonello da Messina che piange inchiostro nero di china: come dichiara Castellucci, è l’inchiostro delle Sacre Scritture, i fiumi di parole spesi per tratteggiare un’immagine del divino che storicamente si è allontanato dalla umana realtà.
E il confronto religioso con il Dio Padre attraverso la figura del Cristo si sdoppia e si riverbera in scena nell’interno borghese che ospita il vecchio accudito dal figlio. In ballo c’è un profondo confronto e scontro generazionale che attraversa il nostro tempo e che si acutizza a ogni passaggio epocale, con particolare urgenza in un frangente storico in cui il patriarcato sembra essere corroso se non dalle fondamenta almeno nelle sue propaggini. Questi passaggi epocali sono momenti di confronto cruciali in cui la possibilità di vita della generazione a venire dipende dalla relazione che riuscirà a instaurare con chi la precede; in cui il vicendevole riconoscimento dovrebbe garantire la differenziazione reciproca, con l’accoglimento dell’eredità dei padri e la trasformazione creativa di questa stessa eredità da parte dei figli. L’immagine del gruppo di bambini che entra in scena e lancia delle granate sulla tela raffigurante il volto di Cristo (una scena che Castellucci per esigenze logistiche dei teatri ospitanti non ha sempre usato nello spettacolo) suggella la necessità di un confronto foriero di vita o di morte, e dell’ambivalenza insita in questa relazione.
Il secondo anello del ciclo è rappresentato dal Velo nero del Pastore.E’ subito esplicita la fonte, una novella dello scrittore statunitense Nathaniel Hawthorne, di cui è ripreso integralmente il titolo. Questa è per lo spettatore la principale chiave d’accesso alla visione dello spettacolo, ma cosa racconta la novella? Il protagonista del racconto di Hawthorne è il reverendo Hooper, che inquieta gli abitanti del paesino in cui presta il santo servizio coprendosi il volto con un velo nero, che sembra comporsi di “due falde di crespo che celavano completamente il volto tranne la bocca e il mento ma probabilmente non gli ostruivano la vista se non per mostrargli un aspetto più scuro di tutte le cose viventi e inanimate”. La visione del volto coperto del reverendo, che si mostra così non solo durante le consuete prediche ma anche nella quotidianità della vita in paese, destabilizza profondamente coloro che si imbattono in lui, anche perché non sono in grado di spiegare la ragione del suo gesto. Sono terrorizzati dall’effetto mortifero che evoca il volto coperto dal velo nero e dall’effetto altrettanto spaventevole che provoca sulla voce malinconica del reverendo, che peraltro non dice nulla di terribile. Dettagli dell’effetto mortifero del velo nero sono sparsi in tutta la novella, dal brivido che percorre una salma a cui il reverendo dà l’estrema unzione al vino che, invece di essere bevuto in un rito per la consacrazione di un matrimonio, rovescia a terra turbato dopo aver scorto accidentalmente il suo stesso volto coperto dal velo riflesso nello specchio. Solo una persona – una donna che intende proporsi come sua sposa – riesce ad avvicinarlo e, unica nel paese a non farsi turbare dalla sua visione, osa chiedergli perché si nasconde dietro il velo. La perentoria risposta del reverendo Hooper, prima di trincerarsi nel silenzio, è che il velo “è un emblema, un simbolo” che deve portare “sempre alla luce e al buio, nella solitudine e davanti allo sguardo della moltitudine, di fronte agli estranei e agli amici più cari”, e che “nessuno sguardo di mortale lo vedrà mai sollevarsi” perché “quest’ombra cupa” deve, dice il Pastore, “separarmi dal mondo”. Il velo nero “deve stare sempre tra noi su questa terra”: con questa frase il reverendo Hooper causa l’allontanamento della donna dopo che per l’ultima volta lei gli ha chiesto di alzare il velo.
Con il velo nero posato sul volto l’uomo di Chiesa simbolizza la negazione del mondo, l’impossibilità a vederlo, o di vederlo solo nell’aspetto più cupo e mortifero. Si comprende a questo punto in che termini questo secondo capitolo del ciclo si congiunga al primo: la fede in quel Dio monoteista che ha escluso da sé il male, la morte, il corpo, le passioni, gli istinti, la materia, il femminile ha implicato la trascendenza rispetto al mondo, alla natura e quindi alla vita nella sua completezza, nella terribilità e nella bellezza, al di là del bene e del male. Il Pastore si nega la visione del mondo, che è ridotto a un deserto opaco, inanimato e mortifero. È la natura pagana e politeista nel suo traboccare di vita, e allo stesso tempo di morte – perché non si ha valore per la vita quando non lo si ha per la morte – che il monoteismo cristiano ha cancellato dall’immaginario collettivo in nome di una vita scevra da ogni imperfezione, immortale e perciò concepibile solo in un al di là, in una realtà ultraterrena. Il divino nella concezione pagana è inteso come parte integrante del mondo, la bellezza è quindi restituita al mondo che è animato e si offre a un’esperienza estetica. Un principio fondamentale della poetica della Socìetas, che Castellucci esplicita in Epopea della polvere (Cfr. “Etica ed Estetica”, una lettera di Romeo Castellucci a Frie Leysen, pp. 306-308, in Epopea della polvere, Ubulibri, 2001), è l’inammissibità di un’etica senza bellezza. Ma le tenebre calate sul mondo dal velo nero del Pastore parlano proprio di un’etica senza bellezza. Forse è questo l’unico vero peccato di cui dovrebbero sospettare i paesani per spiegare l’atto del reverendo Hooper.
Le immagini che si susseguono durante lo spettacolo possono rimandare a questo orizzonte di consapevolezza, e anzitutto al mistero dell’origine del mondo: più che una creazione ex nihilo, dall’immagine dell’enorme turbine che campeggia nella prima scena, sembra un nucleo da cui scaturiscono nel caos gli elementi, che potrebbero essere aria, acqua, terra, fuoco, come nelle teorie dei primi filosofi della natura. A suggellare la negazione del mondo nella sua bellezza e terribilità è un sipario che, come un enorme velo nero, avanza e retrocede, svelando sotto le sue pesanti coltri quelle che per effetto della negazione della vista sono vittime e sembrano giacere sul palco come macerie: un cavallo imbalsamato, il corpo di una donna, dei topini chiusi come cavie in una gabbia. La presenza di uno specchio nero maneggiato da una figura femminile ribadisce il concetto: l’impossibilità di specchiarsi nel mondo si accompagna alla non conoscibilità di esso ma anche alla non conoscibilità di sé. La natura spogliata della sua bellezza è materia inerte a disposizione della scienza: suggerisce l’associazione anche la scritta che campeggia sull’arco scenico:
“Eukaryota Animalia Vertebrata Tetrapoda Mammalia”.
Sono i termini scientifici che classificano e studiano quello che prima di essere considerato vita è un organismo che l’uomo osserva al microscopio. Perché la concezione religiosa che ha sostenuto la negazione del mondo, la sua invisibilità, è la stessa che ha permesso il vertiginoso sviluppo della scienza. L’approccio scientifico al mondo è insensibile, anestetizzato, si rivolge a una realtà che è oggettivata nella misura in cui è resa manipolabile da un soggetto. Questo è l’effetto più peccaminoso del positivismo delle scienze moderne.
Sono due le immagini che, in chiusura di spettacolo, si imprimono alla vista. Nella prima una grande locomotiva entra in palcoscenico, quasi a evocare la scena del film dei fratelli Lumière diventata leggendaria. L’immagine è il segno di un momento epocale: un’invenzione tecnologica che ha inaugurato il Novecento cambiando il mondo, e che attraverso il cinema forse ci ha restituito le immagini animate che l’uomo aveva perso nel mondo. Nella seconda, una fila di lampadine accese che vengono progressivamente falciate dall’azionarsi di eliche meccaniche, forse a significare il frantumarsi dell’età dei lumi ad opera di una nuova forza tecnologica.
Nel titolo della terza opera del ciclo, The Four Seasons Restaurant, è racchiuso un monito che sembra volere subito mettere in guardia lo spettatore sulle precauzioni da prendere durante l’uso, per l’assunzione delle immagini. Il riferimento ai lussuosi hotel nasce dall’episodio che ha visto Mark Rothko rifiutare l’esposizione di una delle sue opere nel Four Seasons di Manhattan. Le immagini dell’artista non devono confondersi con quelle da cui, quotidianamente, in ogni luogo, siamo subissati. E tuttavia, se quelle immagini sono il veleno e la superficie da evitare, tutto il lavoro di Castellucci è, come si è già detto, da sempre fondato sull’uso delle immagini, che sono il rimedio, il pharmakon attraverso cui mettere profondamente in discussione e magari contribuire a curare la cultura occidentale. Ma se questo episodio ha ispirato il titolo, il testo che ha ispirato la messinscena è La morte di Empedocle, la tragedia incompiuta di Hölderlin. Un testo fortemente presente in scena, anche in modo didascalico perché, oltre a essere proiettato nella versione originale in tedesco sulla parete di fondo, è anche recitato in nella traduzione italiana da un gruppo di donne che, raccolte in una palestra, ne fanno quasi un esercizio ginnico, una disciplina a cui dedicarsi come impegno etico ed estetico.
La prima scena si apre con un’immagine fatta di suono, che riprende quella dell’enorme turbine presente nello spettacolo precedente: è un forte boato che sembra richiamare il tornado caotico del mistero della creazione del mondo, ed è evidentemente uno dei principali fili conduttori che attraversano il ciclo. Un’altra immagine che torna dal Velo nero del Pastore è il sipario che avanza e indietreggia facendo scorgere il corpo di un cavallo morto, ribadendo così la questione della visibilità e invisibilità del mondo, e della responsabilità della cultura profondamente cristiana sulla valorizzazione della bellezza del mondo. E’ il nucleo della questione posta dal testo di Hölderlin, uno degli autori che, in piena temperie romantica, ha colto la necessità vitale per la cultura occidentale di riscoprire le origini greche e con esse una visione pagana e politeista, e perciò poetica, del mondo, per correggere l’unilaterità della visione cristiana. La grandezza di Hölderlin, come d’altronde quella di Nietzsche, è stata proprio l’aver compreso la fine della cultura occidentale attanagliata dal pensiero metafisico, nel senso filosofico ma anche religioso, e di aver intravisto e anelato la possibilità di una nuova aurora. Così in una concezione panteistica della vita, il mito è il nuovo logos della ragione, un logos che si fa poesia e permette quella connessione tra umano, mondano e divino che la troppa perfezione del Dio monoteista cristiano aveva interrotto. La poesia porta con sé la cifra della bellezza e con essa il tragico, perché la bellezza, come recita l’Iperione, è armonia entro la discordia, è sempre contrappunto, compresenza di bene e male. Questa consapevolezza introdotta nell’Iperione è compiutamente espressa ne La morte di Empedocle, dove il filosofo vive profondamente nel dissidio tra il desiderio di un cosmo rivalutato nella bellezza della sua natura e la realtà di quello che è costretto ad abitare. Infatti il suo destino di eroe tragico sarà suggellato dalla morte, un folle volo nel cratere dell’Etna quasi a ricongiungersi nell’elemento del fuoco con la natura. Nell’antinomia della dimensione tragica di Hölderlin, la figura di Cristo, pur contrapposta alle immagini degli dei pagani, non è mai tolta; e ne comprende la destinazione liminare: Cristo, per il poeta “viene quando il giorno del mondo volge al termine e ‘si fa sera’” (Cfr. Guardini, Hölderlin: immagine del mondo e religiosità, Morcelliana, Brescia 1995, p. 719). Questo può essere riconosciuto anche nel lavoro di Castellucci che ha inizio proprio con l’immagine di Cristo: non ci si può sbarazzare di più di duemila anni di storia, e tanto meno invocare per rovescio una nuova unilaterità… la sua immagine fa parte del nostro DNA culturale, come tra l’altro per quanto negati, trasfigurati e irriconoscibili nelle molteplici trasformazioni, lo fanno gli dei pagani. Anzi, oggi che per certi versi un volgare paganesimo di superficie sembra de rigueur, come quello che infesta gli hotel di lusso come il Four Seasons, trovare un contrappunto a questa superficialità per riscoprire la profondità delle immagini che danno sotterranea sostanza alla nostra vita è un compito auspicabile.
Ma c’è un altro elemento importante che, coerentemente con lo sviluppo del lavoro, sembra emergere nel lavoro di Castellucci e si colloca come ultimo tassello per completare l’opera: il femminile. Assente nel quadro patriarcale di Sul concetto di volto nel Figlio di Dio, si palesa a partire dalla seconda opera nella presenza in scena di un corpo di donna, che sembra patire come gli altri oggetti inanimati il passaggio del velo/sipario, e nella figura di donna che, nel racconto di Hawthorne, si propone in sposa al Pastore, ma, frustrata nel desiderio di togliergli il velo dal volto, lo abbandona. E infine, in The Four Seasons Restaurant, protagoniste sulla scena a declamare il testo di Hölderlin sono un gruppo di donne, donne forti: sono armate, portano il kalashnikov, e disciplinate nell’esercizio che compiono; ma sono al tempo stesso donne deboli: in un quadro, nell’uscire di scena, sembrano riprodurre iconograficamente la cacciata di Eva dal Paradiso terrestre. Sono donne che nell’esercizio di declamazione del testo si tagliano la lingua, il principale strumento del logos e lo danno in pasto a un cane; verrebbe da pensare: lo restituiscono alla radice bestiale della natura. Sono donne che, in una suggestiva immagine di parto, comunicano l’idea di essere capaci, da sole, tra di loro, come per partenogenesi, di ridarsi la vita. Un volto di donna compare al termine dello spettacolo, umbratile esce da una pioggia di cenere vulcanica, dalla morte di Empedocle, e sembra emergere da un nuovo Big Bang, inaugurando la creazione di un nuovo mondo. Sappiamo dal regista che è il volto di una prostituta di New Orleans, immortalato da Bellocq, fotografo statunitense di cui si conservano molti scatti di prostitute a cui è stato cancellato il volto. Una prima immagine che può evocare la conoscenza della identificazione di questo volto è la Morte della Vergine di Caravaggio: si narra che il pittore abbia usato come modello per ritrarre le fattezze della Madonna morta il corpo di una prostituta annegata nel Tevere. Una seconda immagine che evoca e in qualche modo chiude il cerchio, o uno dei cerchi con cui si è aperto il ciclo, è l’immagine di Cristo che dominava la scena nel primo spettacolo, andando via via a imbrattarsi e cancellarsi. Il femminile, evocato in tutte queste immagini, è propriamente l’elemento mancante alla totalità perfetta del Dio Padre monoteista cristiano, assieme alla materia, al corpo, al male, alle passioni. Jung interpreta la proclamazione papale del dogma dell’Assunzione di Maria Vergine nel 1950 come un importante segno della necessità epocale e psicologica di reintegrare nell’immagine del divino il femminile mediato dalle figure della Sophia-Dea-Madre-Amante-Maria. Il femminile incarnato nell’ultima immagine dello spettacolo è allora quanto, assieme alla bellezza, attende di essere restituito al mondo.
Tag: censura (33), filosofia (5), mitoeteatro (18), Societas Raffaello Sanzio (34)
1 Commentoa“Mitiche costellazioni tra etica ed estetica”
Scrivi un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.



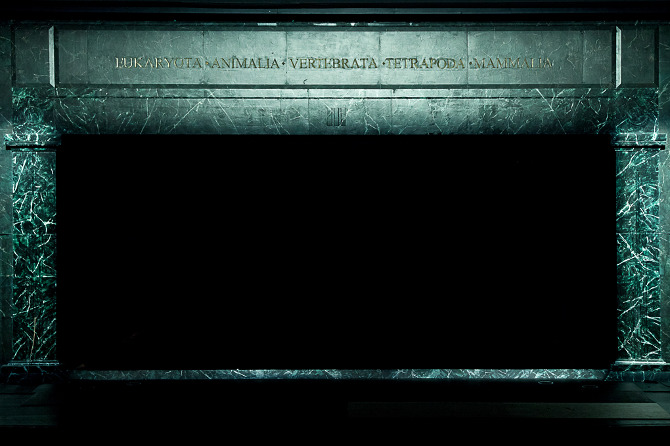





[…] Mitiche costellazioni tra etica ed estetica […]