I paradossi politici del teatro sociale e di comunità
L'intervento al convegno Performing the Social. Education, Care and Social Inclusion through Theatre, Università Cattolica, Milano, 20-21 settembre 2019
Abstract
Il teatro sociale e di comunità si nutre di un “paradosso fondativo”: la compresenza di due obiettivi, il benessere dei soggetti coinvolti (finalità sociale) e la qualità artistica dell’esito (finalità estetica). Ma questa dialettica deve tener conto di un terzo polo: il contesto sociale in cui si inserisce l’intervento e i suoi obiettivi politici e sociali, nel senso più ampio del termine.
Nella dinamica del lavoro, questa pluralità di livelli può generare ulteriori paradossi: a livello della comunità destinataria dell’intervento, al livello dell’istituzione che la ospita (e che è spesso anche il committente), al livello della ridefinizione delle identità individuali e collettive coinvolte, al livello delle professionalità interessate.
Una definizione
Per delimitare il campo, utilizziamo una delle possibili definizioni di teatro sociale e di comunità, quella di Alessandra Rossi Ghiglione, ripresa anche da ateatro: il TS&C è un insieme di pratiche
«con metodologie specifiche in cui équipe di professionisti esperti di teatro e di promozione del benessere delle persone operano con gruppi e comunità di cittadini – spesso svantaggiati – e realizzano percorsi teatrali, performance e progetti con finalità culturali, civili, artistiche e di benessere psicosociale».
I due paradossi fondamentali del teatro sociale e di comunità
Il teatro sociale e di comunità (TS&C) è sospeso tra due paradossi.
Il primo paradosso è che il TS&C ha l’obiettivo di diventare inutile e dunque tende ad autodistruggersi.
Il secondo paradosso è che non ci riesce.
Il primo paradosso, la tendenza all’autodistruzione o al superamento di sé, ritorna in diverse varianti. La prima potrebbe essere formulata così:
Se le pratiche di TS&C hanno successo, diventano inutili.
Gli interventi di TS&C vengono progettati e sostenuti in situazioni di difficoltà, per superare o aggirare uno “svantaggio”. E’ l’obiettivo dei committenti più ingenui:
Alcuni dei nostri utenti (carcerati, anziani, portatori di handicap, adolescenti turbolenti…) vivono una condizione di difficoltà, sono passivi o disfunzionali. Chiamiamo gli esperti del benessere psicosociale e risolveranno il problema!

Venezia, Carnevale (2020)
Simmetrica alla visione del committente che pensa di risolvere un problema con la tecnica, e ugualmente ingenua e semplicistica, c’è quella dell’operatore convinto che la bellezza possa salvare, se non il mondo, almeno l’angolo di inferno in cui si trova a operare.
In teoria, se l’intervento funziona e il disagio scompare, gli operatori diventano inutili e perdono il lavoro.
Se il progetto prosegue dopo aver raggiunto l’obiettivo, il TS&C rischia di ridursi a terapia di mantenimento, a sedativo artistico-culturale, ad attività ricreativa da affiancare al corso di yoga e al torneo di burraco.
Il benessere che diventa malessere
La conclusione di un intervento di TS&C, e la dissoluzione della sua fragile utopia, può avere effetti collaterali negativi, come ha notato Claudio Meldolesi:
Insorge sempre il problema dei problemi, a spettacolo finito: perché si tratta di tornare alla normalità, cosa ardua dopo ogni distacco dalla norma che farà sentire il prima più pesante, intollerabile, a meno che non si trovi per tempo un antidoto.
(Claudio Meldolesi, Immaginazione contro emarginazione. L’esperienza italiana del teatro in carcere, in “Teatro & Storia”, n. 16, 1994, p. 66)
Un nuovo paradosso: la produzione di benessere lascia una scia di malessere, una sensazione di mancanza, nostalgia, depressione, rabbia…
Il dilemma che devono affrontare gli operatori e i committenti ricorda quello esplorato da Sigmund Freud in Analisi terminabile e analisi interminabile ([1937], Bollati Boringhieri, Torino, 1977).
Fermo restando che “la fine dell’analisi è un problema che riguarda la prassi” (e dunque di fatto è destinata a terminare), Freud definisce la psicanalisi come uno degli “impossibili” (come educare e governare) “il cui esito insoddisfacente è scontato in anticipo”.
Una terapia che non cura

Non-Scuola @Olinda Romeo e Giulietta, ispirato a Romeo e Giulietta di William Shakespeare [ph. Luca Del Pia]
Tuttavia il TS&C non ha unicamente finalità terapeutiche e il percorso non è mai così lineare. Di qui un ulteriore paradosso, quello della sopravvivenza, che può essere declinato anche così:
Il TS&C è una terapia che non cura, ma evidenzia la malattia.
E’ una dinamica che gli operatori conoscono bene. Nel momento in cui gli utenti vengono “riattivati”, svelano anche le cause del loro disagio. La rottura dei blocchi interiori fa emergere gli impedimenti esteriori. L’atteggiamento terapeutico parte dal presupposto che la malattia sia un problema del paziente, e che forse sia addirittura una sua colpa. In realtà spesso i problemi degli “utenti” hanno le loro cause fuori dai pazienti, in tutto o in parte: nell’istituzione che li ospita (e che sostiene o consente l’intervento), nel corpo sociale nel suo insieme e nelle sue varie articolazioni.
Da questo punto di vista, l’intervento ha successo quando porta alla luce le cause profonde di un disagio che non poteva trovare espressione. L’intervento esterno avrebbe dovuto risolvere il problema e invece ne crea uno ancora maggiore. Dunque mette in crisi il contesto e ne richiede la trasformazione, più o meno radicale.
Se una pratica ha davvero successo, viene interrotta

Marco Cavallo esce dall’Ospedale Psichiatrico di Trieste e scende in città, 1973
Quando un’istituzione si sente messa in crisi, si aprono due strade. La più semplice consiste nell’eliminare il nuovo problema e chiudere il progetto, in una nuova formulazione del primo paradosso:
Se le pratiche di TS&C hanno successo perché sono radicali, destrabilizzano l’istituzione e dunque vengono interrotte”.
Il disagio muto degli utenti è preferibile al timore di una rivolta. O peggio del cambiamento.
Oppure può iniziare un processo di reale trasformazione. E’ il caso dell’intervento di Giuliano Scabia con Franco Basaglia all’Ospedale Psichiatrico di Trieste alla metà degli anni Settanta, nell’ambito di un processo che ha portato alla chiusura dei manicomi, o della trentennale permanenza della Compagnia della Fortezza a Volterra, che fino al 2013 ospitava, oltre che detenuti a media sicurezza, anche detenuti del circuito alta sicurezza, rivolto ai detenuti appartenenti alla criminalità organizzata. Dal mese di dicembre del 2013, consacrandone la vocazione trattamentale, l’istituto di Volterra è stato riconvertito in istituto destinato unicamente a detenuti media sicurezza, con migliori condizioni per i detenuti anche dal punto di vista regolamentare.
Estetica o politica?

Teatro Periferico, Mombello. Voci da dentro il manicomio
Si genera un altro paradosso: un intervento che avrebbe dovuto essere confinato all’interno di un laboratorio teatrale, e dunque nel luogo deputato della finzione, finisce per avere un impatto sulla realtà esterna. Oltre ai casi già citati, si può ricordare Mombello del Teatro Periferico, rievocazione della quotidianità in un ex ospedale psichiatrico ormai chiuso e abbandonato da tempo, costruito a partire da una serie di interviste con il personale, i ricoverati, i familiari: lo spettacolo ha ispirato il tour “Case Matte”, che ha toccato altri nove ex manicomi in tutta Italia, da Genova a Palermo, attivando un processo di consapevolezza e azioni sociali e politiche nei territori. Il gesto estetico, quando è davvero efficace, diventa azione politica: un’altra forma di autodistruzione.
Il ruolo ambiguo degli operatori

Cattività di Bruno Oliviero: Mimmo Sorrentino con le protagoniste del film
Altri paradossi nascono dal rapporto asimmetrico tra gli operatori e i destinatari dell’intervento. In genere gli utenti non hanno deciso (o richiesto) l’intervento. Gli operatori agiscono per conto della direzione. Anche se si trovano in una posizione ambigua rispetto all’istituzione. Ne fanno parte, perché è l’istituzione a legittimare il loro intervento. Al tempo stesso, devono far emergere la soggettività degli utenti, interpretando i loro bisogni.
Gli operatori parlano a nome degli utenti? O sono gli utenti che parlano per conto degli operatori? Qual è la reale autonomia degli uni e degli altri?
E’ il paradosso del portavoce.
All’inizio del processo, il rapporto è asimmetrico. Gli operatori si sono dotati di competenze e tecniche specifiche, dispongono di notevoli strumenti culturali, hanno una diversa consapevolezza della struttura sociale. I rischi di strumentalizzazione e manipolazione sono evidenti. Anche qui si apre un varco per il paradosso dell’autodistruzione: almeno in teoria, gli utenti dovrebbero emanciparsi da questo inevitabile paternalismo e liberarsi degli operatori.
Nell’era dell’apparire, gli utenti che diventano protagonisti corrono il rischio del narcisismo e dell’esibizionismo. Un altro paradosso:
La prima forma di integrazione, la più spontanea, rischia di essere quella nella società dello spettacolo.
Tuttavia, come nota Claudio Meldolesi, nel caso del teatro-carcere
il recluso è normalmente stimolato a “ricollegarsi”; e se pure ne trarrà stimoli negativi – all’esibizionismo e alla falsificazione di sé – il lavoro in comune lo spingerà di volta in volta a porsi ulteriori mete (…) l’attore recluso ha bisogno di cura e di tempo per inventare: la sua invenzione deve essere globale, collettiva oltre che individuale, esistenziale oltre che di gusto, e psichica oltre che espressiva.
(Claudio Meldolesi, Immaginazione contro emarginazione. L’esperienza italiana del teatro in carcere, cit., p. 43)
Su un altro fronte, l’ambiguità della posizione degli operatori può creare difficoltà nel rapporto con chi lavora quotidianamente all’interno della struttura. Gli infermieri, gli insegnanti e le guardie carcerarie sono in prima linea, di fronte alle esigenze pratiche del lavoro. Ma sono anche i primi custodi della natura repressiva dell’istituzione, con le sue abitudini e le sue rigidità, spesso vissute senza consapevolezza e considerate naturali, necessarie. Anche il personale è oggetto di un intervento trasformativo che non ha richiesto, e vive questa intrusione in maniera più o meno consapevole, con maggiore o minore disponibilità. Il personale della struttura è al tempo stesso pedina dell’ingranaggio repressivo e del processo di emancipazione.
La deriva specialistica

Pinocchio nero, regia di Marco Baliani
Il TS&C lavora per la propria dissoluzione anche per un altro ordine di ragioni, collegate al suo successo, e dunque alla sua disseminazione nei contesti più diversi. La frammentazione del mondo del TS&C – e in prospettiva della sua frammentazione in microsettori – è una conseguenza del primato della tecnica e dell’ipostatizzazione delle differenze ed è in linea con la tendenza alla specializzazione sia dell’accademia sia della società in generale. Negli ultimi anni, gli ambiti di intervento si sono moltiplicati: un sommario elenco comprende scuole, ospedali e affini, case di riposo per anziani, carceri, quartieri e territori disagiati, intercultura, zone di conflitto, disoccupati, donne maltrattate, adolescenti in difficoltà, ex tossicodipendenti, ambiente e natura… L’elenco rischia di allungarsi all’infinito. Ciascuno di questi ambiti ha caratteristiche e necessità specifiche, e dunque tecniche dedicate. Come ha notato Fabrizio Fiaschini,
Per stimolare, in questi settori, meccanismi di domanda/offerta (e quindi pratiche formative) sempre più evolutivi e dinamici, diventa infatti necessario differenziare il più possibile i bisogni, inventandone costantemente di nuovi, oppure, ancor peggio, suddividendo e sezionando quelli che già esistono in categorie apparentemente distinte e autonome, con nomi e caratteristiche proprie, in modo tale da gonfiare e drogare la domanda e creare così i presupposti per la proliferazione di altrettante presunte metodologie formative, da lanciare sul mercato come innovative e specialistiche (e pertanto esclusive) per ciascuno dei settori individuati. (….) La divisione forzata degli ambiti e delle metodologie formative, rischia di creare, pur in assenza di un reale bisogno di specializzazioni, nicchie sempre più pseudo-specialistiche di operatori che operano rigorosamente solo su singoli contesti, in modo del tutto autoreferenziale, perdendo così di vista sia la dimensione complessiva del disagio e dei veri bisogni, sia l’orizzonte del bene comune.
(Fabrizio Fiaschini, Una formazione non selettiva ma inclusiva, intervento alle #BP2016 | Teatro Sociale e di Comunità: la formazione degli operatori. Scuole e idee a confronto, 5 novembre 2016, Civica Scuola di Teatro “Paolo Grassi”)
Le implicazioni sui processi di formazione di chi vuole operare in questo ambito sono immediate. Generalmente le prime generazioni di operatori di TS&C, formatisi in ambito teatrale, hanno costruito la loro competenza attraverso percorsi di autoformazione, legati a contesti specifici. Ma come trasmettere queste esperienze e queste competenze? Come mantenere il collegamento con il teatro, che ha originato questi processi, se prevalgono le competenze terapeutiche e sociologiche? (Vedi l’incontro “Spunti e riflessioni intorno all’arte partecipativa”, a cura della Associazione Culturale Ateatro, 22 novembre 2017, Casa dei Diritti, Milano, e i relativi materiali pubblicati sul sito ateatro.it)
Dalla diversità all’omologazione

Pippo Delbono, La gioia: l’ultimo spettacolo di Bobò
Un’altra spinta verso la dissoluzione del TS&C discende dalla funzione sociale dello spettacolo. Il teatro, lo sappiamo, è un formidabile strumento di consapevolezza individuale e di gruppo. Nei laboratori, utilizzando le tecniche messe a punto dal nuovo teatro, alcuni “portatori di differenza” prendono coscienza di condividere una condizione di disagio. Nel momento in cui entrano in scena, questi “non attori” salgono con i loro corpi nello spazio pubblico della polis e prendono la parola, questa differenza diventa un elemento politico. La loro diversità chiede di essere riconosciuta e accettata come parte del corpo sociale, all’interno della dialettica che muove la dinamica della politica. Di qui nasce l’ennesima variante del primo paradosso, nella forma del “Paradosso della diversità e dell’omologazione”: “Le pratiche di TS&C lavorano con i ‘diversi’. Se hanno successo, portano alla cancellazione della diversità e all’omologazione, come condizione per l’integrazione”. I diversi diventano uguali.
E’ lo stesso nodo che investe, su scala globale, il rapporto tra le diverse culture.
Il percorso verso l’integrazione e l’emancipazione porta inevitabilmente all’assimilazione? Entrare nel mainstream, significa rinunciare alla propria identità, alle proprie specificità? Diventare un microtarget per il marketing?
Il neocapitalismo è in grado di assorbire qualunque diversità riducendola a target e omologandola nell’universo del consumo. Il modello è quello dei ristoranti etnici che si sono moltiplicati nelle metropoli e nei piccoli centri, o quella della world music, che ha ricompreso e annacquato le diverse tradizioni locali in una koiné globale in salsa rock-jazz. In questo scenario, possono innestarsi derive identitarie anche radicali, che tuttavia si nutrono di una filologia ormai impraticabile, perché anch’essa frutto della modernità: la purezza delle tradizioni è mistificatoria tanto quanto gli adattamenti consumistici interculturali.
Dilettanti o professionisti?

Personaggi di Antonio Viganò e Julie Stanzak (foto Patrizia-Chiatti)
Simmetrica a questa tendenza, emerge un’ulteriore trappola autodistruttiva, che nasce dal coinvolgimento di attori (e artisti) non professionisti. Con la loro evidente “diversità”, creano sulla scena un potente “effetto di realtà”. Con il tempo affinano le doti attoriali. Nel momento in cui la compagnia, o alcuni suoi membri, raggiungono un elevato livello artistico, con i conseguenti riscontri di pubblico, i membri della compagnia iniziano a essere (giustamente) retribuiti per la loro attività. A quel punto smettono di essere “non attori”: fuoriescono dalla galassia del TS&C per entrare in quella del teatro professionale tout court. E’ la strada intrapresa dal Teatro La Ribalta di Antonio Viganò, la prima compagnia italiana con attori disabili scritturati come professionisti, sulla scia dei francesi dello Oiseau-Mouche. E’ anche il fondamento di alcune prese di posizione polemiche di Armando Punzo o di Pippo Delbono, che rifiutano con vigore (e giustamente) l’etichetta di TS&C.
Il paradosso di Pinocchio

Mercuzio non deve morire, Armando Punzo e Aniello Arena
Questa versione del paradosso dell’autodistruzione può generare un ulteriore paradosso autodistruttivo, il “paradosso di Pinocchio”, il burattino che diventa bambino, ma viene ricacciato nella sua vecchia condizione. L’attore del TS&C è diventato un professionista, ma il sistema dello spettacolo continua a identificarlo con la sua maschera sociale e dunque lo scrittura per quella maschera (o per quella che era la sua maschera). Anche su questo fronte è sintomatica la posizione di Armando Punzo: fare teatro (e a maggior ragione fate teatro in carcere) significa portare l’attore fuori dalla propria condizione, per proiettarlo in altre dimensioni. Ma se un regista chiede a un condannato per fatti di camorra di fare il camorrista in Gomorra, lo ri-inchioda alla sua condizione di detenuto e alla situazione sociale che ne ha fatto un criminale:
Rifiutarsi di rappresentare significa dire che una persona può essere completamene altro da ciò che è, andare oltre. L’attore che rinuncia alla fiction che ripete la vita prefigura una possibilità, la anticipa, grazie a un linguaggio e a una pratica che lo facilita.
(Armando Punzo, Un’idea più grande di me. Conversazioni con Rossella Menna, Luca Sossella, Roma, 2019, pp. 334-335)
Pinocchio non vorrebbe tornare burattino, ma è l’unica cosa che gli chiedono di fare.
Il paradosso del mostro

Alessandro Garzella, Canto d’amore alla follia
Simmetricamente, una raffica di paradossi investe anche lo spettatore, sospeso tra la paura e la fascinazione del diverso. E’ il “paradosso del mostro”, che ci attrae e ci ripugna. Lo sguardo dei “normali” nei confronti dei “diversi” è spesso venato di paternalismo e di commiserazione: è uno sguardo colonizzatore.
S’insinua per di più il ricatto del politicamente corretto: come posso parlar male di chi è già in una condizione di debolezza, di discriminazione? Come posso giudicare dei non professionisti con gli stessi criteri con cui giudico le compagnie primarie? Lo sguardo diventa ancora più indulgente per gli spettatori sono prossimi agli “utenti”: i familiari, per esempio.
Non manca anche su questo versante un paradosso metodologico, che riguarda gli spettatori professionisti (organizzatori, critici, studiosi, storici). Nel caso del TS&C, per comprendere l’opera, ovvero la restituzione pubblica, è necessario conoscere il processo creativo: spesso il critico è embedded, con tutte le controindicazioni del caso. Se l’osservatore fa parte del progetto, e ne condivide gli obiettivi e i metodi, come può riuscire a giudicare oggettivamente l’opera?
Un gioco di sguardi reciproci

Thioro, regia di Alessandro Argnani
Un ultimo paradosso. L’intervento ha l’obiettivo di riattivare gli utenti e in subordine di trasformare l’istituzione che lo ospita. Ma i primi a cambiare, a essere trasformati, devono essere i responsabili che gestiscono la struttura e coloro che vi lavorano. Se questo non accade, se chi opera non è disposto a mettersi in discussione e mantiene una posizione di superiorità gerarchica, è chiaro che l’intervento risulta paternalistico o puramente ingegneristico. Deve scattare un incontro di sguardi reciproci, che mette in gioco una pulsione che è al cuore di ogni vocazione teatrale:
Nel caso del teatro, questa reciprocità degli sguardi è ancora più forte perché possiamo parlare di un doppio desiderio di alterità: la fascinazione dello spettatore, il suo desiderio di incontrare l’altro, l’attore, lo “straniero che danza”; e ancor prima, il desiderio dell’altro che spinge le persone a farsi attori.
(Marco De Marinis, Teatro dell’altro, cit., p. 12)
Il ruolo degli operatori non è neutro o innocente, né nei rapporti con gli utenti né nei rapporti con eventuali committenti.
Il triangolo

Babilonia Teatro, Pinocchio
Il teatro nasce nello spazio della polis dalla separazione e dalla dialettica (insomma, della differenza) tra due soggettività, quella degli attori che agiscono sulla scena e quella degli spettatori, in una condizione passiva. Nel TS&C lo scenario è più complesso, i soggetti sono più numerosi e le loro relazioni più complesse.
Ci sono gli “utenti”, ovvero i destinatari dell’intervento.
C’è l’istituzione che ospita il progetto. A volte lo può semplicemente “tollerare”, ma di solito lo ha richiesto, progettato e lo sostiene. A sua volta all’interno dell’istituzione lavorano sia i dirigenti che hanno deciso e pianificato l’intervento, sia il personale (agenti di custodia, inservienti…), che ha atteggiamenti, modalità operative e problematiche molto diverse.
Ci sono gli operatori, intrappolati nel triangolo composto dagli utenti, dai committenti e dagli operatori della struttura. Ad arricchire il quadro può esserci la collaborazione dei volontari che supportano in varie fasi l’azione degli operatori.
C’è il pubblico, anch’esso segmentato: ci sono gli osservatori “istituzionali” (coloro che operano all’interno della struttura a vari livelli), c’è la cerchia dei familiari e degli amici dei destinatari, c’è il pubblico generico fatto di persone interessate allo spettacolo. La scelta di restituire il lavoro anche a quest’ultima tipologia di spettatore cambia profondamente la natura dell’evento. Non coinvolge più, in una dimensione autoreferenziale, una comunità ristretta, ma si proietta in una dimensione sociale e civile.
E’ proprio in questo orizzonte che accade il teatro. Ma i lavori di TS&C inseriscono un ulteriore elemento di ambiguità e di consapevolezza: interrogano la struttura sociale e politica, o meglio, la mettono in scena e per farlo inevitabilmente la decostruiscono e la mettono in discussione.
Teoria e pratica del paradosso
Questo è il teatro, di fatto l’arte politica par excellence; solo in esso, nel corso così vivo della rappresentazione la sfera politica della vita umana può essere trasfigurata a livelli ulteriori, così da fondersi con l’arte. La recitazione è insomma la sola forma d’arte in cui l’oggetto viene trasportato nel mondo delle relazioni.
(Hannah Arendt, Vita Activa, p. 180)
I paradossi del TS&C nascono dalla sua natura complessa. I suoi obiettivi sono insieme estetici (la bellezza, la creazione poetica ma a partire dalla sofferenza, da una ferita), terapeutici (il benessere di un individuo “ferito”) e sociali (l’aspetto politico: i meccanismi che generano esclusione/rimozione e sofferenza, la creazione di una consapevolezza collettiva, il processo di integrazione/emancipazione). Investono tre diversi piani di intervento: il livello estetico guarda alla storia (e per i cultori dell’arte per l’arte all’eternità), quello terapeutico si concentra sull’individuo e sul suo benessere, quello sociale lavora a livello collettivo.
I paradossi che abbiamo elencato non sono riflessioni astratte, speculazioni filosofiche. Riflettono conflitti che emergono nella pratica di lavoro quotidiana e non possono essere risolti a priori, sulla base di considerazioni astratte, filosofiche, dividendo il mondo in buoni e cattivi, vittime e carnefici, oppressi e oppressori, per chiudersi nella logica del conflitto, semplicistuica e in fondo consolatoria.
Chi opera nell’ambito del TS&C deve conciliare queste tensioni divergenti, e sul lungo periodo forse incompatibili, con una serie di micro-decisioni che orientano la pratica, sulla base delle condizioni specifiche. Se non tiene conto di tutti questi piani, il progetto è destinato a fallire. Se l’equilibrio si rompe, inevitabilmente, il paradosso esplode e si può risolvere solo eliminando o trascurando uno o due obiettivi.
Ma come produrre allo stesso tempo benessere e pensiero critico, felicità individuale e conflitto, identità e integrazione? Il punto d’equilibrio non può essere dettato solo dall’estetica, solo dalla tecnica terapeutica, solo dalla politica. Può essere suggerito unicamente dall’etica, e soprattutto dall’etica del lavoro e dell’impegno quotidiano. Ma l’etica non può essere il coniglio che esce dal cappello del prestidigitatore intellettuale, lo schermo dietro al quale nascondere i problemi per affidarli alla decisione dell’artista, o alla sua volontà di potenza. E’ un esercizio costante, che si nutre appunto di paradossi e che deve puntualmente comprenderli e affrontarli ogni volta che affiorano. E accade spesso.
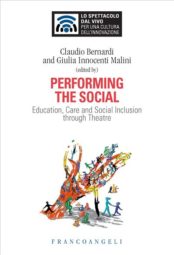
Quello pubblicato qui sopra è l’intervento di Oliviero Ponte di Pino al convegno Performing the Social. Education, Care and Social Inclusion through Theatre, Università Cattolica, Milano, 20-21 settembre 2019.
IL LINK
Teatro della persona, teatri delle persone. Una riflessione sul teatro sociale e di comunità
IL LIBRO
Performing the Social. Education, Care and Social Inclusion through Theatre, a cura di Claudio Bernardi e Giulia Innocenti Malini, Franco Angeli, 2021.
Tag: teatro sociale e di comunità (97)








