Spettacolo! Il Palcoscenico Elementare di Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa
In mostra a Torino dal 2 febbraio 2007
Questo testo verrà pubblicato nel catalogo di I Marcido in mostra: 1986-2006
Una sera di luglio al Festival di Santarcangelo. Sotto i portici di piazza Ganganelli mi viene incontro un ragazzo massiccio, un po tozzo, un lampo scuro negli occhi. Non lho mai visto, non si presenta, mi aggredisce: Sono sicuro che ti è piaciuto moltissimo!. Naturalmente gli rispondo di no. Se è tanto sicuro, che bisogno ha di chiedermelo? E poi quello è di sicuro un fanatico.
Lui resta lì impalato, continua a guardarmi, non so se è sorpreso o arrabbiato. Non dice più nulla e io riprendo a camminare. Passo accanto a una ragazza pallida e minuta, con gli occhi grigi e i capelli chiari. Lo seguiva un passo indietro, come un soldatino, un po rigida, e ora sembra preoccupata. Forse avrei dovuto chiedere scusa, sono stato proprio maleducato.
Sono passati ventanni. Quello che sicuro mi aveva incuriosito era un esordio, si intitolava Studio per le Serve. Da allora non ho smesso di seguire il lavoro di Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa.
È un gruppo che sicuro mi piace moltissimo, perché inventa spettacoli sempre un po strani. Anzi, molto strani, se giudicati con gli standard della routine teatrale. Perché sono opera sicuro di due fanatici. Perché sono lavori belli e intelligenti, pieni di energia. E perché, anno dopo anno, mi continuano a lavorare nella memoria.

Marco Isidori è Macbeth e Lady Macbeth.
Lui è Marco Isidori, il coté barocco, decadente ed enfatico che corrisponde a Marcido Marcidorjs, lei è Daniela Dal Cin, lanima in apparenza fragile ma determinata, nonché dolcemente surreale, di Famosa Mimosa.

Maria Luisa Abate protagonista di Happy Days in Marcidos Field.
Alla coppia bisogna aggiungere almeno la suprema primattrice della compagnia, Maria Luisa The Voice Abate, presenza costante e imprescindibile come la fedele Sabina, e poi limmancabile Coro dei Marcido…
Al palcoscenico arrivano tardi (Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa nasce nel 1984, quando Marco e Daniela hanno superato la trentina), per vie oblique e oscure, quando i gruppi della seconda onda del Nuovo teatro italiano sono già esplosi. Così dal punto di vista critico i Marcido rimarranno, come le Albe a Ravenna, un po schiacciati tra chi è emerso allo snodo tra i Settanta e gli Ottanta e la terza onda dei Teatri 90 (anche di qui la ritornante polemica dellIsidori contro i critici).
Il gruppo ha sede a Torino, dove spesso officia in teatrini-appartamento, in teatri-bomboniera in cima ad antichi palazzi, in teatracci di periferia… Spesso i due leader si ritirano a meditare e lavorare tra i monti della Val Varaita o a San Benedetto del Tronto, in riva allAdriatico.
Lui è prima di tutto poeta, e ribadirà più volte la sua fede ambigua nella Parola:
I cardini della nostra ricerca sono sempre stati la Parola, il Verbo, il Significato, la Significazione: tutto secondo me è racchiuso nella Parola.
(Marco Isidori, intervista di Christopher Cepernich, Corriere dellArte, 22 giugno 1996)
Lei nasce invece pittrice. Ogni tanto li incontro, a Torino, a Milano o chissà dove, e facciamo quattro chiacchiere. Anno dopo anno, gli ho ripetuto di tenere duro anche se i loro spettacoli giravano poco e la critica latitava, che erano bravi anche se non capivo tutto, e dunque di non preoccuparsi troppo se il loro lavoro non lo capiva quasi nessuno.
Ho scoperto che Daniela Dal Cin più spesso delegata alle missioni diplomatiche ha una voce levigata come i ciottoli che si trovano sui greti dei fiumi. Spesso parla con un volume qualche decibel più alto del giusto e per questo, quando ci incontriamo nei bar vicino alle stazioni, gli altri avventori ci guardano un po strano. Lui invece ha sempre quel modo brusco, i gesti e la voce che ogni tanto hanno come uno strappo. È sempre molto sicuro di quello che dice, come se fosse una questione di vita o di morte, e capisci che è meglio non contraddirlo troppo, altrimenti si potrebbe infuriare. Infatti quando discutiamo cerco di non contraddirlo troppo: lui e Daniela si fidano un podi me (ulteriore aggravante, per quei due…), e per fortuna Marco non si arrabbia nemmeno se lo prendo un po in giro. Anzi, ogni tanto esplode in una gran risata, anche se a volte non capisco bene il motivo: e allora quella bocca che gli taglia la faccia si spalanca, ed è insieme dolce e crudele. Naturalmente quando ride così nei bar gli altri avventori ci guardano un po strano, ma non me ne importa niente.
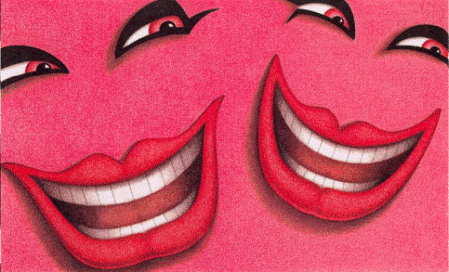
Il sipario della Locandiera.
Non esiste in Italia chi abbia unidea di teatro forte, coerente e ostinata come Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa. E che labbia praticata con tanta forza, coerenza, ostinazione e disciplina per decenni, nellarco di una ventina di spettacoli, contro tutto e tutti. Una coerenza, va aggiunto, che non è mai monotona, perché vi fiorisce rigogliosa la pianta del barocco e dunque è sempre colorata, inventiva, sorprendente. E insieme ossessiva e feroce: loro dicono che è protetta solo dallo scudo fatato del suo gentile anacronismo, e dunque la difendono con una verve polemica lucida e acuminata.
Perché e anche questo è notevole questa idea di teatro non si è mai evoluta, almeno nelle sue linee portanti: è sempre rimasta la stessa, matura e definitiva fin dagli esordi, come risulta evidente dalle quattro comunicazioni inaugurali, redatte nel 1984 da Marco Isidori mentre lavorava alle Serve. In fondo i Marcido hanno sempre fatto la stessa cosa: Siamo andati a caccia del Palcoscenico Elementare!, come proclama lIsi nelle note di regia del suo Pinocchio.
È chiaro, ci sono state variazioni sul tema, diverse combinazioni degli ingredienti, e dunque un costante gusto della sperimentazione e della sorpresa, un affinamento di certe tecniche, e a volte ma molto di rado qualche soldo in più da investire nella produzione. Ma quello che colpisce è la costanza, lostinato ardore del duo e lentusiasmo che riescono a trasmettere ai loro allievi, sempre nuovi (si intuisce che non è facile restare a lungo in compagnia: pochi soldi e una disciplina troppo dura, una dedizione al teatro che può sfociare in un moralismo fondamentalista…).
Ancora più sorprendente è un altro dato: in fondo la poetica del gruppo è basata su un principio molto semplice, che dovrebbe essere alla base di ogni opera spettacolare. Ma i Marcido lo spingono alle conseguenze più radicali, estreme (o meglio logiche), e così sembra che gli altri si limitino a enunciarlo, quel principio così chiaro e importante, senza tradurlo davvero in pratica.
Qui è la radice profonda del Teatro, lorigine della sua stessa specificità estetica: il carattere unitario di tutto quanto in esso concorre alla costruzione drammatica, la pertinenza di acconciature e costumi, della recitazione, della scenografia e della musica, pertinenza propria dellatto liturgico che non consente alcunché di interscambiabile.
(Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa, Una giostra: lAgamennone, Edizioni del Noce, Camposampietro, 1991, p. 3)
Il principio fondamentale, il primo postulato del Teatro Elementare dei Marcido, è dunque banale: i diversi elementi costitutivi dellevento spettacolare gli attori e i loro corpi, le scene, gli addobbi e i costumi, le luci e le ombre, la voce e la musica, le parole, i gesti, il respiro e il canto, e naturalmente anche gli spettatori fanno parte di un tutto unico, una macchina-corpo dai molteplici organi. I punti di riferimento sono quelli della grande tradizione delle avanguardie del Novecento, primo tra tutti A. A. (…) lanimo furioso di Antonino. E poi
una valanga di molti bei nomi depoca: dal grande Craig, al gesuino Grotowski, dal tonante Mejerchold, al malinconico Appia, e profondendosi via via fino allultimo bagliore che soffiò Carmelo sullo sguardo del mondo qualche lustro addietro.
(dal programma di sala di Happy Days in Marcidos Field)
Siamo insomma nel gran fiume del teatro come opera darte totale: ma in questo caso praticata con una coerenza dacciaio, ispirata da una fiammeggiante fede nel teatro e nelle sue capacità di fascinazione e trasformazione. Con la consapevolezza che solo la pratica teatrale più precisamente le modalità con le quali tratteremo lattore può davvero liberare la scienza di quei Nomoni (…) inscatolata nei libri! (dal programma di sala di Happy Days in Marcidos Field). Evitando naturalmente di cercar scampo o facile approdo nella gran carosellata dei ludi sommatori (dal programma di sala del Cielo in una stanza). Insomma, si cerca ununità organica, essenziale.
Questa visione del teatro spazza subito via ogni idea di rappresentazione: la Marcido, lontanissima da ogni realismo, per non abortire nel verosimile immondo cancella introspezione e psicologia privilegiando azione e gesto. Trascura la mimesi e cerca la catarsi. Questo postulato antinaturalistico è subito sancito da una delle due citazioni poste in esergo alla inaugurale Prima comunicazione per Le serve (1984), rubata a un maestro di esacerbata teatralità:
Senza sapere di preciso che cosa sia il teatro, so quel che gli nego dessere: la descrizione di gesti quotidiani vista dallesterno.
(Jean Genet)
In secondo luogo la fusione di elementi e corpi diversi, animati e inanimati, porta con sé una potente tensione erotica, o meglio erotizza corpi, oggetti e organi (e qui il punto di riferimento teorico potrebbe essere il corpo senza organi di Artaud riletto da Deleuze e Guattari). La riemersione del dionisiaco passa anche da qui, attraverso la creazione di un inquietante codice pornografico, di un perturbante alfabeto sadomaso, di una regola orgiastica.
Nei confronti dei testi, il metodo Marcido prevede una personale forma di appropriazione, spesso gioiosamente esplicitata nei sottotitoli: ci sono una Sirenetta di Andersen intrappolata nel gioco della Marcido e una Locandiera che negli stessi Marcido inciampa, un Isi (alias Marco Isidori) che fa Pinocchio (anche se desidererebbe sfar lo Mondo), Beckett che si perde in Marcidos Field e che poi ispirerà Marcidos Love, una solenne funzione del Prometeo incatenato di Eschilo, un Macbeth che lIsi ha potuto leggere soltanto per come il suo strabismo glielo permise, e ancora i Giganti pirandelliani senzaltro da far nostri.
Oggetto di queste appropriazioni un programmatico e sistematico stupro sono miti classici e moderni, dalle Serve omicide di Genet ai sanguinari Atridi dellOrestea, dal dio ribelle Prometeo a Suzie Wong in quanto monumento allalterità la più direttamente conclamata, da un fremente Macbeth ibridato con la sua Lady alla logorroica Winnie di Beckett, da Fedra a unaltra chiacchierona come Molly Bloom. Al fuoco teatrale si glorificano, cantano e bruciano gli eroi e soprattutto le eroine di un Olimpo della diversità, spesso ibridi e comunque con più duna traccia del Mostro. Protagoniste sono dunque
combinazioni dellenergia fatale, (…) Loro (…), i Regali, le celebrità affermatesi per esser vispe scatenatrici della Grande Occasione Epifanica del Signor Dioniso.
(dal programma di sala di LIsi fa Pinocchio)
LOccasione Epifanica è naturalmente ciò che i Marcido cercano disperatamente ogni volta di resuscitare sul loro Palcoscenico Elementare.
Tra gli antecedenti di queste riscritture ci sono le sintesi futuriste, a partire dalla funzione dinamizzatrice evidenziata da titoli che evocano danze di guerra, giostre e vortici, party, tiri a segno (Bersaglio su Molly Bloom), perché
il mondo del Circo, dei divertimenti viaggianti e degli antichi stadi (…) sono, per noi, luoghi autentici dellepifania dionisiaca.
(Una giostra, cit., p. 4)
Ma il modello sono soprattutto le folgoranti reinvenzioni di Carmelo Bene, con la loro capacità di decostruire i testi, di smontarne il senso e svuotare la stessa logica della rappresentazione; anche se va aggiunto i Marcido cercano di superare la dimensione dellassolo a favore della coralità, e impostano un rapporto più complesso e articolato con il pubblico.
In effetti lappiglio più semplice per penetrare la poetica dei Marcido è proprio la posizione dello spettatore nei loro corpi-macchina. Nello spettacolo desordio, lo Studio per le Serve, la scena è una sorta di cassaforte-armadio, una placenta-vagina foderata di stoffa rossa, metafora semplice ed esplicita sia in rapporto al testo di Genet sia nellesemplificazione di una certa idea del teatro. Al pubblico è imposta la tradizionale posizione di osservatore della scatola scenica con le ante dellarmadio a fungere sipario e quarta parete ma questa funzione è per così dire iperdeterminata dalla metafora, ironicamente sottolineata, e insomma subito svuotata di senso.
Lincognita dello sguardo dello spettatore verrà poi risolta in diverse maniere, con ulteriori spostamenti. Nella tappa successiva la scatola-palcoscenico ingloba il pubblico, che diventa così anche elemento scenografico e drammaturgico di cui esplorare le diverse potenzialità (e in questi teatri-tempio savverte leco di certe invenzioni di Grotowski e Barba, ma filtrate e razionalizzate in macchinerie barocche di sapore ronconiano). Nelle Serve, una danza di guerra i venti-venticinque spettatori-voyeur vengono infatti sistemati sulla panca che corre tutto intorno a una struttura ovale di ferro e legno, chiusa o meglio sigillata da siparietti di stoffa rossa. I curiosi possono sbirciare allinterno solo attraverso una fenditura orizzontale alta una dozzina di centimetri che corre allaltezza dello sguardo. Lì dentro, in quellarena claustrofobica, le serve assassine Claire e Solange danzano per questi occhi una guerra di crudele raffinatezza. Il pubblico si fa attivo protagonista, fin dagli esordi:
Sono gli sguardi del pubblico moltiplicati dalla geometria, a cingere lazione, la loro presenza a ridosso della scena e di sé stessi, creerà nellattore, una nervosità leggera, un sentirsi scrutato da occhi che scrutano, molto favorevole a portare nella recitazione quella lieve componente isterica, sufficiente, a sospenderne i gesti (Genet).
(Le serve, Prima comunicazione)
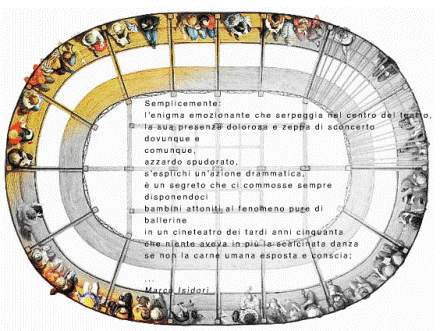
La scena di Una giostra: lAgamennone.
Una giostra: lAgamennone porta questo rapporto alla logica evoluzione: i settanta spettatori penetrano ora in una versione riveduta e ampliata di questo teatro-scenografia lovale si è ingrandito fino a misurare una decina di metri sul lato maggiore e siedono addossati alla parete della Reggia degli Atridi. In unacrobatica coreografia tridimensionale, gli attori esplorano lo spazio, ne percorrono le linee di forza, circondano e aggrediscono il pubblico da ogni lato (sembra un sogno di Mejerchold fatto realtà).
Il meccanismo del coinvolgimento può farsi ancora più radicale. Il cielo in una stanza ha un unico spettatore: dove unico vuol dire certo privilegiato, ma forse anche ultimo della specie; o meglio un esemplare di laboratorio su cui verificare, con sana e ingenua radicalità, lefficacia della comunicazione teatrale. Lo spettatore-cavia si ritrova chiuso in un appartamento, in balia di dieci attori. A un certo punto diventa addirittura Gengis Kahn e gli tocca sedere in groppa a una tigre di nome Ma (in realtà due attori-portatori nascosti sotto il coloratissimo mantello dellanimale) che lo scorazza di qua e di là nella stanza: come in un folle rodeo, deve addirittura domare la belva dellimmaginario.

La Torre del Teatro Rosso.
Al vertice della megalomania scenografica di Daniela Dal Cin si pone (per ora) la Torre del Teatro Rosso, pensata nel 1993 per un Gengis Kahn mai realizzato (vedi Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa. disegni, costumi, scenari, con introduzione di Franco Quadri, catalogo della mostra, Torino, Piemonte artistico e culturale, 4-21 aprile 1996). La Torre, edificata un decennio dopo per il Vortice del Macbeth, è un impressionante cubo di nove metri di lato, dove la funzione di sipario è affidata alla superficie esterna (tre anni di lavoro per 27 grandi tele), interamente percorsa da una rossa decorazione di carattere esplosivamente erotico, un corteo danzante di corpi nudi impegnati in amplessi dogni sorta, un trionfo di satiri e menadi infoiati, di centauri e ninfe che esibiscono i genitali, e coinvolgono persino gatti, cammelli, serpenti e coccodrilli in un folle e interminabile girotondo orgiastico punteggiato da demoni maliziosi e compiaciuti. Il pubblico questa volta unottantina di testimoni-complici penetra nella Torre salendo una passerella-ponte levatoio e si pigia su tre pareti, in due file serrate di panchette. La fortezza è un buco, il fallo si rivela vagina (per i Marcido il teatro non è mica una bocca, come teorizzava Richard Schechner…). Gli attori a cominciare da un Marco Isidori in sottoveste e scarponi, che è insieme Macbeth e la sua Lady si muovono soprattutto al centro, in fondo al pozzo nero del teatro: gli spettatori li guardano dallalto, ma spesso si ritrovano anche circondati e sovrastati dalle azioni dei coreuti-acrobati.
Inutile sottolineare la follia economica di queste imprese di carpenteria: ma i teatrini-Marcido vere e proprie architetture, frutto anche dellabilità artigianale di fabbri e falegnami sono necessari altari sacrificali che arricchiscono il significato della parola teatro restituendogli il senso del rito.
Il pubblico può dunque essere inglobato nello spettacolo, ne fa sempre organicamente parte, a volte in maniera imbarazzante, superando il confine dellintimità. Tuttavia non si creano mai confusioni di ruoli o superficiale coinvolgimento. Allo spettatore, masochisticamente inchiodato alla sua posizione, non si chiede di agire e interagire con gli attori, ma solo di essere uno sguardo il più possibile acuto, e al limite voyeuristico.
Nel Palcoscenico Elementare dei Marcido attore e spettatore incarnano due poli, ovvero due ruoli distinti e individuabili. Nel riflettere su questa separazione, i sipari assumono un ruolo insieme funzionale e simbolico, grazie a una variantistica provocatoria e pedagogica, oltre che baroccamente sorprendente. I sipari condensano e tematizzano infatti la dialettica tra théatron e skené:
La prima rimanda allatto del guardare, la seconda a quello del nascondere. Mettendole in relazione si dovrebbe concludere che teatro significa: sottrarre qualcosa allo sguardo.
(Fernando Mastropasqua, Teatro provincia delluomo, Edizioni Arti Grafiche Federico Frediani, Livorno, 2004)
In Una canzone damore cè un potente sipario di carta, vasto, teso, tirato a far da pancia sonora sulle costole di una struttura poligonale ad arco (Il Mondo! sì, il Mondo!), e nei disegni preparatori si precisa raggio metri 2,5 altezza metri 4: il Gran Sipario di carta cinese verrà naturalmente sfondato dalla Pallaceppo alla quale è incatenato Prometeo.
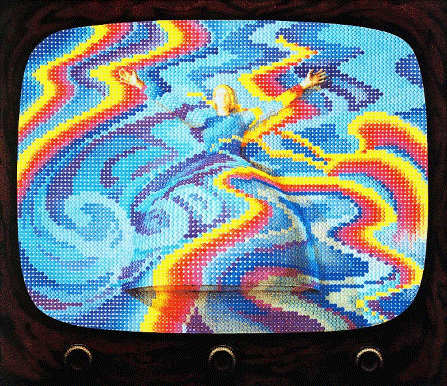
La scena di Palcoscenico ed Inno.
Per Palcoscenico ed Inno circa ventimila bottoni di seta colorata simulano in un maniacale arazzo i pixel di un monitor video, dentro una cornice-scatola-boccascena di falso legno con gli appositi pulsanti. Come in un quadro di Seurat, da quel fluttuare di punti, curve e sinuosità emerge una figura femminile, quasi crocifissa allo schermo: è la Sirenetta, pura immagine alla ricerca di unanima, sospesa tra il fantastico mondo sottomarino e la realtà. Così il teatro gioca a scimmiottare, con lingenuo e maniacale illusionismo del bricoleur, lattrazione dello schermo elettronico, ma risponde esaltando la terza dimensione, fino a chiamare in scena un grottesco, surreale e rotolante uomo-palla.
Attraverso il sipario, il gioco del gran teatro della meraviglia e della sorpresa si può rivelare ora seduttivo ora minaccioso. Happy Days in Marcidos Field si presenta con una clamorosa cortina di corpi nudi, vivi e pulsanti a pochi centimetri dal pubblico: penzolano nel vuoto uno accanto allaltro, appesi per le braccia, a chiudere il boccascena prima di dar vita al coro che incarna Willie (che nelloriginale beckettiano è il muto compagno di scena della loquacissima protagonista, e ora viene frantumato, moltiplicato e distribuito nellennesimo Coro Marcido). Ma la provocazione erotica può ribaltarsi in segnale di pericolo.

La locandina di A tutto tondo.
A tutto tondo si apre con unimmagine ancora più scioccante: la scena è una gabbia chiusa da una palizzata che sfoggia conficcata al sommo una chiostra di testine umane mummificate: sono le repellenti teste mozze di chi si è avvicinato al mistero e non ha superato la prova. Allinizio dello spettacolo la grata cala verso il pubblico, a segnalare una zona di pericolo; poco dopo la sagoma del mansueto gorilla che sintravedeva subito dietro viene smembrata per consentire lapparizione della protagonista della serata, la sensuale e terribile Suzie Wong: quella lugubre palizzata-sipario dà accesso a
una vera e propria Camera di Demenza; unalcova, sommata ad una gabbia, sommata ad una pista di circo; tutto, il tutto, attrezzato con sottopalchi, altalene, trabocchetti e uninfinità di gogne.
In Spettacolo cè addirittura un sipario (detto del Mostro, come informa lopportuna didascalia) che ribalta il senso della comunicazione teatrale e restituisce allo spettatore il suo sguardo: al centro di un ciclone azzurro di cieli, nubi e velocità, appare un occhio gigantesco che guarda minaccioso ma non vede (un altro occhio ugualmente inquietante e surreale, in forma di enorme scultura, campeggerà anche nel Prometeo, nella scena di Io e perciò sormontata da due enormi corni bovini. Si trovano altri occhi, in scena e nelle locandine, a testimoniare un rincorrersi coerente di riflessioni, temi e metafore insomma il sedimentarsi dun immaginario o di una mitologia).

Il programma di sala di Musica per una Fedra moderna.
Questi sipari, così come quei prototipi di teatro ovali o turriti, sono autentici capolavori. Così come lo sono molti dei costumi, delle acconciature e degli attrezzi disegnati e prodotti con artigiana pazienza da Daniela Dal Cin. Anche se, a ben guardare, è molto difficile scindere lattore dalle scene e dagli oggetti di scena: spesso formano un tutto organico, attraverso protesi e cinghie, appoggiature, altalene, cappi e trapezi (…) che noi seleggerà a praticabili (e qui la memoria va al Sogno di una notte di mezza estate circense di Brook).
Quello dellattore e della scena è un rapporto simbiotico, fin dal primo Studio per le Serve. Il costume di Madame diventa una raggiera di fili perlati a formare una rete che incatena lattrice alla scena, una meravigliosa trappola finale, un gioiello, ardito per concezione e splendore nero (Le serve, Comunicazione numero due): lattrice-ragno è prigioniera nella cassaforte-vagina, e al tempo stesso potenziale cacciatrice che seduce gli spettatori e la loro attenzione.
Lambiguo meccanismo verrà spesso ripreso in seguito, lungo il sentiero ripetitivo della coazione nevrotica e quello sacrale del rito. Troverà altre apoteosi, a cominciare dalla Cassandra-ragno dellAgamennone. In Spettacolo la ritualità della tragedia si ribalta in un esibizionismo vagamente sadomaso: la belva-protagonista Fedra, estranea e diversa fin dal suo primo apparire, viene ingabbiata in costumi scultorei, issata su alte pedane, esposta seminuda a mezzaria con lunico sostegno di un palo orizzontale, intrappolata da abiti e macchinari che la trasformano in unicona in bilico tra ieraticità e feticismo; la sua declamazione è sempre enfatica, ricca di sottolineature ed eccessi, a volte strozzata, singhiozzante e gutturale, a volte melodrammaticamente intensa, ripiena e arrotondata. È finita lepoca dei mostri, si lascia sfuggire la Nutrice: perché questa Fedra si rivela lultimo mostro che può infrangere le leggi dellumanità, lunica creatura ancora in grado di farsi travolgere dalla sua animalità e già pronta come un ibrido cyberpunk alla contaminazione con la macchina. Dunque è creatura intrinsecamente teatrale, attraente e repellente, irrimediabilmente diversa, ultimo residuo di un passato cancellato dallavvento dellIo e delle sue miserie, e insieme anticipazione di una spettacolarità inquietante e scandalosa.

Happy Days in Marcido’s Field.
In Happy Days in Marcidos Field la protagonista resta incastonata per tutto lo spettacolo come unape regina al vertice duna piramide di legno, che reinventa il monticello di sabbia immaginato da Beckett. Questa gabbia-trono occupa lintero palcoscenico: quando si scioglie il sipario di corpi nudi che la nasconde alla platea, al sommo vi appare Winnie, bloccata e quasi infilzata sulla cima di queste travi, la pelle arrossata e annerita dal fuoco, come scorticata e sanguinolenta, in un sacrificio erotico alla Bataille. Sotto unenorme ma ingrigita parrucca anni Sessanta, inguainata in un bustino decorato di rose, Winnie sferza con il suo stravolto monologo il monte di nudità che nel frattempo si sono avvinghiate allo scheletro ligneo, come in un affresco dellInferno; e sferza gli spettatori, nei loro abiti civili: come se per avere il teatro e catturare lo spettatore (e non solo il suo sguardo) fosse necessario prima questo denudamento, e poi andare ancora oltre, fino alla carne viva.
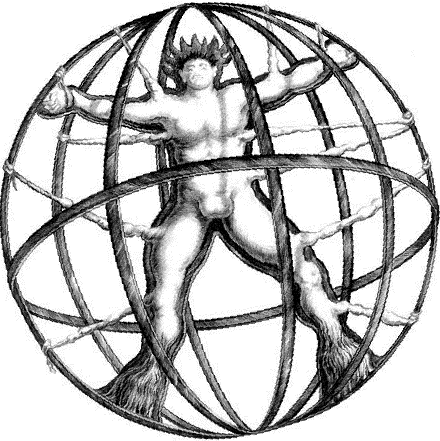
La Palla che recita di Una canzone damore.
In Una canzone damore Prometeo, il dio che ha liberato per gli uomini le forze della natura il fuoco si ritrova imbragato al centro di una gigantesca sfera di ferro, quasi a parodia del celeberrimo uomo vitruviano disegnato da Leonardo, inchiodato alla propria abnorme individualità. Intorno a questa gabbia-prigione si erge in forma di cornice un arco, sempre di ferro, largo nove metri e alto sei, che indica un ulteriore orizzonte, quello del boccascena-Mondo. Per tutto lo spettacolo Prometeo-Isidori, Corpo Magico, insieme metallico ed umano, verrà sballottato e centrifugato, autentica Palla che recita sospinta per la scena in un folle inesausto giravoltare, con lattore costretto a declamare faticosamente e innaturalmente il testo in ogni posizione, sospeso nel vuoto con varie inclinazioni e spesso a gambe allaria.
La scena diventa un ambiguo teatrino sadomasochistico a cui lattore si fa legare per il piacere voyeuristico di chi lo guarda (peraltro analogamente inchiodato al suo posto e ruolo, come sè visto), e che naturalmente diventa loggetto da sedurre. In un lavoro per certi aspetti minore, La locandiera, si fa esplicito il rimando a Kleist e Craig: per tutto lo spettacolo gli attori agiscono come marionette mosse da fili ben evidenti, in un abnorme teatrino per bambini.

La Grande Conchiglia di Bersaglio su Molly Bloom.
La strepitosa scenografia di Bersaglio su Molly Bloom moltiplica il meccanismo sadomasochistico della legatura su unenorme struttura-sipario in ferro, illuminata da cento lucine, che occupa lintero boccascena. Gli undici cantanti Marcido alcuni raddoppiati da sagomati in cartone per riempire tutte le nicchie di questo gran retablo sono imbozzolati allinterno di altrettanti costumi-conchiglia bianchi, a loro volta collegati da tiranti alla Grande Conchiglia che fanno risuonare di voci soliste e contrappunti corali.
Come abbiamo visto, attore e scena sono collegati spesso inestricabilmente in un tuttuno da legacci e corregge, funi e carrucole, protesi e ceppi, che sospingono il corpo vivo, con la sua carne pulsante e il suo respiro, verso la macchina e la cosa. Costumi e acconciature possono evocare anche la materia o lanimale. Esemplari e memorabili restano i costumi dellAgamennone, che intrecciano lumano con il minerale, il vegetale, lanimale, e che al tempo stesso fungono da sorgenti ritmiche e rumoristiche, come mantelli sciamanici: le scaglie di rame dello strascico di Clitennestra-serpente, le lance di legno che si dipartono da Agamennone-istrice e già citato labito pesantissimo e interamente ricamato di anelli dottone con corona-lampadario a raggiera dalluminio al cui centro campeggia una Cassandra-ragno. In unopera darte totale ossessiva e claustrofobica, lelemento umano resta così angosciosamente sospeso tra la dannazione e la redenzione, tra la regressione nella materia e la sublimazione nello spirituale.
Libridazione tra umano e non umano resta peraltro una costante a cui attingere, non appena se ne presenta loccasione. A volte e con i Marcido accade spesso si condensa in esperimenti che generano efficaci metafore sceniche.
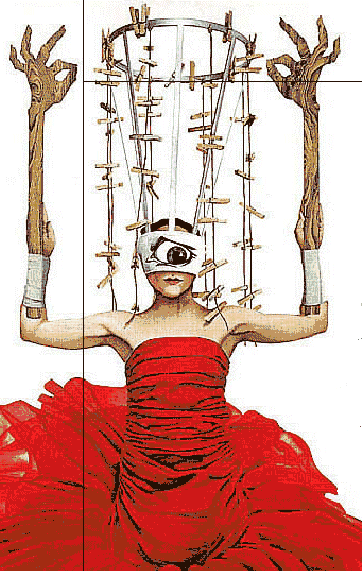
La Grande Ballerina protagonista di Canzonetta.
In Canzonetta presentato come studio dai Persiani protagonista è la Grande Ballerina (in Eschilo era la regina Atossa, vedova di Dario e madre di Serse), essere finto naturale, chimera che nasce dalla fusione di due corpi, sormontata da un ennesimo grande occhio cieco e da una beffarda corona-aureola decorata di mollette da bucato; anche le mani sono riproporzionate grazie a due protesi di legno che alludono ai remi della battaglia navale di Salamina, intorno a cui ruota il testo. A creare il mostro è il tutù rosso che inguaina due corpi impilati e incastrati uno sullaltro, quelli dellattore che verso il basso preme seguendo gravità e del danzante che alla gravità si oppone e verso lalto spinge, come annota Ferdinando D’Agata: alle sue gambe muscolose tocca, in un exploit atletico, il ruolo del danzante, mentre la voce dellattore che verso il basso preme è quella di Maria Luisa Abate. Proprio nel contrasto tra queste due energie contrapposte, tra voce e corpo, sta il senso di una sperimentazione quasi agonistica: secondo le note di regia, lo stridere delle giunture mentre è in atto lo sforzo per dare esistenza al progetto chimerico, fonderà lo spettacolo.
In questa colorata sarabanda di ibridi e chimere sintrufolano animali totemici, che campeggiano su grandi pannelli o in enormi sculture: il Gatto e la Volpe per Pinocchio
Oliviero_Ponte_di_Pino
2007-01-09T00:00:00
Tag: Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa (13)






Scrivi un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.