Oltre il coronavirus | Riuscirà il teatro a sopravvivere alla pandemia? Speranze e pessimismi
Tre giovani curiosi attori italiani interrogano un devoto dell’azione mentre una studiosa russa vede nero
Ateatro sta provando a immaginare quello che sarà il futuro dello spettacolo dal vivo dopo il Coronavirus.
Una prima sollecitazione di metodo l’ha offerta la decisione di Ravenna Teatro di destinare tutti i fondi ricevuti per l’emergenza ad artisti, residenze e spazi di ricerca.
Questo secondo intervento mette a confronto due visioni per molti aspetti contrapposte, anche se partono da una idea condivisa di teatro.
Nel corso degli scorsi mesi, un gruppo di giovani attori con sede a Trieste, Artifragili, ha organizzato un ciclo di incontri con alcune personalità della scena italiana ed europea, #chenesaràdinoi.
Il 3 giugno 2020, l’interlocutore di Artifragili è stato Alessio Nardin, regista e pedagogo, per una riflessione sulla situazione dello spettacolo ai tempi della pandemia. Tra i testimoni di questo dialogo, Natasha Isaeva, studiosa e donna di teatro che collabora con Anatoli Vassil’ev da quasi 19 anni, e che ha voluto condividere i suoi pensieri.
Un ringraziamento speciale ad Artifragili per la loro preziosissima collaborazione.
Alessio Nardin | Il teatro è un pallone da spiaggia che torna in superficie

Alessio Nardin a Valladolid (2019)
Come ha passato questo tempo di quarantena?
Ah, subito una domanda d’attualità!
Preferiva una introduzione più generale? Noi vorremmo usare al meglio il tempo con lei.
Va benissimo. Anche se il mio desiderio non sarebbe dare delle risposte, piuttosto trovare la strada per pormi degli interrogativi insieme a voi. Per questo ciò che mi preoccupa di più sono esattamente i tempi di questa intervista. Perché forse nasceranno dei silenzi tra noi ed è difficile scrivere un silenzio, una pausa, e non so se i tempi dei vostri lettori sono gli stessi che ho io.
Allora facciamo così, si prenda tutto il tempo che vuole. Di cosa vorrebbe parlare? Può parlare di tutto ciò che vuole.
Se veramente ho totale libertà, comincerei proprio con un silenzio. (pausa) Ma come si può scrivere il silenzio? (pausa) Per provare a rispondere alla sua prima domanda, direi che in questo tempo ho praticato il silenzio: che non vuol dire stare zitto. Ho provato ad ascoltare con il massimo delle mie capacità tutti i suoni che venivano da fuori di me in questo momento straordinario, sia dal punto di vista umano sia per ciò che riguarda quello a cui mi dedico cioè il teatro e il cinema. Ho provato ad ascoltare tutto: le voci, i sussurri, le grida, le richieste, le opinioni. Questa è stata la mia principale attività in questo periodo.
E cosa ha sentito nel teatro italiano?
(pausa) Una gran “rumor bianco”. (pausa) Curiosamente mi sembra sia stato un tempo in cui contemporaneamente molte persone avevano urgenza di parlare o di fare rumore. Addirittura molto più di prima che tutto questo succedesse.
In che senso?
Probabilmente prima, nel teatro e nel cinema, c’erano molte voci soffocate e la pandemia le ha fatte salire a galla. Questo non vuol dire che tutto quello che ho ascoltato fosse un suono gradevole o interessante: a volte erano stonature, stridori, chiasso.
In questo contesto e periodo qual è secondo lei il ruolo degli attori e delle persone di teatro?
Non saprei, onestamente. Dovremmo chiederci dov’è il virus: dov’è fisicamente? Quello che ho visto più di frequente, rispetto alle realtà europee che conosco, ha a che vedere con due cose. La prima: concretamente il teatro europeo, e quello italiano ancora di più, è molto preoccupato di essere indispensabile per la polis. E giustamente, a mio modo di vedere, lo rivendica. La seconda: rilevo, come paradosso, che più lo rivendica e meno trova persone che siano concretamente d’accordo in questo.

Steel video da «Asino» di Anatolij Vasil’ev, presentato all’International Film Festival Rotterdam 2018.
Cosa intende dire? Che non c’è sufficiente attenzione da parte della società per il teatro e il cinema?
No. Intendo dire che formalmente nessuno si alzerà in piedi e dirà: “Radiamo al suolo i teatri. Distruggiamoli!” Nessuno sarà tanto onesto intellettualmente, come lo fu in un momento di lucidità il ministro delle finanze italiane di qualche anno fa (anche se poi Giulio Tremonti ha smentito di aver pronunciato quella frase). Nessuno riuscirà a dire ciò che pensa, cioè che “con il teatro non si mangia”. Nessuno dirà che ormai il teatro si sta approssimando a un lavoro da mantenuti o al volontariato. Nessuno lo ha detto e nessuno lo dirà. Ma ciò che vedo è che più gli attori rivendicano la loro indispensabilità per la comunità e meno questa gli viene riconosciuta. In altri termini, gli attori e i registi continuano a dire pervicacemente che “senza di noi il mondo è più povero e peggiore”- In alcuni casi è vero! Ma concretamente sembra che nessuno abbia bisogno del teatro. O meglio, che i teatri e i cinema possano venire per ultimi nelle priorità della comunità. Non c’è nessuna reale urgenza di renderli attivi: nei Decreti sono gli ultimi a essere riaperti. E’ solo una constatazione.
Si potrà pur fare qualcosa contro questo! Lei ha visto o sentito qualche proposta interessante in questo periodo rispetto a come potrebbe cambiare il teatro durante e dopo il Covid-19?
Guardo con stima e con fascinazione le proposte che gli attori e registi italiani hanno fatto per vivere e poter sopravvivere in questo periodo. Ma da molti colleghi, anche famosi e che stimo, ho sentito cose che mi hanno fatto molto riflettere. Non tanto su quale possa essere il ruolo degli attori, dei registi e degli artisti del teatro in questo momento. Quanto piuttosto su quale sia la visione in prospettiva del teatro: mi hanno confermato che il teatro ha delle questioni non risolte che vengono da prima della pandemia e che la pandemia ha fatto smuovere proprio perché ha tolto la possibilità di fare.
Cosa l’ha colpita nelle proposte dei suoi colleghi?
In alcuni casi sono forme di resistenza del teatro nella pandemia e alla sua decadenza, altri che mirano a una sussistenza primaria e altre guardano invece in una prospettiva futura. Queste tre posizioni non sono la stessa cosa. Non vuol dire che una è negativa e l’altra positiva o che una è migliore dell’altra. Ma sono concetti, che sottendono a essenze, profondamente diversi e portano verso strade completamente diverse. Ho visto e vedo muoversi insieme persone che puntano alla resistenza con persone che puntano alla sussistenza con persone, per la verità poche, che provano a vedere la prospettiva oltre il presente, o meglio provano a vedere il momento attuale come possibile spinta per una rinascita. Ho sentito più volte dire che il teatro non sarà mai più come prima, che bisogna inventarsi un nuovo modo di fare teatro. Vi chiedo: siamo sicuri di questo? Se guardo indietro, mi sembra di vedere che il teatro sempre si è trasformato nell’evoluzione artistica con o senza pandemie e che ciò nonostante rimane identico nella sua essenza primaria. Anzi, solo rispettando la propria essenza può davvero rinnovarsi. Le personalità teatrali, recenti e meno recenti, che hanno rinnovato in modo determinante il teatro hanno sempre affondato le radici nei principi di base del teatro.
Concretamente quindi come muoversi ora? Che possiamo fare rispetto ai teatri e alle programmazioni?
(pausa) La vera domanda sarebbe: faccio perché sono? O faccio e quindi sono?
Tutte e due!
Non credo sia possibile: bisogna scegliere. Teatri e programmazioni sono frutto di scelte ben precise. Mi sembra che il teatro italiano, e forse in parte anche quello europeo, da diversi anni sia caratterizzato dal fare, fare, fare produzioni. Su questo si basano i finanziamenti, i tempi artistici (che forse proprio per questo tali non sono) e quindi anche le opere che ne escono. La legislatura italiana, da quando sono stati creati i Teatri Nazionali, a prescindere a volte anche dalle volontà dei direttori (che spesso sono persone che conosco e stimo), ha incentivato all’ennesima potenza questa tendenza. Il teatro europeo e italiano si è trovato costretto negli ultimi anni a fare e fare e “il fare” un po’ alla volta mi sembra che abbia rischiato di diventare “l’essere”. Per “essere” devi “fare”. Se non fai, non sei. Quando è arrivata questa pandemia, che ci ha chiuso in casa col silicone (come dice una persona che amo), ci siamo ritrovati a non poter fare e lì sono affiorati tutti gli interrogativi latenti. Per questo la domanda ha a che vedere con il quesito “faccio perché sono?” Ho una mia identità artistica e per questo realizzo un’opera? O viceversa: “faccio” uno spettacolo sperando che questo mi porti a scoprire la mio “essere”? Una cosa è sicura, e non dipende da me: questo virus ci ha costretto a non fare. E quindi non ci è rimasto che “l’essere”, qualsiasi esso fosse, in ogni sua forma.
Vista anche la sua importante esperienza all’estero (Europa, Russia, Sud America), quali sono secondo lei le differenze sostanziali tra la realtà professionale italiana e quella estera: c’è qualcosa che possiamo rubare da loro e se si che cosa?
Potrebbe essere un furto con scasso o una rapina a mano armata! Mi segue?
Certo!
No, non fraintenda: in tutti i sensi. Non sono un esterofilo! Amo l’Italia e il suo teatro. La mia esperienza, per una serie di coincidenze e incontri fortunati, si è sviluppata più in Europa e in Eurasia che in Italia. Però io le direi questo: esistono ancora alcuni luoghi nel mondo dove il teatro è veramente qualcosa di partecipato e lo è per la sua essenza. In questi luoghi la partecipazione comune avviene per la natura propria del teatro: il manifestarsi dell’azione in scena. Non so quanto dureranno ancora questi luoghi, ma ci sono e si possono frequentare e vivere. E questo credo che dovrebbe essere ciò che i giovani artisti dovrebbero cercare, vivere e costruire.
Perché dice che non sa se questi luoghi dureranno ancora molto?
Non so se dureranno, perché sono legati alla natura dell’uomo oggi: alla sua natura organica. Se lei scruta l’orizzonte come un marinaio esperto, può notare che probabilmente la pandemia è uno specchio di quanto le cose che riguardano il comportamento umano si propaghino rapidamente nel mondo e lo “contagino”. Una cosa che nasce in un posto, attraverso l’uomo e i suoi comportamenti, arriva velocemente in un altro. E questo vale anche per il teatro.
Mi sta dicendo che il teatro si comporta come un virus?
Facciamo un gioco, un paradosso: se noi adesso la bendiamo e la conduciamo in un teatro europeo, specie quelli occidentali, e lei non vede i cartelloni, non sa chi è il regista. Mi segue? Se io le faccio vedere tre spettacoli di tre diversi registi europei, lei corre il rischio di non sapermi dire se questo regista è francese, italiano, spagnolo, tedesco. E non parlo di nazione, per non rischiare poi di andare a finire in una categoria che non mi appartiene. Sto parlando piuttosto di una cultura, di un modo di vivere, di radici che ci appartengono profondamente. E quando questo comincia a scomparire si arriva a una sorta di impoverimento della persona. Ed è molto difficile rubare a un povero.

Stanislavsky Electrotheatre
Lei vede questo pericolo imminente?
Forse già in corso. Facciamo un esempio molto brutale e sintetico: nel periodo in cui noi qui a Milano avevamo una figura di riferimento enorme, forse uno dei pochissimi geni teatrali che abbiamo avuto, cioè Giorgio Strehler, a Mosca in quegli anni, nello stesso tempo nella stessa città, avevano una decina di artisti del calibro di Jurij Ljubimov, Anatolij Vasil’ev, Adolf Shapiro, Pyotr Fomenko, Anatoly Efros, Andrey Efimos, Lev Dodin, e me ne sto sicuramente dimenticando qualcuno e me ne scuso. Ho avuto la fortuna e l’onore di incontrare personalmente e di lavorare con alcuni di loro. Quindi esisteva una città dove ogni tre giorni potevi scegliere se andare a vedere quel artista piuttosto che quell’altro: si può vagamente intuire che ricchezza c’era? Era una ricchezza incommensurabile. Capite che radici aveva l’albero del teatro russo? Eppure oggi alcuni giovani registi russi, e lo dico con cognizione di causa visto che lavoro lì da alcuni anni, guardano come orizzonte all’Europa, che cercano di emulare. Questo è incredibile: è come prendere un albero che ha delle radici fortissime e segarle da sotto terra, per poi sperare che i frutti siano belli o che l’albero stia in piedi. Al primo alito di vento, l’albero verrà giù! Si tratta di un patrimonio incredibilmente ricco, che noi possiamo e dobbiamo rubare con avidità artistica.
Allora l’Europa in questo senso ha più materia da “rubare”?
Non parlo di questo. Per rubare qualcosa devi prima riconoscere ciò che è prezioso. Ora vi giro il gioco e si scateneranno le ire italiane ed europee. Guardate che radici avevamo noi italiani teatralmente. Non parlo neanche della Commedia dell’Arte, altrimenti si rischia di aprire il vaso di Pandora, ma basta guardare le nostre radici più recenti: Giorgio Strehler, Carmelo Bene, Eduardo De Filippo, Leo De Berardinis. Che ne abbiamo fatto? Questa è la domanda che mi pongo e che vi pongo.
Se nessuno possiede veramente le proprie radici, chi potrà rubare cosa e a chi? Questa è la vera domanda che vi farei.
Quindi quando lei mi chiede cosa possiamo rubare noi italiani ad altre culture? Io penso che le mie esperienze al Teatro Nazionale di Mosca Stanislavsky Electrotheatre, a quello Nazionale di Strasburgo e alla Escuela Superior de Arte Drammatica in Spagna, in Brasile, in Francia, in Polonia, e molte altre esperienze europee, mi indicano che potremmo rubare l’indispensabilità concreta del teatro per la comunità. In alcuni paesi, istituzioni e artisti ritengono indispensabile il teatro, reciprocamente e insieme. Questo forse in Italia manca: a volte manca l’istituzione a volte mancano gli artisti.

Stanislavsky Electrotheatre
Allora l’Italia è molto arretrata e dovrebbe rubare molto?
Non credo. Perché, come ho accennato prima, anche loro avrebbero molto da rubare da noi. Posso portarvi solo un esempio concreto, apparentemente lontano dal teatro. Se andate a Mosca, a San Pietroburgo, a Parigi, a Madrid e dite “Fellini”, le persone si illuminano. Quando porto l’immaginario delle scene dei singoli film,gli attori, quelli giovani e quelli meno giovani, attori subito si accendono perché le conoscono molto bene. A me è capitato qualche volta di farlo con dei giovani attori italiani, e naturalmente mi asterrò dal farlo con lei, ma spesso le risposte sono: “Sì, ne ho sentito parlare”, “Devo guardarlo” eccetera. Questo ha a che vedere con le radici del nostro albero, la recente età dell’oro di Visconti, Fellini, De Sica, Antonioni, Risi, Monicelli, Rossellini, Scola, Germi.
In altri termini guardate: io sono un contadino, figlio di contadini. Come direbbe qualcuno, probabilmente sono due buone braccia strappate ai campi che momentaneamente si dedica al teatro, ma chi viene dalla cultura rurale sa perfettamente cosa vuol dire avere radici sia che queste siano culturali, sia che queste siano legate al luogo dove si nasce. Se volete, giusto per non allontanarsi dagli esempi che vi ho appena fatto, prendete Fellini: la Romagna trasuda dai suoi lavori e non importa se poi sono ambientati altrove, le sue radici sono chiarissime. Io ho vissuto personalmente quell’aria e quell’atmosfera perché nel film che ho fatto insieme con Anatolij Vasil’ev, Asino!, molti dei testi che abbiamo utilizzato ci sono stati dati in esclusiva da Tonino Guerra, che il maestro Vasil’ev conosceva personalmente.
Quei testi trasudano l’originalità dell’uomo. Allora penso che è proprio questo il punto chiave: quando in diversi luoghi del mondo comincia a essere chiaro per l’uomo che per ottenere un buon frutto dall’albero le radici devono essere forti e sane. Nessun albero con le radici marce o tagliate potrà dare frutti. Avete solo una possibilità: andare al supermercato, prendere i frutti e attaccarli con lo scotch all’albero o poi dire: “Avete visto il mio albero quanti bei frutti ha dato? Sono un bravissimo contadino!” Ma in realtà sono mele prese al supermercato e poi attaccate con lo scotch a un albero morto. Se volete, potete chiamarlo un albero di ricerca o contemporaneo, ed è vero, però concretamente quel albero non dà frutti.
Quindi lei crede che sia una questione legata alla cultura?
Credo che tutto sia più semplice e più concreto. Non credo sia una questione di cultura intesa come tutto ciò che riguarda le arti. È una questione di come viviamo e della inevitabile presenza sulla scena teatrale di due entità che sono nello stesso corpo: la persona e la persona scenica. La vita dell’una non è automaticamente connessa alla vita dell’altra, anche se hanno chiaramente una comunicazione tra loro. Quando in un luogo queste due entità hanno la propria essenza, accade ancora che il primato venga dato alla parte artistica. Per esempio allo Electro Stanislavsky di Mosca o al Teatro Nazionale di Strasburgo o alla Escuela Superior de Arte Dramatico, alla Civica Accademia Nico Pepe, questo accade ancora. E dove c’è questo primato, è possibile sempre che qualcosa nasca: a volte sarà bello, a volte sarà brutto, a volte ci piacerà, altre no… ma questo è su un piano artistico, non su quello personale.
Lei li separa?
Avete presente Glenn Gould? Il suo genio e le sue qualità artistiche sono indubbie. Però Gould considerava Mozart non esattamente un genio, perciò pronunciò la famosa frase: “Purtroppo morì troppo tardi, non troppo presto”. Questo è fondamentale: è una questione artistica. A un artista non interessa un altro artista, non gli piace ma nessuno toglie a Mozart che fosse un artista e un grande artista.
Cosa vuole dire?
Quando noi, come spettatori, andiamo a teatro, anche se non possiamo dirlo pubblicamente, spesso non arriviamo neanche ad avere due posizioni artistiche differenti. Spesso le posizioni artistiche sono proprio assenti. Per questo non c’è proprio neanche niente da dire. Noi ci sforziamo di dire qualcosa sullo spettacolo e per questo molto spesso siamo banali e usiamo il “gerghese” teatrale: “Non è male… Si tratta di ripulirlo un po’! Deve rodarsi, gli attori devono stare in ascolto”. Questo è uno sforzo che facciamo noi, persone sceniche, nella nostra banalità: concretamente là dove non c’è niente da dire dovremmo, e ritorno al punto di partenza, con grande rispetto saper praticare il silenzio . Ma è difficile e rischioso e lo dico in primis a me stesso.

Stanislavsky Electrotheatre
Allora il problema è interno al teatro? Il teatro forse dovrebbe attingere da fuori di se nuova linfa?
Partiamo da una domanda: il teatro è un’arte o no? È una domanda vera! Se lo è, e io credo a ragione che lo sia, ciò che gli pertiene è la sua materia basica: l’azione. Certo come diceva il buon Kostija (nel Gabbiano di Cechov), bisogna cercare nuove forme. Ed è molto probabile che la pandemia sia un tempo molto fertile per questa ricerca. Dobbiamo subito confrontarci con nuove forme: streaming, tv, realtà virtuali? (pausa) Non so. (pausa) Forse si, ma a partire dalla natura essenziale del teatro.
L’innovazione che ruolo ha nella sua idea di teatro? È importante?
Sì, assolutamente: l’arte ha sempre in se la natura dell’innovazione. Deve accadere nel momento e nel luogo in cui siamo. E per questo non potrà che essere innovativa a prescindere dalla tecnologia che usa. A volte è più innovativa quando è più tecnologicamente povera.
In questo senso lei ritiene sia un tema fertile quello delle nuove forme?
Non propriamente. Se davvero crediamo che il teatro sia un’arte, dovremmo cominciare a vedere prima di tutto se c’è qualcosa, nella nostra natura di persone, che veramente ci dà un’ispirazione, dopo di che, eventualmente, come persone sceniche, dobbiamo padroneggiare gli strumenti per realizzarla. Dovremmo averlo chiaro, ognuno per sé, se crediamo concretamente nel teatro. (pausa) Se abbiamo fede nel teatro. E questo non è scontato. Farlo non vuol dire crederci. (pausa) Per questo intuisco che prima del Covid-19 il teatro avesse molti interrogativi irrisolti che erano messi sott’acqua. Ho questa immagine: il teatro era come un pallone da spiaggia, spinto sott’acqua. Il Covid-19 ha semplicemente tolto la mano di chi lo teneva sott’acqua e tutto è venuto prepotentemente a galla.
Da tutto questo intuisco che lei è contrario alle nuove forme?
Se il teatro non è connesso con la propria materia, allora continueremo a dare vita a nuova confusione. Mi sembra che il teatro si chieda sovente in cosa consista la sua contemporaneità. Ha il continuo timore di essere superato da altre forme d’arte e di spettacolo dal vivo molto più tecnologiche. Il teatro vive il “complesso di Trigorin”: i treni passano continuamente ma lui è sempre fermo in stazione e non riesce a prenderne neanche uno. Era il suo incubo.
Il teatro da tempo si chiede in varie forme come può essere moderno, come può essere contemporaneo. Mi sembra che in molti casi cerchi questa contemporaneità fuori da sé, fuori dalla propria essenza, attraverso quello che forse voi giovani chiamate “contaminazione”.

Stanislavsky Electrotheatre
Lei non desidera praticare la contaminazione?
Veramente non so bene cosa sia e quindi non posso essere contro. Però osservo che l’idea che la contemporaneità si trovi fuori dall’essenza del teatro e che quindi il teatro di per sé non possa essere contemporaneo se non va a pescare altrove o se non si snatura si sta diffondendo sempre più. Questo non mi sembra corretto e può dare origine a molta confusione, specie nelle nuove generazioni. Da qui hanno origine tutta una serie di spettacoli fatti da persone che con il teatro non hanno niente a che vedere.
Persone incapaci?
No, non mi riferisco al talento delle singole persone: ma non è la prima volta che sento giornalisti famosi o critici d’arte o professori universitari, scrittori, influencer che dicono pubblicamente: “Ho appena finito il mio spettacolo, era tutto sold out”. Ed è vero, era tutto sold out! Cosa che agli attori riesce con maggiore difficoltà. E rispetto a questo, le persone di teatro come si posizionano? (pausa) A volte in concorrenza. E anche questo mi sembra un errore: allo stesso modo, io potrei pretendere di fare un editoriale su un giornale nazionale, e ne avrei anche facoltà perché, grazie al mio passato scolastico, conosco piuttosto bene la perifrastica attiva e la consecutio temporum. Per certi aspetti, nel mondo del teatro, specie in quello occidentale, queste incursioni avvengono di frequente: questo secondo me avviene per quei problemi di cui parlavamo e ci riguardano in quanto persone sceniche. Non dobbiamo arrabbiarci con il giornalista o con il critico d’arte: lui non c’entra nulla, occupa correttamente tutto lo spazio che gli viene concesso di occupare da noi in quanto spazio privo di essenza. Se demandiamo la nostra contemporaneità ad altri che non sono esperti di azione, gli altri giustamente riempiranno il nostro “spazio” che invece alcune volte dovremmo avere l’arditezza di lasciare vuoto. (pausa) Dobbiamo riacquistare il coraggio di poter lasciare lo spazio vuoto. (pausa) Vivo ma vuoto. Senza avere l’obbligo di riempirlo a tutti i costi.
Quindi lei cosa suggerisce di fare?
Non ho la pretesa di avere la soluzione, ma vedo la prospettiva. Se le persone che vogliono dedicarsi al teatro non tornano alla sua essenza, se non si alimentano a partire da questa stessa essenza, allora avremo poche possibilità di incontrarci in un teatro vivo in cui credere.
Lei invoca spesso questa essenza e questa natura del teatro: in concreto di cosa sta parlando?
Dell’azione. Io lo capisco così: l’aritmetica del teatro è che “uno più uno fa tre”. Non è un’aritmetica “uno più uno fa due”, ovvero l’aritmetica della logica umana. In quello strano spazio dimensionale che chiamiamo teatro, vige un’altra norma. Accade qualcosa di diverso: non avviene che attori più spettatori uguale due, no! C’è qualcosa tra loro e questa non è una mia invenzione, è nella natura intrinseca di quello spazio dimensionale. (pausa) La natura dell’uomo agente è qualcosa che appartiene alla natura umana. È una qualità che abbiamo atavicamente, non è un’invenzione. Se togliamo questa natura agente all’attore, non abbiamo più niente dell’essenza del teatro. Su tutto il resto possiamo ampiamente discutere, per esempio sul fatto che io ho la mia estetica e mi piace il tal regista, o che con questo o quel attore lavoriamo insieme, mentre il talaltro non mi interessa. Ma tutto questo deve arrivare dopo: può venire solo se già è presente in scena la natura agente dell’uomo. In Europa, ma in Italia di più, questo viene considerato per una questione di rapporto tra persone e non una posizione artistica tra due persone sceniche. Ma sono due cose che appartengono a due ambiti differenti.
Siamo tornati alla sua argomentazione sulla questione personale: l’aspetto dell’individualità personale non riguarda l’arte?
Certo che la riguarda, ma non sul piano individuale. È tutto molto più semplice. Dobbiamo artisticamente, e parlo a me stesso, accettare che non tutti i quadri di Van Gogh sono venuti bene. Neanche tutti i film di Fellini sono dei capolavori e possiamo dirlo senza timore. Ma questo non toglie nulla alla genialità di Van Gogh e Fellini, anzi. È proprio nella natura brutale e spontanea della creatività che alcune opere possano avere una prospettiva e altre no. Il processo artistico non può essere come il Papa: infallibile! Mi sembra che il teatro soffra da tempo di un enorme complesso di infallibilità: ogni spettacolo deve venire bene. Ma non credo che questo ci aiuti. Tutto dovrebbe partire dalla nostra posizione artistica: dovremmo poter arrivare al punto di poter dire: “Questo mio spettacolo onestamente bisogna chiuderlo, non c’è più la natura agente dell’uomo”. Ma è una posizione artistica notevole, che troverà molte opposizioni concrete sia individuali (degli attori) che organizzative (la produzione, le tournée, i cartelloni).
Allora qual è il futuro che ci attende in teatro? Cosa possiamo fare per il teatro del futuro in Europa e in Italia?
(pausa) Per prima cosa dovremmo fare un passo indietro. È fondamentale. Facciamo un passo indietro, ritorniamo alla natura elementare e semplice del teatro. Questo può sembrare un paradosso: arretrare. Ma per fare una grande salto in avanti bisogna prima preparare un passo indietro. Proviamo a fare un passo indietro per fare un grande salto in avanti.
Adesso però vorremmo delle risposte a delle domande che sono scaturite dalle sue riflessioni durante i nostri silenzi ora.
Vediamo se sono in grado di rispondere.

Stanislavsky Electrotheatre
Provocatoriamente, lei crede che potrà proporre in futuro un suo spettacolo in modalità digitale?
Il digitale non è un mostro, non è un l’idra di Lerna da cui scappare. Sono sempre stato attratto dall’applicazione di nuove tecnologie all’azione. Peraltro sono tutte cose già ampiamente proposte in ambito teatrale: l’utilizzo delle realtà virtuali e dei video non nascono oggi, con il Covid-19, anzi. Ho già usato il digitale in alcuni lavori. Contemporaneamente credo che per il momento il teatro, esattamente per quell’aritmetica del “uno più uno uguale tre”, abbia la necessità che si incontrino persone vive. Questo non vuol dire che come lo abbiamo fatto fino a ieri fosse la strada più interessante, intendo dire più “viva”. Per esempio parliamo degli spazi teatrali che adesso sono al centro delle problematiche di affollamento. (pausa) Rilevo che anche prima di questi problemi legati al Covid-19 questi spazi mi ponevano degli interrogativi importanti: ci sono luoghi teatrali che già per la loro geometria spaziale impediscono che alcuni conflitti avvengano. Allora forse bisognerebbe cominciare a ripensare gli spazi teatrali, specie quelli istituzionali.
Cosa intende?
Allo Stanislavsky Electrotheatre di Mosca, dove lavoro da due anni e dove lavorerò anche nel 2021 con una regia shakespeariana, lo spazio è qualcosa di speciale. Lì, insieme al direttore Boris Yukhananov, che ringrazio ancora per avermi dato tempo e modo di lavorare con tutto il suo staff, abbiamo fatto un progetto enorme su Pinocchio: una performance composta di cinque spettacoli scritto da un drammaturgo Andreij Vishnevskij con cui è nato un sodalizio artistico, una grande stima reciproca.

ПИНОККИО allo Stanislavsky Electrotheatre
Bene, cinque anni fa questo teatro è stato totalmente ricostruito grazie al pensiero avveniristico di Boris Yukhananov: ora è uno spazio altamente tecnologico, all’avanguardia in Europa, con la platea continuamente smontabile e componibile. Non c’è un involucro rigido e statico da cui comincio a vedere se e come riesco a utilizzarlo. In quel teatro puoi costruire lo spazio a partire dall’azione a cui vuoi dare vita come regista: è estremamente tecnologico, con un sistema di audio e suono di altissima qualità perché fanno anche molti concerti di musica elettronica contemporanea. La tecnologia è al servizio, come tutti noi, dell’azione. Questo credo sia un teatro altamente innovativo.
Quindi lei crede che il suo teatro si possa sviluppare solo fuori dall’Italia con artisti non italiani?
No. Ci sono bravissimi artisti italiani, ma molti di loro lavorano con più attitudine fuori dall’Italia. Ma sono fiducioso che questo cambierà. Tanto per essere chiari: allo Stanislavskij Electrotheatre oltre al direttore Yukhananov, oltre a molti giovani e bravi registi russi, ci sono due italiani che lavorano lì con una certa frequenza: uno è Romeo Castellucci, l’altro sono io. E questo è merito della visione di Yukhananov. Lo si vede negli artisti che invita e lo si vede dallo spazio teatrale che ha ideato e costruito. È una visione di teatro. Non ha a che vedere con una nazionalità.
Ha a che vedere con la ricchezza e la relazione attore spettatore dal vivo di cui parlava prima?
Sì, credo che debba esistere sempre “”uno più uno uguale tre”. Usando tutta la tecnologia che riteniamo necessaria, ma sempre diretta con persone che si incontrano per condividere. Diversamente mi sembra che manchi la materia basica. Per esempio lei crede che potremmo fare una messa in streaming?
Perché no? Potrebbe essere una buona proposta?
Anche io! Mi pare che esistano anche già le scatoline con la voce del defunto Papa Giovanni Paolo II che dice il rosario e dà l’assoluzione dai peccati. È nella modernità della Chiesa? (pausa) Forse. Ma ci possiamo dire almeno tra noi, senza scomodare altri, che non esiste nulla del sacramento della confessione in una scatolina che ti dice “ed io ti assolvo dei tuoi peccati in nome del Padre…” Perché se è un sacramento, dovrebbe esistere l’intermediazione tra l’uomo e qualcosa che va oltre l’uomo, qualcosa di metafisico. Questa intermediazione è fatta a sua volta da un altro uomo: il celebrante, la persona scenica. Forse facciamo fatica ad accettarlo in questo momento, ma questo è quello che ci pertiene rispetto al teatro e che dovremmo provare a fare: creare un’intermediazione, in senso positivo, tra l’uomo e ciò che va oltre l’uomo. Certo, in modo molto concreto, a volte questa intermediazione non avviene, non funziona. Ma noi non dobbiamo rammaricarci: l’intermediazione non è infallibile. Quando avviene è una sorta di miracolo e dobbiamo contemplarlo e gioirne. Allora quando parliamo di streaming io non sono contrario a priori, altrimenti non avrei fatto di recente una Masterclass che ha visto partecipare più di 50 attori da tutta Europa. Penso però che il teatro abbia ancora il valore di un rito e il rito ha bisogno di persone vive, perché il rito avviene in quel momento e in quel luogo. Non altrove. Qualcosa deve manifestarsi contemporaneamente per l’attore e lo spettatore. (pausa) È una epifania. Questo, per me, non è derogabile. (pausa) Magari posso sbagliarmi, magari in futuro chiameremo teatro qualcosa che sarà fatto dai robot, già forse siamo sulla buona strada, ma credo che la presenza dell’essere umano, come persona e come persona scenica in carne e ossa, è indispensabile.
Forse in questo senso il teatro, come rito, è un luogo in cui il virus non entra?
Non credo. Non so se augurarmi che il teatro sia veramente asettico, non contagiato. Può darsi che il teatro sia un positivo asintomatico, cioè infetta ma non sa di infettare o perlomeno non ne ha idea. In fondo il teatro stesso è un virus che contagia irrimediabilmente alcune persone.
Lei prima ha parlato di un teatro che esiste e non sussiste, che può nutrirsi nel silenzio. Allora un tale teatro non ha un rapporto diretto con il pubblico? Può fare a meno del pubblico? Un tale teatro può astenersi dal fare?
Credo che questo tempo di stop forzato non ha a che vedere con il fatto di non fare nulla. Mio nonno era contadino e sapeva benissimo che a scacchiera ogni anno doveva lasciare una fetta di campo a erba. E questa scelta, che sembra assurda e improduttiva perché l’erba non vale niente, in realtà era indispensabile per rendere ricca la terra e il campo per l’anno successivo: bisognava lasciare, si dice in gergo contadino, che la terra riposasse perché potesse essere più fertile nel futuro. Io credo che questo tempo per il teatro sia stato, e forse è già finito, un tempo utilissimo per arricchire, per seminare, per coltivare ciò che verrà dopo il Covid-19. È quello che ho voluto fare per esempio con quella enorme Masterclass: l’idea non è stata di fare un corso, non ne avevamo nessun bisogno, ma di incontrarci con tre grandi autori (Cechov, Pirandello, De Filippo) e attraverso l’azione seminare qualcosa per noi per domani provare a donarlo al teatro.
A proposito di grandi autori classici. Lei lavora anche con autori contemporanei? Quali?
Si, molto spesso. Mi sembra abbastanza strano suddividere i drammaturghi in classici e contemporanei. Gli autori sono come il vino: o è buono o non è buono. Poi che sia di una annata particolare o meno, ha valore solo per il suo contenuto e per la sua specificità. Ho lavorato e lavoro direttamente con molti autori contemporanei con cui spesso è nato un sodalizio artistico: Spregelburd, Tolcachir, Vishnevskij, Domenech, Bezerra, Majorga eccetera. La qualità di un drammaturgo di scrivere per l’azione non dipende dall’epoca in cui scrive, ma dal suo talento. Questi drammaturghi scrivono in modo molto diverso uno dall’altro: il loro processo di scrittura è diverso. Ma tutti sono ricchi di talento ed è un piacere lavorare con loro direttamente. Scoprire l’azione nelle loro drammaturgie e trovare il processo perché possa manifestarsi in scena è ogni volta una sfida artistica irrinunciabile.
Un’ultima domanda: se l’artista Nardin di oggi potesse parlare con l’artista Nardin degli esordi cosa gli direbbe? E aggiungo il Nardin degli esordi cosa direbbe a lei oggi?
Questo è un gioco? Allora le rispondo così. Se se potessi parlare con il mio io degli esordi, non gli direi niente: forse gli tirerei due schiaffi con amore. Il giovane Nardin al vecchio Nardin probabilmente direbbe a ragione: “Spostati che tocca a me andare in scena, lasciami fare.”
Però ci tengo a dire una cosa: quando ho cominciato, ero un giovane di qualche bella speranza e di una certa presunzione. Questa presunzione paradossalmente è stata fondamentale, mi ha spinto. Ma devo molto ad alcuni incontri che mi hanno donato artisticamente, poi anche umanamente, una grandissima quantità di cose con grande qualità. Adesso dirò una cosa molto pericolosa per il teatro occidentale. A un certo punto della mia strada sentivo una incapacità, una mancanza di strumenti. Mi rendevo conto di alcune cose che avrei voluto realizzare ma che concretamente non ero in grado di fare. Come un anelito, come una persona che ha un disegno meraviglioso in testa ma non sa come realizzarlo. La mia fortuna fu che, esattamente nel momento in cui ebbi la consapevolezza che il teatro che stavo facendo mi aveva stancato, incontrai un vero grande Maestro.
E posso dirle che il maestro appare solo quando l’allievo è pronto, non viceversa. Se a voi italiani non piace la parola “allievo”, sceglietene un’altra. Nessun maestro può apparire se l’allievo non ne sente la necessità. In altri termini: è l’allievo che deve essere nella posizione di scegliere il maestro. Poi il maestro lo può accettare oppure no, ma il movimento deve nascere dall’allievo verso il maestro. Questo è uno dei grandi problemi del teatro europeo occidentale e qui risiede anche molto della questione pedagogica. Il giovane Nardin ha avuto questa fortuna e devo ancora una gratitudine artistica enorme a una persona in particolare, con cui lavoro ormai da più di dieci anni continuativamente: Anatolij Vasil’ev. Il giovane Alessio non conosceva questo passaggio artistico, il vecchio Alessio ha avuto la fortuna di viverlo giorno per giorno.
Natasha Isaeva | Il teatro sgonfiato dalla pandemia

Natasha Isaeva
Si sa, Antonin Artaud nel suo saggio Il teatro e la peste (Le Théâtre et la peste) (da Il teatro e il suo doppio) ha scritto:
Quando la peste entra in una città, il quadro chiaro della società si scioglie, non ha più servizio stradale, esercito, polizia, amministrazione della città; a seconda della disponibilità di mani libere nei diversi luoghi, i falò iniziano a bruciare i morti… La peste prende immagini dormienti, nascoste nel degrado, e le porta improvvisamente ai gesti più estremi; e proprio come la peste, il teatro prende i gesti e li porta all’estremo: come la peste, crea una nuova catena di connessione tra ciò che è e ciò che non è ancora possibile, tra la virtualità del possibile e ciò che esiste nella natura materializzata.
Prima di tutto l’“essenza” del teatro, la sua anima più intima, di cui tutti noi stiamo parlando, deve in qualche modo esistere nella nostra “esperienza”. Non sto parlando di un qualche tipo di risposta emotiva. Anatolij Vasil’ev, sia nella sua pedagogia sia nelle sue produzioni teatrali, apprezza soprattutto la possibilità di toccare con mano la vita viva e pulsante all’interno dell’artista. Se sul palco questa vita c’è, ci sarà sicuramente una risposta da parte dello spettatore, dell’ascoltatore… Se lo tocchi, se sei anche leggermente graffiato da quell’amo, sei già preso.
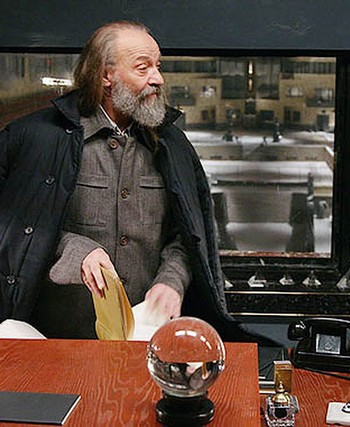
Dau: Anatolij Vasil’ev nei panni di Anatolij Krupitsa
Nell’esperienza del progetto cinematografico Dau, dove Vasil’ev era direttamente coinvolto (anche come attore), quella realtà artistica si trovava da qualche parte tra il teatro e il cinema, e tutto era basato su questo tipo di presunzione: l’interprete e lo spettatore devono prima sperimentare qualcosa insieme… è una sorta di radiazione… (Vedi anche Dau di Ilya Khrzhanovsky, ovvero il comunismo sovietico come opera d’arte totale e Post-scriptum: la partie parisienne du projet Dau sous son angle théâtral. Avec Anatoli Vassiliev)
Antonin Artaud stava parlando di essere “infettato”, e Artaud di pratica teatrale ne capiva qualcosa… Qualsiasi esperienza – se è genuina, cioè se è abbastanza dolorosa e abbastanza cruda, ma allo stesso tempo se si suppone che ci dia un piacere puramente artistico, quasi sensuale – rivela certamente qualcosa in noi. Qualcosa che prima non sapevamo di noi stessi, o meglio qualcosa che non volevamo guardare e in cui avevamo paura di credere.
Questo è il vero segno, il marchio di fabbrica di un buon regista teatrale! Essere in grado di influenzare l’energia grezza in un artista, iniziando gradualmente a concentrarla da qualche parte… Allora puoi intuire, puoi sentire il vettore interno, puoi sentire la direzione… In sostanza, è come costruire un camino, una cappa aspirante, attraverso la quale il vento ronza con una forza terribile! La cosa più importante qui è la sublimazione di quell’energia, che spesso deriva dal chakra più basso (muladhara), situato alla base della colonna vertebrale. Energie crude, oscure, non sempre trasparenti per l’attore stesso, per lui opache… Energie del sole nero, quasi fisiologiche, che hanno origine da attrazioni oscure e connessioni pericolose, e ogni volta che freniamo quegli impulsi primari con qualcosa di politicamente corretto, ogni volta che li censuriamo in anticipo – sia attraverso la moralità accettata o attraverso le istituzioni statali – ci stiamo già privando dell’opportunità di andare avanti, verso l’alto – su per questo canale.

Dau. Il ritorno del figliol prodigo: Anatolij Vasil’ev (Anatoli Krupitsa) e il protagonista Theodore Currentzis (Dau)
Non ho nemmeno provato a decidere da sola se la storia di Dau somiglia alla vita reale, se la ricostruzione corrisponde al periodo storico. Lo stavo afferrando a un livello viscerale: era come se ci fosse qualcosa davanti a me, un protoplasma vivente che vibra e si accende – e io vibro insieme a esso, in risonanza. Non un puro documento, ma quella che chiamiamo una “composizione artistica”, o finzione. Qualcosa che provoca immediatamente un curioso distillato di sensualità. Con l’inclusione di un elemento performativo molto forte (e io sono stata effettivamente in presenza e co-performer in quel progetto, per esempio traducevo durante gli études di Vassil’ev, quegli esercizi dove tutto è creato in libertà, senza un testo memorizzato, anche se questa libertà all’inizio sembra essere un po’ goffa e imbarazzante). È molto diverso da una vita naturale… È più simile a un’esperienza voyeuristica… Questo è il motivo per cui l’esperienza di Dau, nella sua interezza, esiste in mezzo, da qualche parte nel mezzo – tra documentario e finzione, tra teatro (con potenti inclusioni performative) e cinema…
Dopo aver vissuto questa esperienza, quando quasi ogni giorno c’è uno spettacolo che possiamo guardare online, quando abbiamo il meglio della scena contemporanea sul nostro monitor, posso dire che, almeno per me, un teatro completamente privo dell’elemento performativo (che è il vero sale della vita stessa) ha in qualche modo cessato di esistere. Non mi tocca né mi ferisce più.

Natasha Isaeva
Non posso fare a meno di pensare che quella è stata l’ultima volta in cui abbiamo avuto questo tipo di esperienza… Adesso, quando vediamo uno spettacolo sullo schermo, ammiriamo una texture che è già scomparsa – una costola di mammut, un osso di pesce fossile. Non ci sarà più permesso di fare un’esperienza di quel genere!
Il mondo sarà molto più semplice… Qui in Francia è già diventata un’esperienza pressoché quotidiana: quasi tutto il discorso universitario e culturale è diventato politicamente corretto, l’arte teatrale sta lentamente morendo – e tutti sembrano felici! Per me il teatro psicologico tradizionale, che qui è riconosciuto e accettato, è già molto più semplicistico. Anche se in linea di principio è più accessibile, più popolare. E temo che dopo lo shock generale della quarantena (sia psicologico sia socio-economico), tutti i difficili tentativi di creare strutture teatrali complesse, basate sulla pura energia liberata degli artisti, non sopravviveranno – o sopravviveranno in uno stato molto più mutilato e inibito… Le persone sono esauste, sventrate, nervose e optano per scelte più semplici. E’ comprensibile.
Temo che il “Brave New World” verso il quale ci sospinge la quarantena non ci piacerà! È strano che nessuno dei protagonisti nel campo dell’arte, della letteratura o della filosofia sembri pensarci. Mancino giurato nelle sue convinzioni, il filosofo italiano Giorgio Agamben teme soprattutto l’aumento della pressione della polizia e della violenza di Stato, oltre che la possibile ascesa del neofascismo. Il regista teatrale tedesco Matthias Langhoff, che ha lavorato in Francia per tutta la vita, propone seriamente ai suoi colleghi di andare in giro in un furgone con un minimo di oggetti di scena e di dare spettacoli per i contadini riconoscenti delle campagne…
E ho molta più paura che noi – l’intellighenzia, il popolo dell’arte – saremo i primi a essere gettati via da questo pallone di cultura… Tutto sarà molto più semplice, divertente e accessibile! Gli eventi saranno ritagliati in modo più uniforme e fluido, praticamente ovunque… Vedo una società in cui nessuno vorrà essere difficile, dove cittadini riconoscenti preferiranno un intrattenimento moderato e universalmente accettato. Non ci saranno più soldi da buttar via per i trucchi rischiosi e complicati, per i ghiribizzi da artista…
Sono così terribilmente, quasi peccaminosamente affezionata al recente teatro d’avanguardia, con i suoi audaci collage postmoderni di diverse tecniche, con i suoi elementi performativi e le scenografie complesse e su più livelli. Un teatro così folle, non ovvio, non per tutti… Ma richiede fede – e richiede denaro. Piango come la povera Elsa nella favola dei fratelli Grimm, perché prevedo la semplificazione universale, la stanchezza generale… Vedo la tanto attesa ripresa come il tempo delle economie universali e come un nuovo Puritanesimo imposto dalle circostanze.
E penso che abbiamo già perso il nostro pubblico. Il pubblico in senso lato: tutti coloro che hanno prestato attenzione, ascoltato, e si sono lasciati trasportare… Preferire entrare in una sala per un concerto, assistere a un semplice dramma borghese, o magari seguire una sitcom. L’abbiamo sedotto con un certo successo per un po’, ma adesso è finita. Un pubblico stanco delle complicazioni ci abbandonerà volentieri, per andarsene dove ha sempre voluto andare, con un sospiro di sollievo… Tutte le seduzioni e le abitudini sociali acquisite nel mondo di prima cadranno a pezzi da un giorno all’altro… E all’improvviso le persone normali e “ordinarie” si renderanno conto che gli intellettuali, tutti quei pervertiti occhialuti, alla fine si sono semplicemente incasinati con le loro teste! E quegli stessi intellettuali avevano già preparato la strada con la loro correttezza politica, il loro cupo femminismo e la loro esagerata preoccupazione per la sicurezza morale e psicologica…
Solo che ora questa strada ci sarà imposta, frutto del comprensibile desiderio di buttare via il lievito e il sale dalla società. Perché i filistei sono sempre stati istintivamente contrari all’allentamento delle fondamenta, ed sono lì da sempre a difendere le gerarchie sociali e i valori familiari… Insomma, contro la libertà e la sperimentazione artistica! Ritorneremo dalla quarantena in un mondo diverso. Il virus, come spesso accade, sta semplicemente accelerando i processi…
Tag: coronavirus (99), KhrzhanovskyIlya (2), Stanislavsky Electrotheatre (3), VasilevAnatolij (4)








