Post-modern Eschilo, ovvero la rinascita della tragedia
La perdita del senso profondo del tragico pare uno dei sintomi tipici della modernità. Oggi tendiamo a “pensare ai miti e alle tragedie in cui i miti si incarnano semplicemente come un repertorio di classici a cui il teatro del Novecento ha potuto attingere”, tratte da “un passato primitivo e remoto da cui la storia si è definitivamente emancipata, o a uno schermo su cui il pensiero moderno ha proiettato un senso ancestrale del divino”, come nota Daniela Sacco nel suo Mito e teatro. Il principio drammaturgico del montaggio (Mimesis, Milano-Udine, 2013, p. 9). Tuttavia continuiamo a mettere in scena le antiche tragedie, senza però ritrovare la pienezza dell’esperienza.
Il rischio è di ridurre i classici a un repertorio di trame, di fabulae per quanto variabili, modificabili e adattabili a contesto sempre diversi. Al di là della ricognizione delle trame, la questione che andrebbe posta è eminentemente filosofica: si tratta di entrare nel meccanismo creativo della composizione teatrale, di comprenderne la struttura e di capire il rapporto che si instaura con la visione del mondo contemporanea.
(Sacco, cit., p. 184)
La fine del tragico è da tempo tema di riflessione critica: a distanza di pochi anni, la decretavano George Steiner (La morte della tragedia (1961), Garzanti, Milano, 1995), e Ludwik Flaszen, il “consulente letterario” degli spettacoli di Jerzy Grotowski:
L’avanguardia degli anni Cinquanta ha dimostrato l’impossibilità della tragedia tradizionale in teatro. La tragedia è possibile solo quando i valori hanno avalli trascendenti, percepiti come sostanziali. Quando muoiono gli dei, la tragedia è rimpiazzata dal grottesco, dalla smorfia dolente del buffone che fronteggia un cielo vuoto. I presupposti dell’avanguardia sono irrefutabili: oggi, la tragedia tradizionale è prosciugata, altezzosa o retorica o triviale melodramma sentimentale. Sicché chiediamo: come attingere una dimensione tragica in teatro che non sia né una posa pittoresca e morta né una banalità? Come attingere l’antico sentimento che abbinava pietà e terrore, oggi perduto nella nostra memoria emotiva?
(Ludwik Flaszen, “Dopo l’avanguardia” (febbraio 1967), ora in Grotowski & Company. Sorgenti e variazioni, Edizioni di Pagina, Bari, 2014, p. 148)
Per Grotowski (e Flaszen) “una risposta grezza è: sovvertire definitivi ed elementari valori. In ultima istanza, uno di quei valori è l’integrità dell’organismo umano. Quando non resta altro, l’estremo rifugio della dignità è il corpo umano, un organismo vivente, garanzia materiale dell’identità individuale e della sua autonomia nel mondo” (ibid.). La suggestione della riscoperta del corpo ha ispirato molto teatro a partire dagli anni Sessanta, dall’Antigone del Living Theatre a Dyonisus in 69 di Richard Schechner (su questo vedi Edith Hall, Fiona Macintosh e Amanda Wringley (cur.), Dionysus Since 69. Greek Tragedy at the Dawn of the Third Millennium, Oxford University Press, Oxford, 2004).
La strada imboccata da Daniela Sacco per ritrovare oggi il senso profondo del tragico prende una direzione molto diversa, in apparenza opposta, mettendo in cortocircuito l’origine greca del teatro e il suo approdo contemporaneo, prima nelle avanguardie storiche del primo Novecento e poi nelle ultime avanguardie teatrali. Tentativi che hanno utilizzato come grimaldello non la parola, o il corpo, ma l’immagine.
All’origine, Aristotele pone la tragedia in dialettica con il mito, ovvero con l’epos, con il racconto, che rappresenta “l’elemento più importante dell’arte tragica, più delle altre parti che costituiscono la tragedia, più dei caratteri, del linguaggio, del pensiero, della musica e della vista. (…) Il mithos è il fine (τέλος) della tragedia, ne è il principio (αρχὴ) e l’anima (ψυχὴ)” (Daniela Sacco, cit, p. 17).
Ma come si passa dal mito alla tragedia, per (ri)trovarne l’anima?
E’ testimonianza di Ateneo l’attribuzione a Eschilo dell’affermazione secondo cui il suo lavoro si limitava a “raccogliere le briciole del banchetto omerico”. (…) Briciola è il frammento strappato alla trama offerta dalla tradizione epica, dal patrimonio culturale comune dei Greci, di cui poteva disporre il tragediografo. (…) L’operazione del primo tragediografo della storia consiste quindi nel raccogliere un frammento della tradizione epica e utilizzarlo in una nuova combinazione, quel frammento costituisce il fatto (τό πράγμα) (…) che la nuova composizione (σύνθεσις) collega in una trama, in una nuova combinazione, tale da avere la capacità di dire gli universali.
(Sacco, cit., p. 18).
Daniela Sacco stana insomma un Eschilo post-moderno, che nella scrittura drammatica del mito (o meglio, nella sua riscrittura) procede accostando frammenti, come farà 2500 anni più tardi, tra gli altri, Heiner Müller con i suoi Materiali per Medea.
L’idea di frammento è centrale anche per comprendere il rapporto del teatro con Dioniso, “il dio-fanciullo i cui attributi sono i giochi, i balocchi regalati dai Titani per distrarlo” prima di smembrarlo. Perché Dioniso “è anche il bimbo che giocando con lo specchio lo manda in frantumi, e in questi frantumi si riflette scorgendo la pluralità del mondo. (…) L’atto del bambino è sovversivo, è rivoluzionario” (Sacco, cit., p. 59).
Di conseguenza, emerge anche un Eschilo cinematografico, che ricompone i frammenti del mito con un sapiente montaggio (e forse è anche per questo che Shakespeare al cinema funziona così bene…). Si evoca così un fondamentale snodo storico novecentesco: la “scoperta” del montaggio da parte di Sergej Ejzenštejn, il passaggio teorico (Teoria del montaggio, Marsilio, Venezia, 2004) che precede il passaggio “pratico” dalla regia teatrale a quella cinematografica (vedi in particolare Sacco, cit., pp. 130-139). La “conversione” di Ejzenštejn è sintomo di una svolta epocale, svolta gravida di conseguenze:
Il montaggio risulta essere (…) la “forma simbolica” del pensiero della postmodernità, così come lo è stata, nella definizione che ne ha dato Erwin Panofsy mutuando un’espressione di Ernst Cassirer, la prospettiva nel Rinascimento per la modernità.
(Sacco, cit., p. 72)
Come abbiamo visto, la tragedia, e in genere il teatro nella sua essenza più autentica, procedono per montaggio di frammenti. Questo linguaggio non parla all’intelletto, alla razionalità: è un “pensare per immagini”, che ha una lunga storia. Daniela Sacco ne insegue le tracce: dalla “morfologia goethiana” alla psicoanalisi di Freud e Jung (perché l’inconscio parla per immagini), dall’Ulisse di Joyce (la rivisitazione di un mito, alla quale proprio Ejzenštejn dedicò un’illuminante lettura) alle “pathosformel” di Aby Warburg e del suo Atlante della memoria (perché anche l’arte parla per immagini). E cita en passant quel piccolo capolavoro dimenticato che è L’abbicì della guerra. Immagini della seconda guerra mondiale di Bertolt Brecht (1955, Einaudi, Torino, 2002).
Il culmine di questo percorso (che per certi aspetti ribalta il celebre motto di Freud, “Là dove c’era l’Es ci sarà l’Io”) è l’approdo “pagano e politeista” James Hillman, che gli permette di riappropriarsi dell’antico volto del mito. Per lui, il mito è
immaginale o memoria: le forme e le immagini del mito che la cultura occidentale ha storicamente negato ma con cui deve inevitabilmente, per l’urgenza del presente, tornare a fare i conti. Quelli che per la filosofia postmoderna sono nichilisticamente intesi come ‘cocci’, i frammenti risultanti dallo sgretolamento della ragione, per la psicologia sostenuta da Hillman al seguito di Jung sono le immagini; immagini che hanno un valore assolutamente irriducibile al pensiero nichilista.
(Sacco, cit., p. 92)
La svolta che porta a un consapevole “pensare per immagini” è determinata da due eventi, che agiscono su due diversi piani. Il primo è lo shock determinato dall’avvento di una tecnologia come il cinema, che “spiazza” radicalmente tutta l’arte moderna, obbligandola a un radicale ripensamento. Basti pensare ai collage cubisti di Braque e Picasso, al vertiginoso Nu descendant un escalier di Marcel Duchamp o alla Città che sale o a Forme uniche nella continuità dello spazio di Umberto Boccioni… E poi – quasi contemporanea alla diffusione del nuovo medium – c’è la catastrofe delle due guerre mondiali.
Che la Grande Guerra abbia rappresentato uno spartiacque nel mondo contemporaneo, provocando una frattura nel corso storico e la profonda trasformazione del paesaggio mentale, è una riflessione ormai matura. (…) L’”idea della simultaneità”, l’”affermazione della pluralità di spazi e tempi”, l’”affermarsi della realtà del tempo privato”, il “livellamento delle gerarchie spaziali tradizionali” sono tra le più importanti emergenze mentali che Kern associa alle principali rivoluzioni sociali: il livellamento delle gerarchie, lo sgretolarsi della coscienza aristocratica, l’ascesa della democrazia.
(Sacco, cit., p. 84)
“Se i classici sono morti”, si chiederà Brecht nel 1928, “quando sono morti? La verità è questa: sono morti in guerra – sono anch’essi vittime della guerra”. Vent’anni dopo, tra le macerie della Seconda guerra mondiale, dopo Hiroshima e Nagasaki, diventerà legittimo interrogarsi con Adorno se è ancora possibile scrivere poesia dopo Auschwitz.
E’ dunque inevitabile che la riflessione sul mito e sul teatro s’intrecci con quella sulla storia, e in particolare con le intuizioni di Walter Benjamin: “La storia torna a essere leggibile perché attraverso il montaggio si produce una vera e propria conoscenza, una conoscenza che sembra essere alternativa a quella presupposta dalla scienza moderna” (Sacco, cit., p. 122). Nel suo (incompiuto) Passagen-Werk Benjamin userà dunque il montaggio (Montage) per “erigere le grandi costruzioni sulla base di minuscoli elementi costruttivi, ritagliati con nettezza e precisione. Nello scoprire, anzi nell’analisi del piccolo movimento singolo, il cristallo dell’accadere totale” (Walter Benjamin, I “passages” di Parigi, Torino Einaudi, 2010, p. 515, fr. N 2, 6).
Sulla scena, sarà il Living Theatre a ritrovare l’equilibrio tra mithos e logos, tra immagine-corpo e parola, tra “minuscoli elementi costruttivi” e “accadere totale”, conciliando Artaud e Brecht. Quello inaugurato dal Living è un teatro che rifiuta la rappresentazione (la mimesi della realtà) e l’immedesimazione attoriale: da lì il nuovo teatro “anti-aristotelico” approderà alla “scrittura scenica” lanciata da Giuseppe Bartolucci e al “teatro post-drammatico” teorizzato da Hans-Thies Lehmann. Per Julian Beck (formatosi come pittore) e Judith Malina (allieva di Erwin Piscator, il regista che usava i filmati nei suoi spettacoli), “la creazione o l’individuazione di immagini e il loro assembramento procede di pari passo alla costruzione dello spettacolo” (Sacco, cit., p. 185).
Per concludere e dimostrare la forza della sua tesi, Daniela Sacco approfondisce due casi esemplari. Il primo è Robert Wilson, paradigmatico anche per Lehmann, che parla di teatro “neo-mitico”,
intendendo per miti le immagini che fanno parte del “cosmo immaginario” e non sono portate sulla scena nella loro consistenza di azioni ma “con la loro logica pre-razionale” e come immagini virtuali che si offrono alla vista e alla sensibilità piuttosto che al racconto, Sono immagini mitiche indifferentemente Medea o Prometeo, Einstein e Freud, piuttosto che Stalin e Faust, tutte figure che compaiono in forme diverse nei suoi spettacoli, e tutte riassorbite nel contesto virtuale di un catalogo d’immagini della storia dell’umanità.
(Sacco, cit., p. 197)
I Knee Plays, i frammenti di spettacolo che raccordano le diverse parti degli spettacoli di Wilson “sono elementi di frattura, di intervallo, ma allo stesso tempo sono elementi di sutura, di relazione e collegamento. La frammentazione è un processo ambivalente, nella separazione e nell’intervallo c’è al tempo steso la coordinazione, la relazione, il collegamento, il dialogo tra le parti: in questa duplicità sta il principio del montaggio” (Sacco, cit., p. 206). Il secondo artista citato da Daniela Sacco è Peter Sellars, che critica Wilson per la scarsa “presenza morale” e che nelle sue riletture dei classici recupera una esplicita dimensione politica. In ogni caso, “anche relativamente alla natura eminentemente poietica del teatro, Sellars afferma che il suo lavoro implica ‘la creazione di un autentico sistema mitologico, in cui risuonino una serie di immagini, e che permetta a una certa società di parlare a se stessa’” (Sacco, cit., p. 212).
Manca da questa ricognizione il creatore che forse più esplicitamente sta lavorando sul recupero della tragedia attraverso le immagini (ed escludendo quasi del tutto il logos). Il suo obiettivo è il recupero di una drammaturgia “pre-socratica”, che vuole indurre nello spettatore proprio la “pietà e terrore” che Aristotele individua come effetti del percorso catartico. La Tragedia Endogonidia di Romeo Castellucci è costruita attraverso l’accostamento e la contrapposizione di figure teatrali di forte impatto, attraverso il montaggio “musicale” dei diversi elementi. E’ un procedimento che accomuna il lavoro di registi molto diversi, da Jerzy Grotowski a Eugenio Barba, da Tadeusz Kantor a Robert Lepage, da Pippo Delbono (che nell’ultimo Orchidee lavora proprio sull’interazione tra immagine video e scena teatrale) al “montaggio delle trasgressioni” di ricci/forte.
E’ una sapienza insieme antica e moderna, che attraversa l’intera storia del teatro. Il montaggio è un principio riconoscibile nella tragedia antica, nel cinema ma anche nel teatro post-drammatico. Va sottolineato che il tragico non sta nella singola immagine, nella figura in sé, ma nel rapporto tra le immagini; meglio, l’abisso tragico (lo “scandalo”) viene colto da chi accosta quelle due immagini, da chi ne legge le relazioni all’interno delle proprie scale di valori. Nota Daniela Sacco, citando Hans-Thies Lehmann, che
se prima di Aristotele il teatro in quanto rappresentazione visiva è il regno dell’accidentale, con la condanna platonica che ne consegue, “dopo Aristotele si attribuisce al logos drammatico l’instaurazione della logica alle spalle dell’illusione fallace. La drammaturgia fa quindi apparire le ‘leggi’ dietro le apparenze”.
(Sacco, cit., p. 192)
Poco più di un secolo dopo l’invenzione del cinema, e cinque secoli dopo la prima diffusione della stampa, la scena sta radicalmente cambiando. Un contadino medioevale vedeva una quarantina di immagini artificiali in un’intera vita. Oggi vediamo in media 600.000 immagini artificiali al giorno, 1200 ore di tv all’anno, ovvero circa 4 ore e 20 minuti di tv al giorno. Le statistiche sulle immagini caricate ogni minuto su Facebook (e Instagram, e Pinterest…) e sui video caricati ogni minuto su Youtube (e Vimeo, e… Youporn) devono essere aggiornate di continuo, visto che i numeri aumentano esponenzialmente. In rete, da qualche anno si sta sedimentando un immenso inconscio collettivo, dove pare regnare l’accidentale.
Se il tragico risiede nelle immagini (in quelle immagini), chi cerca di scoprire le “leggi dietro le apparenze”, chi tenta di mostrare la tragicità sottesa alla di figure nel “teatro della memoria” di internet, è forse l’incarnazione moderna di Eschilo…
Tag: mitoeteatro (18), Peter Sellars (7), Robert Wilson (14), tragedia (22)


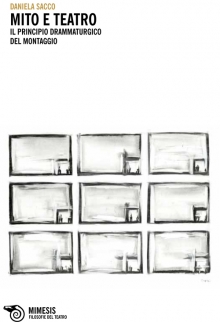





Scrivi un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.