Il senso profondo della tradizione e dell’innovazione
Mirella Schino e L'età dei maestri. Appia, Craig, Stanislavskij, Mejerchol’d, Copeau, Artaud e gli altri
Nella tradizione ebraica l’esegesi si gioca sugli spazi bianchi tra le lettere e le parole: il senso del testo, i suoi segreti si rivelano in questi spazi, aperti ad almeno settanta sensi diversi – e secondo il biblista Paolo De Benedetti c’è sempre comunque la possibilità di un settantunesimo senso…
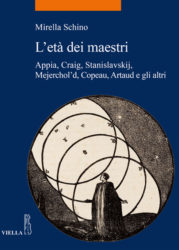 Questa apertura ermeneutica mi è venuta in mente leggendo l’ultimo saggio di Mirella Schino, L’età dei maestri, dedicato ai grandi maestri che hanno definitivamente rivoluzionato le idee e la pratica del teatro agli inizi del Novecento: Appia, Craig, Stanislavskij, Mejerchol’d, Copeau, Artaud e tanti altri, da Djagilev a Nižinskij, da Piscator a Reinhardt, da Brecht ai russi del dopo rivoluzione fino ai primi anni Trenta e all’ imposizione del realismo socialista, dogmatica e quasi sempre tragica: si leggano nel libro le pagine, strazianti, sulle torture inflitte a Mejerchol’d e a sua moglie, l’attrice Zinaida Rajch, e sulla loro atroce uccisione (vedi anche la recensione di ateatro al volume). Un periodo mitico per il teatro, paragonabile per importanza all’Atene di Pericle o alla fioritura della Commedia dell’Arte, ma ancor più significativo perché ha trasformato radicalmente l’idea e la natura stesse di “teatro”, la sua specificità di “arte vivente”. A questo periodo, e ai suoi protagonisti, Schino nel 2005 aveva già dedicato un altro studio, La nascita della regia teatrale (Laterza), sulle teorie, i metodi, le pratiche e l’eredità di quei maestri, che in Italia vengono di solito sbrigativamente sussunti sotto l’etichetta di “teatro di regia”.
Questa apertura ermeneutica mi è venuta in mente leggendo l’ultimo saggio di Mirella Schino, L’età dei maestri, dedicato ai grandi maestri che hanno definitivamente rivoluzionato le idee e la pratica del teatro agli inizi del Novecento: Appia, Craig, Stanislavskij, Mejerchol’d, Copeau, Artaud e tanti altri, da Djagilev a Nižinskij, da Piscator a Reinhardt, da Brecht ai russi del dopo rivoluzione fino ai primi anni Trenta e all’ imposizione del realismo socialista, dogmatica e quasi sempre tragica: si leggano nel libro le pagine, strazianti, sulle torture inflitte a Mejerchol’d e a sua moglie, l’attrice Zinaida Rajch, e sulla loro atroce uccisione (vedi anche la recensione di ateatro al volume). Un periodo mitico per il teatro, paragonabile per importanza all’Atene di Pericle o alla fioritura della Commedia dell’Arte, ma ancor più significativo perché ha trasformato radicalmente l’idea e la natura stesse di “teatro”, la sua specificità di “arte vivente”. A questo periodo, e ai suoi protagonisti, Schino nel 2005 aveva già dedicato un altro studio, La nascita della regia teatrale (Laterza), sulle teorie, i metodi, le pratiche e l’eredità di quei maestri, che in Italia vengono di solito sbrigativamente sussunti sotto l’etichetta di “teatro di regia”.
 Qui l’orizzonte si allarga, includendo un più vasto territorio culturale e di costume, un “territorio mentale comune” che si estende dai romanzi alla pedagogia a quell’area un po’ nebulosa che lambisce l’esoterismo e include personaggi importanti come Gurdijeff o esperienze come quella utopistica del Monte Verità, vicino ad Ascona, antesignana delle culture alternative del secondo Novecento e allora frequentata da Gropius e Thomas Mann, da Shaw e Jung, da Gide e Joyce, da Remarque e Paul Klee e, tra i tanti altri, pare anche da Lenin. L’intento, riuscito, è quello di trovare un senso in quello “spazio bianco” di cui sopra e che Schino chiama la “zona liquida del teatro”: non una scuola, non una metodologia o una didattica comuni, non presupposti e intenti simili ma l’intrecciarsi di quella che l’autrice, usando una metafora della tradizione buddhista, chiama la “rete di Indra” cioè una rete che si estende in ogni direzione e in cui ogni nodo è luminoso e riflette all’infinito la luce degli altri. Autonomia e interdipendenza; fuor di metafora: “la ricerca di ognuno si riflette e si illumina per la luce di quella degli altri” (p.283).
Qui l’orizzonte si allarga, includendo un più vasto territorio culturale e di costume, un “territorio mentale comune” che si estende dai romanzi alla pedagogia a quell’area un po’ nebulosa che lambisce l’esoterismo e include personaggi importanti come Gurdijeff o esperienze come quella utopistica del Monte Verità, vicino ad Ascona, antesignana delle culture alternative del secondo Novecento e allora frequentata da Gropius e Thomas Mann, da Shaw e Jung, da Gide e Joyce, da Remarque e Paul Klee e, tra i tanti altri, pare anche da Lenin. L’intento, riuscito, è quello di trovare un senso in quello “spazio bianco” di cui sopra e che Schino chiama la “zona liquida del teatro”: non una scuola, non una metodologia o una didattica comuni, non presupposti e intenti simili ma l’intrecciarsi di quella che l’autrice, usando una metafora della tradizione buddhista, chiama la “rete di Indra” cioè una rete che si estende in ogni direzione e in cui ogni nodo è luminoso e riflette all’infinito la luce degli altri. Autonomia e interdipendenza; fuor di metafora: “la ricerca di ognuno si riflette e si illumina per la luce di quella degli altri” (p.283).
Il discorso si snoda quindi lungo un percorso che include i maestri, le descrizioni (affascinanti, degne di Ripellino) degli spettacoli “storici” ricostruiti sulle testimonianze d’epoca, le biografie spesso drammatiche, gli scritti e le visioni, le esperienze, i contatti e i dissidi. Ma anche le innovazioni tecniche (la luce elettrica, a esempio, e il suo uso scenico e drammaturgico). E i cambiamenti istituzionali ed economici: nell’Ottocento le compagnie teatrali erano micro-società marginali, artigianali ed economicamente autosufficienti; nel Novecento il teatro diventa un’attività in senso lato sociale, richiede quindi un’organizzazione complessa e pubbliche sovvenzioni.

Antonin Artaud, Carte d’Identité
Ma quella che più interessa da un punto di vista storico e artistico è l’importanza assunta dalla danza: soprattutto dopo la conoscenza diretta di danzatori siamesi e balinesi, di sciamani siberiani, del teatro Nō e in genere dei teatri extraeuropei, la danza diventa fondamentale anche per la scena teatrale e per una nuova dinamica del corpo dell’attore. In quegli anni cambia il teatro, reale o solo pensato, e cambia anche la danza: non più svolazzare di veli e graziosi, fluttuanti volteggi, arabeschi tracciati nell’aria, ma aderenza al terreno, fisicità che manifesta l’anima, come sottolinea Jacques Rivière in una memorabile recensione di Le Sacre du printemps di Nižinskij. E Schino: “Il movimento, in Nižinskij, non è disegno, ma espressione di organicità, emanazione del corpo, è letteralmente legato a esso per non disperdersi nello spazio, è una danza interna, la pelle umana è il perimetro in cui muoversi” (p.191). Come non pensare all’indimenticabile Vollmond di Pina Bausch?
Ma non solo la Bausch ha le sue radici in quegli anni lontani. Senza Mejerchol’d o Appia o Copeau non avremmo avuto probabilmente l’Orlando Furioso o Il viaggio a Reims di Ronconi o 1789 di Ariane Mnouchkine o il Mahabharata di Peter Brook in una cava vicino ad Avignone o l’Amleto di Grüber alla Schaubühne o Fast/Foules e Les Troyennes di Thierry Salmon. E nemmeno le esperienze di teatro di gruppo a partire dagli anni Settanta del secolo scorso. O Pippo Delbono e Danio Manfredini. O la Compagnia della Fortezza, fondata e guidata da Armando Punzo con i detenuti di Volterra. O il Teatro delle Albe di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari. E sicuramente nemmeno Grotowski e l’Odin Teatret di Eugenio Barba.
Con quest’ultimo teatro Mirella Schino ha una frequentazione organica: suo è Il libro degli inventari (Bulzoni) sugli archivi dell’Odin. Non ultimo pregio de L’età dei maestri è anche la sotterranea corrente autobiografica che lo attraversa: espressa con elegante riserbo, percepibile nelle vibrazioni della scrittura e nella competenza di prima mano con cui un intellettuale partecipe rilegge la storia.
Tag: Antonin Artaud (16), Eugenio Barba (26), GordonCraigEdward (2), MejercholdVsevolod (5), nuovoteatro (38), StanislavskijKonstantin (4)




Scrivi un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.